Questo racconto fa parte delle Lettere di Martinius. Se non conosci la serie, comincia dal prologo.
Iacintus, 18 Agosto. A.D. 1800.
Martinius saluta i suoi Principi ed il suo Re.
Miei amati Farwic e Malwic,
Il mio viaggio mi ha finalmente portato ai margini delle terre ancora saldamente devote alla nostra Chiesa. Davanti a me, stanno i profondi boschi di Morea – la grande barriera naturale che separa la penisola di Teokonos dall’Iberia. Al di là, il Regno di Lozera e, più a settentrione, la Repubblica di Bastille. Il mio cuore tuttavia è sereno, fortificato dal tempo speso con Agustus e dall’accoglienza ricevuta qui a Iacintus. La mia permanenza qui è stata infatti inaspettatamente piacevole – non solo per la bellezza che anche questo luogo ci ha offerto, ma per alcuni fortuiti e gioiosi incontri. Lasciate dunque che vi racconti di questo piccolo pezzo della mia avventura.
Dovete sapere che Iacintus è al margine occidentale di Teokonos, separata da Agata per mezzo di una vasta e piuttosto aspra pianura. Si tratta di un territorio secco e brullo, interrotto solo occasionalmente da qualche fiumiciattolo minore attorno a cui si sviluppano piccole attività agricole. Per la maggior parte della sua estensione, la sola vegetazione a fusto è l’olivo selvatico. Molti giorni abbiamo cavalcato nell’arsura di Agosto, lungo strade per nulla protette da vegetazione. La notte, invece, è molto fredda, poiché il terreno conserva scarsamente il calore del giorno.
Si è trattato dunque di un viaggio impegnativo, che ci ha portati alla meta la notte del sedici Agosto, due giorni fa. I miei uomini erano piuttosto provati dal viaggio, ma non per questo meno rumorosi del solito. I più giovani della mia scorta canticchiavano canzoni campestri per tenersi in allerta, mentre io, assieme ai chierici, recitavo sottovoce le litanie – tutti eravamo, seppur stanchi, attenti ed irrequieti.
Fu così, poco dopo la morte del sole, con la pianura appena immersa nel buio della sera, che Iacintus ci apparve. La città emerse maestosa e bellissima dall’orizzonte, quasi d’improvviso, proiettando una luce fioca e calda di migliaia di torce verso il cielo. Una figlia di re, quando entra nella sala della festa nella sua veste nuziale, fa cadere il silenzio fra gli invitati: resi attoniti dalla sua bellezza, tacciono. Fu così per il mio equipaggio quando le mura di Iacintus ci apparvero sorgendo dalla notte.
La cinta è come una luminosa e bianca veste. Apparve imponente, eppure soave, nella sua pietra calcarea, candida e splendente, adornata da nastri colorati e pietre preziose. Si trattava in verità di lunghe edere fiorite che, assieme a papaveri e capperi, crescono ostinatamente aggrappate alle crepe della muratura. Quella colorita vegetazione risplendeva incredibilmente alla rossastra luce delle fiaccole, e ci appariva – complice forse la stanchezza – come il più fine degli ornamenti di donna.
Le mura sono poi interamente ricamate da continui bassorilievi. Dalla roccia si alzano le effigi di ciascuno dei padri di Iacintus, i grandi Re del passato. Nessuno, vedendo la finezza di questa veste, la sospetterebbe essere anche una formidabile armatura. Eppure Iacintus, fiera oltre che bella, resiste inviolata da secoli, bastione che fu decisivo in molte guerre del passato. Così entrammo silenziosamente e con una certa costernazione attraverso il grande portale orientale, sotto gli occhi, fissi nella pietra, dei sovrani della città.
Attraversammo le vie, più silenziose e discrete di quelle di Agata, accolti dai profumi della sera: carni e spezie, liquori odorosi, pani, stufati e numerose vivande locali, che dalle finestre delle abitazioni versavano i loro aromi nelle strade, risvegliando i miei uomini – e me stesso – dal torpore e dalla fatica del viaggio.
Arrivati alla sede patriarcale, ci fu permesso di rifocillarci. Fummo poi raggiunti da un buffo e rotondo segretario, il quale ci informò della temporanea assenza del patriarca, lontano dall’ufficio per questioni private: avremmo dovuto attendere sino ad oggi per conoscerlo, o per accedere ai documenti del patriarcato. In un primo momento mi rassegnai, e avvisai i miei assistenti che avrebbero avuto una giornata di licenza. Il fato però aveva per noi in serbo qualcosa di diverso – attraverso un incontro provvidenziale.
La mattina successiva inviai al mercato uno dei miei uomini per acquistare delle scorte indispensabili per la traversata della Morea. Si trattava di un certo Flavio, un ragazzotto di Lavinium piuttosto disinvolto, che fa parte della mia scorta armata.
Così, mentre compiva la sua commissione con dubbia diligenza, è accaduto che il giovane conoscesse una simpatica ragazza del posto, una donna curiosa e piuttosto indiscreta di nome Rachele. Quando Flavio le ha raccontato di come fosse in viaggio per una «importante missione per Lavinium», la donna si è tanto incuriosita che ha insistito perché partecipassimo al matrimonio della sorella, che per fortuita coincidenza si sarebbe tenuto lo stesso pomeriggio. Desiderava ardentemente che intrattenessimo gli ospiti con i racconti dei paesi che abbiamo visitato – e non temeva affatto di risultare inopportuna o insistente.
Come potete immaginare, ho cercato di rifiutare l’invito. Tuttavia, quando sono stato interpellato, la voce era ormai già stata diffusa tra il mio equipaggio. Forse per via delle difficoltà del viaggio, il desiderio dei miei uomini di partecipare ad una festa era tale che non ho potuto negare loro l’opportunità.
Così, nel pomeriggio, ci dirigemmo verso un villaggio contadino, a poco più di un’ora al trotto dalla città. Al centro del paesello vi era un piccolo tempietto, sul cui sagrato, una piccola piazzetta lastricata con grandi piastre in granito, era radunata una numerosa folla. Lì siamo stati accolti dai due sposi, con gioia, curiosità e non poca generosità, considerando che il mio equipaggio è composto di dodici soldati e di otto chierici.
Erano due giovani di nome Jacob e Myriam, e mi sembrarono subito semplici, belli, umili. Lo sposo era vestito di un fine ma modesto camice di lino, decorato da frange rosse e blu. La sposa, invece, era raccolta in una lunga tunica bianchissima, cinta con delle trecce di cuoio sopra le candide spalle. Aveva lunghi capelli neri, acconciati in una grande treccia e decorati da fiori di campo, che le incorniciavano un volto da bambina. Incrociando i suoi occhi, scuri quanto i capelli, mi parve per un istante di rivedere vostra madre.
I due mostrarono una curiosità non minore, seppur più discreta, di quella della sorella della sposa. Raccontai a loro ciò che ho raccontato a voi, enfatizzando forse qualche dettaglio sull’eroica traversata del Mare Medio o sul viaggio da Agata. Fu una conversazione piacevole e leggera, che molto mi rivelò sull’indole e sull’ospitalità dei Teokoniti.
Devo ammettere di aver condiviso volentieri la grande gioia degli sposi. L’inizio di una nuova vita, ciò che accade nella santa e definitiva unione che è il matrimonio, è spunto sempre nuovo e sempre felice. La costernazione per la perdita del pomeriggio così lasciò spazio ad una serena gioia. Tuttavia, non era ancora la fine delle sorprese riservatemi dalla fortuna.
Mentre ancora conversavo con i due, si avvicinò il chierico che avrebbe celebrato il matrimonio, e con sorpresa notai che indossava gli abiti patriarcali.
Fu così che conobbi Aurius, il patriarca di Iacintus. La sua assenza dalla capitale era dovuta proprio al matrimonio di Myriam, che appresi essere sua sorella, la quale aveva insistito affinché celebrasse lui il rito. Così fui invitato, come è costume quando si ospita un presbitero, a partecipare al servizio all’altare, mentre il Patriarca presiedette il rito.
La celebrazione fu solenne, gioiosa e commovente. Quando fu conclusa, fummo invitati ai festeggiamenti, che furono semplici, sobri e festosi come è tipico nelle campagne, ma non per questo mancarono di durare fino a tarda sera, e non mancò né il vino né il cibo.
Al centro del paese fu acceso un grande focolare, ed i giovani – inclusi diversi dei miei uomini – formarono un grande cerchio attorno ad esso e si lanciarono in una serie di danze e canti. Io mi sedetti un poco in disparte, su una panca appena esterna al luogo dei festeggiamenti, e stetti ad osservare – un po’ in apprensione per la sobrietà della mia scorta, ma invero anche piuttosto divertito.
Lì, fui raggiunto dal Patriarca Aurius, ed ebbi così l’occasione per un primo ed informale colloquio. Aurius è un uomo mite, discreto, e, in senso positivo, poco rimarchevole. Piuttosto giovane per il suo ruolo, ma non per questo meno saggio o erudito di quanto si conviene. Il suo aspetto fisico ne rappresenta bene l’indole: una costituzione da figlio delle campagne, ampia e solida, con un volto pulito e rassicurante.
Spiegai ad Aurius la natura dell’incarico affidatomi. Raggiunto un accordo sulle attività dei giorni seguenti, gli raccontai delle tappe iniziali del mio viaggio, così come delle prossime: raggiungere Bezier costeggiando a settentrione i Monti Beri, attraversando dunque gli impervi boschi di Morea. Di lì risalire verso Van e dunque Bastille, per raggiungere infine il nord.
Con grande gratitudine scoprii come il patriarca fosse ben aggiornato sulle vicende correnti. Aurius mi ha donato preziose informazioni – e, purtroppo, per nulla di buon augurio. A quanto pare, diversi viaggiatori hanno riportato problemi sulla rotta attraverso la Morea. Le foreste sono irrequiete e gli attacchi alle carovane, non solo da parte di malintenzionati, ma persino da gruppi di animali selvatici, sembrano essersi improvvisamente intensificati. Alcuni affermano di aver sentito uno strano vociare tra le fronde ombrose – sostengono che le bestie siano aizzate da un troll. Altri, addirittura, affermano che gli elfi – svaniti dal nostro mondo dopo la Seconda Guerra – siano riapparsi.
Racconti bizzarri e forse superstiziosi, a cui si uniscono però storie più concrete di nuove persecuzioni della nostra fede nei territori di Bastille. Lì, nonostante le tensioni della rivoluzione dello scorso ventennio si siano affievolite, il risentimento e l’odio ancora non hanno cessato di causare scontri e violenze. Il lavoro diplomatico e sociale del patriarca di Bastille non sembra bastato a ricucire ciò che è stato strappato, e la tensione sembra nuovamente in agguato.
Per quanto riguarda Iacintus, essa rimane ancora in una relativa pace, e ben ancorata alla nostra ortodossia. Suppongo Aurius abbia un certo merito – ma certamente la vicinanza al Mare Medio e dunque il frequente contatto con Lavinium, nonché l’influenza di Ilion, contribuiscono a questo.
I nostri discorsi furono interrotti da Myriam e Rachele, le quali pretendevano – con un certo imbarazzo da parte mia – di ballare con questo vecchio e con il loro fratello. Fummo così catapultati nella festa, con una certa indifferenza dei presenti verso il nostro rango – e con non poco divertimento dei miei uomini. Devo dire, figli miei, che anche un temperamento riflessivo e rigido come il mio fatica ad essere indifferente ad una così pulita ed innocente allegria, e non posso negare di avere goduto di questa inaspettata occasione.
In effetti, ho dovuto prendere atto che anche il mio animo, reso malinconico dalla lontananza dalla mia terra, aveva bisogno di questo genere di semplice felicità. Da quando sono partito, vi ho spesso scritto parlandovi del dolore, del sacrificio, dell’eroismo, della morte: dei patimenti di una vita che, nonostante tutte le fatiche, deve rimanere protesa alla Speranza finale.
Non vi ho però parlato della gioia: aspetto forse ben più essenziale della nostra esistenza. Di questo allora vorrei parlarvi. È giusto infatti che sappiate che sebbene la lotta sia destino di ogni uomo che in questo mondo può dirsi nobile di cuore, essa non è il nostro ultimo destino.
Lottare non è la ragione del nostro essere: è una necessità data dalla caduta di questo mondo, ove l’ingiustizia ed il male regnano sovrani, ed i giusti devono combattere perché la dignità dei deboli sia preservata.
Non dobbiamo però finire per credere di essere stati creati per questo. Un padre ed una madre concepiscono un figlio consapevoli che la sua crescita, la sua libertà, il suo scontrarsi col mondo, gli causeranno sofferenza. Ma quale genitore metterebbe al mondo un figlio desiderando per esso la sofferenza in sé?
Così anche il nostro Padre, consapevole di ciò che implica la nostra libertà, ci ha però creato non per la lotta, ma per la gioia. Siamo posti ad esistere per amare l’un l’altro, per condividere la bellezza di ciò che è stato creato, per lodare così il Signore: a questo tende la nostra esistenza, e a questo torneremo nell’ultimo giorno, quando ogni lacrima sarà asciugata e ogni ginocchio piegato.
Dunque non temete, figli miei, di godere del bene della vita. Non vi è nulla di male in questo, purché non vi distolga dal nostro obbiettivo finale. Io stesso, non infrequentemente, tendo a convincermi che le cose della nostra fede, assieme ai miei compiti attuali, siano le sole cose di cui dovrei interessarmi ed occuparmi. Ma questa disposizione d’animo finisce spesso per lasciarci esausti, consunti, ed infine invita l’accidia!
Del resto, quando guardo indietro ai miei eccessi di zelo, mi rendo conto che in essi non vi è nulla di coerente. Se infatti il nostro Signore è veramente degno di stima e lode, non devono forse esserlo anche le cose che Egli ha creato e ci ha donato? Che follia, allora, disprezzare il buon cibo, la buona musica, una buona storia! Così anche, e soprattutto, per le cose naturali: l’acqua che ristora ed il fuoco che riscalda, la luce del giorno ed il mistero della notte, e ogni altra cosa che riempie il nostro mondo di bellezza.
Imparate, giovani principi: allenate i vostri occhi ed i vostri cuori. Il gusto infatti non è un senso spontaneo, ma è figlio della gratitudine, e questo e quella sono come muscoli. Se li si esercita, se ci si sforza di apprezzare quotidianamente i doni della vita, di ammirare il buono ed il bello, tanto più trarremo gioia da essi. Se invece ci abbandoniamo alla malinconia, soffochiamo i nostri sensi con eccesso di rigore, e manchiamo di ringraziare per ogni giornata, allora finiremo per non notare più nulla di ciò che dovrebbe sostenere ed alimentare il nostro spirito.
Siete retti e maturi abbastanza per capire che questo non deve trasformarsi in un assecondarsi smodato, in un estetismo senza sostanza. Del resto, il massimo modo di esprimere la gratitudine per qualcosa, è condividerla: assicurarsi che ne possa godere anche il prossimo. Voi avrete la responsabilità che così sia per la nostra nazione.
Dunque banchetterete quando banchetterà il popolo, digiunerete quando il raccolto sarà magro, sarete i primi a gioire nella prosperità, ed i primi a sacrificarvi nella carestia e nel conflitto. Perdonate però il cianciare di un vecchio maestro: ciò che ricordo a voi, ricordo anche a me stesso; poiché anche io, nel piccolo del mio equipaggio, devo tenere conto di queste cose.
Ciò detto, miei giovani, vi saluto. Presto concluderò il mio lavoro qui a Iacintus e dovrò affrontare il passaggio attraverso la Morea, per raggiungere Bezier, dove spero di ricevere vostre. Se sarò fortunato, il viaggio durerà tre settimane. Da lì continueremo a nord, entrando finalmente nei territori della Repubblica.
Confesso di essere stato appesantito da questa incombenza. Molti fratelli del mio ordine furono vittima di gravi persecuzioni durante il cambio di regime, e nonostante gli sforzi diplomatici di Lavinium e dei regni fedeli all’Arso, la situazione è lungi dall’essere stabile. Non so che accoglienza aspetti me o i miei uomini, e non amo l’idea di avere a che fare con quei lapsi che giurarono fedeltà alla Repubblica, inquinando il loro ministero.
In tutto questo, i miei uomini non paiono turbati: a molto ha giovato loro la provvidenza che ci ha concesso di partecipare ad una così gioiosa evenienza; ed in piena sincerità, io stesso ne ho tratto un certo sostegno.
Dunque vi saluto! Con la speranza di raggiungere Bezier entro la seconda settimana di settembre, e di ricevere lì vostre notizie. Da lì raggiungerò Van entro la fine del mese; infine, Bastille.
Tengo voi, figli, e Re Arwic, sempre nel mio cuore.
Con amore profondo,
Martinius Wyss.

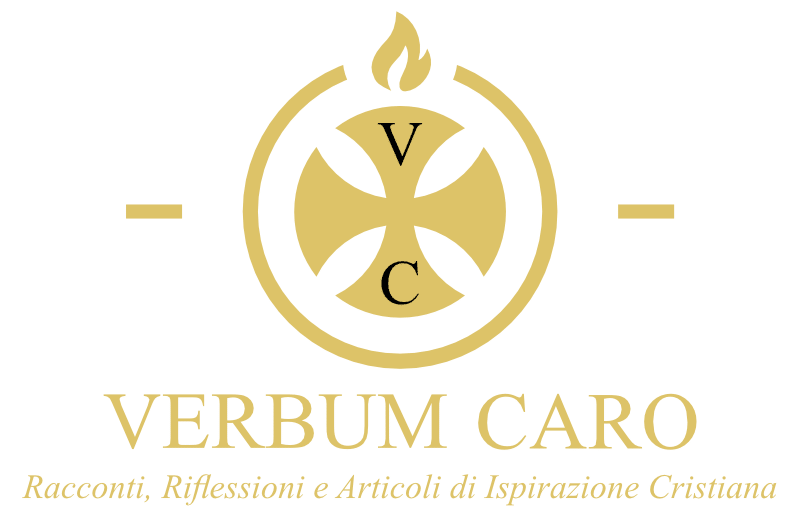

Lascia un commento