Tra la settimana scorsa e la corrente, sul blog Come se non del teologo Andrea Grillo, è comparsa una serie di articoli piuttosto particolari.
I testi trattano del giovane Beato Carlo Acutis e, contestualmente, della teologia eucaristica della Chiesa. La maniera in cui si parla di questi temi è assai improvvida, specie considerando che la pubblicazione è avvenuta proprio a cavallo dell’occasione della solennità del Corpus Domini.
Il linguaggio degli articoli, infatti, è piuttosto perentorio, crudo e abrasivo. Molti fedeli hanno percepito nelle parole del teologo un attacco diretto all’amatissimo Santo dei Giovani, prossimo alla canonizzazione. Inoltre, gli articoli sono stati impugnati da vari commentatori e accusati di contenere gravi errori dottrinali; e così attorno ai testi si è alzato un putiferio.
Grillo, per parte sua, ha rigettato indirettamente le accuse, pubblicando una lettera di un altro teologo, il quale cerca di giustificare gli articoli menzionati e proteggere il collega dalle critiche.
Tuttavia, se esiste un significato oggettivo nel linguaggio, è molto difficile sostenere che le critiche ricevute dal teologo siano infondate. Per dimostrare quanto dico, ed invitare nuovamente il teologo ad un chiarimento – ed auspicherei, anche delle scuse – ho deciso di commentare passo per passo i testi.
Il primo di questi appare sul blog del teologo il 17 giugno. Comunque la si veda, il pezzo è acerbamente polemico, e lo è sin dal titolo: Il giovane Carlo Acutis e la maleducazione eucaristica.
Un secondo articolo, intitolato Il linguaggio della santità: parole e immagini su e di Carlo Acutis appare proprio in occasione della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Contrariamente a quanto il titolo potrebbe far sperare, il testo non ha affatto un impianto più caritatevole e pastorale del precedente.
Andiamo dunque ad approfondire il pensiero di Andrea Grillo, partendo dal primo dei due scritti citati.
Il Primo Articolo
da Il giovane Carlo Acutis e la maleducazione eucaristica
Come è possibile che un giovane beato possa comunicare una teologia eucaristica così vecchia, così pesante, ossessiva, concentrata sull’inessenziale e tanto trascurata invece sulle cose decisive? […] Chi lo ha assecondato in questo interesse per i “miracoli”, trascurando il vero miracolo?
L’articolo inizia con una serie di domande pesanti nella retorica e sinceramente preoccupanti nei contenuti. Il teologo lamenta la «vecchiezza, pesantezza e ossessività» della teologia eucaristica espressa dalla sensibilità del Beato Carlo Acutis. Come dicevo, se le parole hanno un senso oggettivo, già in questo attacco si sta dipingendo il ragazzo come vittima di una ossessione; un fanciullo inconsapevole che non avrebbe dovuto essere «assecondato» ma piuttosto corretto.
Al di là dell’attacco a Carlo, c’è da notare una frase chiave in questo incipit, e cioè: «concentrata sull’inessenziale». Cosa sia questo «inessenziale» su cui si concentra il Beato, non è chiarito dall’attacco dell’articolo. Tuttavia, nel lettore attento, sin dalle prime righe non può non innescarsi la preoccupazione che per il teologo ciò che è «inessenziale» sia la vera presenza di Cristo nell’Eucaristia.
Cioè la realtà totale, non solo ideale o spirituale, ma anche sostanziale – e di conseguenza, misteriosa – della trasformazione delle specie eucaristiche nel corpo di Cristo. Cioè il centro dell’intero pensiero Cattolico-Ortodosso, ed il fondamentale punto di distinzione rispetto al pensiero protestante.
Continuando, scopriamo che l’insofferenza del teologo per l’approccio del giovane Acutis all’eucaristia è tale da spingerlo a chiedersi chi abbia assecondato l’interesse di Carlo per i miracoli. Suggerisce, senza preoccuparsi di dimostrarlo, che questa fascinazione porti a trascurare “il vero miracolo” dell’eucaristia. Quale sia, nel suo pensiero, il vero miracolo, lo vedremo poi.
Per quanto letto, dovrebbero comunque sorgere già alcune domande. È davvero legittimo che un teologo si arroghi il diritto di stabilire, a dispetto dell’autorevole processo della Chiesa, quali miracoli siano «veri» e quali non lo siano?
Grillo sembra inoltre suggerire che l’interesse dei giovani per la dimensione sovrannaturale della fede sia qualcosa da stroncare, ma perché mai dovrebbe esserlo? Non è forse una risorsa fondamentale, in un mondo dove regna un cieco ed ottuso razionalismo?
L’articolo poi continua con una serie di critiche più o meno destrutturate e retoriche ad alcuni chierici – tra cui un cardinale – che hanno commentato la mostra sui miracoli eucaristici del Beato. Le prime due critiche non portano, in verità, granché da commentare.
Presenza Reale: Dogma immutato
Il «colpo di scena» arriva nel terzo attacco, volto a Padre Roberto Coggi, dove troviamo una riflessione davvero grave e significativa:
da Il giovane Carlo Acutis e la maleducazione eucaristica
Per finire, il testo di Roberto Coggi, mette la ciliegina sulla torta. Proprio all’inizio della sua Introduzione egli scrive:“Conosciamo la dottrina cattolica riguardo alla presenza reale. Con le parole della consacrazione: «Questo è il mio Corpo», «Questo è il mio Sangue», la sostanza del pane diventa il Corpo di Cristo, e la sostanza del vino il suo Sangue.”
Forse qualcuno avrebbe dovuto aggiornare il padre domenicano sul fatto che la riforma del Messale del 1970 ha cambiato quella che lui è convinto sia “dottrina cattolica”, ma è sola (sic.) la sua fantasia.
A meno di non fraintendere le parole del teologo, sembrerebbe che stia sostenendo che sia ormai superata l’idea secondo cui la sostanza del pane e del vino muti nel vero Corpo e Sangue di Cristo con le parole della consacrazione.
Il testo non sembrerebbe per la verità in alcun modo ambiguo. L’unica ragione per convincerci di star fraintendendo, è come la asserzione sia così palesemente falsa da impedirci di credere che il teologo ne sia davvero convinto.
Infatti, è sufficiente aprire il catechismo per leggere confermata con assoluta chiarezza la teologia di Coggi:
CCC 1376 Il Concilio di Trento riassume la fede cattolica dichiarando: «Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha detto che ciò che offriva sotto la specie del pane era veramente il suo Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e questo santo Concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo conveniente e appropriato è chiamata dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione».
CCC 1377 La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della consacrazione e continua finché sussistono le specie eucaristiche. Cristo è tutto e integro presente in ciascuna specie e in ciascuna sua parte; perciò la frazione del pane non divide Cristo.
Se non fosse un fraintendimento – e non riesco a vedere come possa esserlo – la dichiarazione di Grillo sarebbe davvero molto grave, e dovrebbe essere rigettata con assoluta precisione e determinazione.
Dichiarare che il Concilio Vaticano II abbia “cambiato la dottrina cattolica”, specie rispetto ad uno dei dogmi definiti con maggiore autorità magisteriale in assoluto, è una affermazione sensazionale, che, se vera, invaliderebbe l’intero sistema cattolico, minando l’infallibilità della Tradizione. Per altro, è una affermazione del tutto infondata, ed in effetti il teologo non cita nessun documento conciliare o del magistero postconciliare.
È inoltre piuttosto sorprendente che questo cambio epocale sia attribuito dal Grillo alla riforma del messale. Un dogma fondamentale della Chiesa Cattolica sarebbe stato, secondo il teologo, superato da una pronunciazione in materia liturgica, che per definizione non è sede di affermazione dogmatica. Una dichiarazione sconcertante per un uomo di simile calibro accademico.
Ciò senza contare che la Sacrosantum Concilium, la costituzione liturgica del Concilio Vaticano II, che certamente non si occupa di definizioni dogmatiche, afferma comunque la piena continuità con la tradizione ecclesiale, sia pure indirettamente. Ecco ad esempio al c. 55:
55 Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa, nella quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo sacrificio. Fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, […]
La tesi che stiamo discutendo non è dunque in alcun modo patrimonio del Concilio Vaticano II.
Ci troviamo invece davanti al solito pesante, vecchio, ossessivo – e aggiungo ideologico – appello ad un fantomatico «spirito del concilio». Uno spirito inesistente nei documenti conciliari e che sembra curiosamente dire tutto il contrario di ciò che ha detto nei secoli lo Spirito Santo.
Insomma, scritta da un teologo a cui è data la responsabilità di insegnare nelle università pontificie, questa affermazione è davvero difficile da accettare.
I Miracoli e la Comunione
A questo punto, il ragionamento di Grillo diventa di ancor più difficile comprensione. Si arriva a sostenere che il tomismo «neghi ogni possibilità di “miracolo” [eucaristico]»; ancora una volta, senza produrre alcuna citazione. In verità, San Tommaso d’Acquino ammette eccome i miracoli eucaristici. Nella Somma il Dottore spiega che, pur non essendo simili manifestazioni tangibili necessarie alla verità del sacramento eucaristico, esse non lo invalidano, ma piuttosto ne indicano la verità.
Summa Theologiae, III, q. 76, a. 8
[…] a volte si vede miracolosamente in questo sacramento della carne, o del sangue, o addirittura un bambino. […] Dobbiamo perciò concludere che, restando le stesse dimensioni di prima, si compiono miracolosamente delle mutazioni negli altri accidenti, p. es., nella figura, nel colore e in altri simili, così che appaia della carne, o del sangue, oppure un bambino. E questo non è un inganno: perché come si è detto sopra, avviene “per indicare una verità”, cioè per dimostrare con queste miracolose apparizioni che in questo sacramento è veramente presente il corpo e il sangue di Cristo.
D’altra parte, se anche la asserzione di Grillo sull’Acquinate fosse corretta, va comunque ribadito che non può essere certo il pensiero di un Santo Teologo a limitare Dio Onnipotente. Ancora meno può farlo il pensiero di un teologo non santo.
Infine, il teologo conclude un ragionamento che è davvero impossibile, per quanto spirito di carità vi si metta, non leggere come un grottesco con attacco ai danni del Beato Carlo Acutis:
da Il giovane Carlo Acutis e la maleducazione eucaristica
Che questo tratto sia portato come “argomento” a favore della santità di Carlo è davvero sorprendente. Dovremmo forse arrivare a dire: lo riconosciamo santo “nonostante la sua fissazione distorta per i miracoli eucaristici”?
La trattazione si chiude con tono esortativo. Grillo indica nella comunione ecclesiale «l’unico vero miracolo eucaristico». Purtroppo, appena il rigo successivo a questa dichiarazione, il teologo attacca a tappeto e con assoluta disinvoltura tutti i cristiani che condividono la sensibilità eucaristica di Carlo, accusandoli di avere «un cuore arido».
Mi chiedo, è questa una buona dimostrazione di «comunione ecclesiale»?
Per quanto concerne il merito della sua teoria, Grillo non si preoccupa di dimostrare come una forte attenzione all’oggettività delle specie eucaristiche si dovrebbe porre in contrasto con una forte esperienza soggettiva della comunione eucaristica. Lo dà per scontato, laddove invece è ragionevole sostenere che sia vero proprio il contrario: solo attorno al Vero Corpo e al Vero Sangue di Cristo, si può dare una vera comunione ecclesiale.
Questo perché la comunione ecclesiale non è la gioia della buona tavola. È l’integrazione mistica e profonda del corpo dei fedeli nell’amore. Un amore inteso nel senso di agape, e cioè il volere profondamente il Bene dell’altro; anche di quell’altro per cui non si nutre alcun genere di simpatia.
Chi conosce gli uomini, sa che questo non è umano. Si può realizzare solo attorno a quel pane che trascende il tempo, trascende lo spazio, supera le nostre miserie, vince le nostre costernazioni, abbatte le nostre invidie. Un pane che appare pane, ma che è sostanzialmente Amore.
Questo il Beato Carlo Acutis lo aveva capito molto bene, ed è per questo che a breve sarà Santo.
Pochi giorni più tardi, comunque, il teologo produce un altro articolo, sinceramente ancora più difficile da difendere. Diamoci una occhiata.
Il Secondo Articolo
Il secondo articolo si apre con un bel tono intellettuale: una citazione sottile al teologo gesuita O’Malley, una breve e languida riflessione sul Concilio Vaticano II. Il volo, purtroppo, dura poco.
Bastano poche righe per arrivare a nuove acerbe critiche. Le prime, alla Congregazione per le Cause dei Santi, rea di utilizzare un linguaggio «caricaturale e distorto» per parlare del Beato Carlo Acutis. Segue immediatamente un nuovo attacco ad alcune parole del Beato, per cui si contesta una «spiritualità imbarazzante», un uso delle parole «non formato», e «una opinione censurabile».
Di fronte a simili parole, come si può negare che si stia trattando un Santo in fieris con incredibile supponenza e paternalismo?
L’unica concessione che è possibile fare al teologo, è ammettere che la frase contestata al Beato è effettivamente pesante per la sensibilità moderna.
Offro tutte le sofferenze che dovrò patire, al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il Purgatorio e andare dritto in Paradiso. – Beato Carlo Acutis
Grillo non ha torto nel ricordare che Dio non utilizza le nostre sofferenze in vita in maniera «transazionale». Questa è una coscienza che la Chiesa ha ormai maturato e sedimentato.
Certamente, si tratta di una frase contestabile da un punto di vista di rigore teologico. Ma l’approccio alla dichiarazione del Beato non può prescindere dal considerare il soggetto che la ha pronunciata, nel contesto in cui la ha pronunciata.
Carlo Acutis pronuncia questa frase di fronte ad una diagnosi di leucemia acuta, una condanna di morte certa, imminente ed accompagnata da gravissimi dolori. Non lo fa pigramente adagiato su qualche molle salotto di una facoltà teologica. In questo contesto, la frase di Acutis diventa una reazione eroica; una glorificazione del dolore sopportato con dignità.
Carlo non farà il purgatorio. Questa dichiarazione è solo apparentemente folkloristica, superficiale; in realtà ha dentro molto. Ha dentro la verità che, sopportando con dignità il dramma della vita, Carlo fu già parte in terra della ecclesia patiens: la chiesa sofferente, che nella prova della purificazione si prepara al trionfo celeste.
La sua testimonianza aiuta noi, che siamo ancora nella lotta contro le nostre infermità spirituali, ad essere ecclesia militans, pellegrini terreni uniti nel combattimento contro il male; anzitutto quello che abbiamo dentro.
E sì, la sua è una frase che, contrariamente a quanto sostiene il teologo, ci fa bene sentire. Una frase che è come una sberla rinsavente per un’epoca in cui i giovani sembrano non aver più la forza di affrontare nemmeno la quotidianità della vita.
Santa Ingenuità e Finta Saggezza
Il teologo continua poi commentando un estratto dell’agiografia di Carlo con queste parole:
da Il linguaggio della santità: parole e immagini su e di Carlo Acutis
Alcune questioni saltano subito all’occhio: è “apostolo dell’eucaristia” un ragazzino che imita i pastorelli di Fatima e colleziona immagini di tutti i miracoli eucaristici? Piuttosto che educarlo, si è preferito lasciarlo fare? Oppure si cerca, attraverso di lui, di rendere infantile tutta la chiesa, proponendo a tutti come modello un ragazzo che non è stato guidato dalla sapienza che avrebbero dovuto avere con lui gli adulti (laici e chierici) che stavano intorno a lui?
Mi chiedo, come di può negare che vi sia un trattamento del tutto inadeguato nei confronti del Beato, ridotto ad ragazzino senza cognizione di causa o educazione nella fede?
A cosa si sarebbe dovuto «educare» il giovane Acutis, secondo il dottore? Allo scetticismo materialista-scientifico? È davvero ciò di cui c’è bisogno in questo clima sociale e culturale?
Nel merito, comunque, la riflessione non spiega come dovrebbe essere nella sua visione una Chiesa «non infantile», o quale sapienza avrebbero dovuto usare gli adulti con il Beato.
In effetti, da questo punto dell’articolo, Grillo continuerà ad asserire molto, ma ad argomentare molto poco. Asserzione per asserzione, allora, ritengo che questi passaggi biblici rispondano adeguatamente al ragionamento del teologo sulla «infantilità» del Beato e la propria supposta «sapienza» che ad essa si contrappone:
Matteo 18:3-4
3 e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli.Romani 1:20-22
20 […] Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa 21 perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. 22 Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti.
Continuando, Grillo accusa la spiritualità eucaristica di Carlo di essere «borghese»: una asserzione così palesemente insensata, ideologica e fuori tempo, da non poter suscitare altro che ilarità in qualsiasi lettore che non si trovi proprio all’interno della categoria descritta nel passaggio sopra citato della Lettera ai Romani.
Viviamo in un mondo interamente secolarizzato, votato al consumismo, all’individualismo economico, morale e relazionale più estremo, al relativismo più mediocre e all’ignavia più completa; intriso di materialismo opportunista e aridità spirituale. In un simile mondo, definire la radicalità eucaristica di Acutis «borghese» è semplicemente ossimorico, paradossale, incomprensibile.
Nel paragrafo successivo, si continua in quello che si manifesta a questo punto come un assurdo tentativo di screditare Beato. Ciò a prescindere dalle intenzioni del teologo, che continuiamo a sperare in buona fede: le parole hanno purtroppo un peso ed un significato intrinseco.
Si riporta infatti alcune frasi a lui attribuite, implicando, senza spiegare perché, che siano frasi poco consone ad un ragazzo cristiano del terzo millennio. La prima critica mossa esplicitamente, poi, è mancanza di originalità: le sue frasi calcherebbero troppo fortemente la tradizione omiletica o la Scrittura.
Si tratta di un’altra asserzione paradossale. La Chiesa non è un istituto votato alla ricerca e all’innovazione, bensì è il custode di una Verità già rivelata nella sua completezza. Una verità che può essere al più compresa maggiormente, sviluppata o esposta in maniera più adeguata ai tempi, ma mai cambiata o «innovata». Dunque l’originalità non è assolutamente un parametro di giudizio per la bontà teologica.
Una critica di questo genere sarebbe comprensibile da un teologo del mondo evangelico, ma certamente non da un Cattolico. Reinterpretare e riproporre incessantemente la Tradizione Sacra non è forse parte fondante del compito della Chiesa? Purtroppo, il valore degli argomenti proposti non è destinato a migliorare. Infatti, i passaggi successivi sembrano non solo ignorare la tradizione ecclesiale, ma persino la Sacra Scrittura.
Ci sono due frasi di Acutis, infatti, che infastidiscono particolarmente Grillo pur essendo assolutamente coerenti con l’insegnamento biblico.
Non io, ma Dio
La prima è «Non io, ma Dio» e secondo il teologo porrebbe un ingiusto contrasto tra l’amore per sé stessi e l’amore per Dio. Come in precedenza, Grillo non argomenta, ma si limita ad asserire le sue posizioni, e sinceramente continua a trasparire un fare paternalistico e supponente. Secondo il suo pensiero, nella frase di Carlo vi sarebbe «una ingenuità che si capisce in un 14enne», ma che gli adulti che l’hanno formato avrebbero correggere.
Eppure l’ingenuità di Carlo è la stessa santa ingenuità di San Paolo e San Giovanni Battista:
Giovanni 3:27-30
27 Giovanni rispose: “[…] 28 Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. 29 Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. 30 Lui deve crescere; io, invece, diminuire“.Galati 2:19-20
19 In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, 20 e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Si tratta dell’ingenuità di chi sa perdersi nelle parole e nell’esempio del Maestro, dimenticando sé stesso, e lasciando che Dio viva per mezzo della propria presenza terrena. Questo non annulla la gratificazione dell’Io, anzi: San Giovanni ci dice che è questo che rende piena la sua gioia. Del resto, questo insegnamento è dato dal Cristo stesso:
Marco 8:34-35
34 Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà.
Dunque se siamo con Cristo, siamo ancora una volta dalla parte di Acutis. Non io, ma Dio: verità semplice ed essenziale in un epoca di individualismo senza freni. Una verità specialmente importante per i teologi, che, se incauti, rischiano quotidianamente di farsi accecare dall’hubris, e trasformare Dio in un mezzo per procurarsi piacere intellettuale e accrescere il proprio prestigio.
Nasciamo tutti originali
La seconda frase che disturba il teologo è «Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie». In questo caso, Grillo avanza una proposta inversa: saremmo fotocopie alla nascita, e tramite la vita avremmo la possibilità di renderci originali. Ad una scarna argomentazione, fa subito seguire una nuova critica, in linea con il linguaggio utilizzato precedentemente, ai danni del Beato o dei suoi interpreti, o di entrambi:
da Il linguaggio della santità: parole e immagini su e di Carlo Acutis
Anche qui, una frase troppo unilaterale, isolata, perde di vista una sapienza più completa e più santa. Non siamo già originali, ma lo diventiamo nelle relazioni, con Dio e con il prossimo. Qui, come è evidente, le parole di Carlo, almeno quelle scelte come più significative, restano all’interno di una comprensione sia della fede, sia del culto, che appare profondamente limitata.
È significativo, osservando i passaggi che ho evidenziato in corsivo, notare come il teologo consideri la propria opinione non semplicemente più savia, ma persino più santa di quella di un ragazzo in via di canonizzazione. Le parole di Acutis si collocano in una «comprensione profondamente limitata sia del culto che della fede», sottintendendo che la comprensione del teologo sarebbe più invece più matura.
L’esposizione del ragionamento, come detto, non lascia trasparire chiaramente se la bordata sia rivolta al giovane o ad i curatori della sua agiografia, ma, in ogni caso, si tratta comunque di parole difficilmente difendibili.
Non solo: sono parole appartenenti ad un pensiero che non corrisponde affatto alla scrittura. Nell’idea che gli uomini «non siano già originali dalla nascita» appare infatti una «comprensione della fede profondamente limitata», che non tiene conto, per esempio, di testi come il Salmo 139:
Salmo 139:13-16
13 Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.14 Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.15 Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.16 Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.
Il medesimo concetto è ribadito in Geremia 1:5, o Efesini 2:10, così come nel Libro di Isaia. La Bibbia non si stanca mai di ripetere come Dio abbia un piano unico ed intimo per ciascuno di noi, sin da prima della nostra nascita.
Alla luce della pressione omologatrice della società moderna, i cui effetti sono evidenti a chiunque non desideri attivamente distogliere lo sguardo, le parole del Beato Carlo Acutis appaiono più che condivisibili, e risuonano armoniosamente con la Sacra Scrittura.
L’ultima parte dell’articolo non ha contenuti significativi o meritevoli di particolare commento. Si tratta di una polemica, comprensibile ma francamente piuttosto intellettualista, verso le espressioni di pietà popolare attorno al corpo del Beato.
La Radice del Problema
È difficile pensare che Andrea Grillo abbia un qualche personale motivo di astio verso un giovane Beato. D’altra parte, nonostante i tentativi d’area di difendere i suoi articoli, il linguaggio irriverente e crudo utilizzato nei confronti del giovane è difficilmente equivocabile. Ma, allora, cosa può averlo spinto a vergare due articoli del genere?
Il primo dei due articoli, ci consente di avere un legittimo sospetto. Il problema di Grillo con Acutis potrebbe non essere altro che la sua potente testimonianza eucaristica: una testimonianza che avvalora e propone con potenza al mondo e ai giovani la verità della presenza di Cristo nella eucaristia.
E perché – potreste chiedere – Grillo dovrebbe essere disturbato da una simile testimonianza? Un terzo articolo, comparso il 23 giugno con il titolo di Specie e sostanza: e le azioni rituali? Riconoscere il Signore nella frazione del pane, ci può aiutare a confermare quale sia la radice del problema, e legittimare ulteriormente i sospetti che il primo attacco ad Acutis ha sollevato.
L’articolo è piuttosto tecnico, e può facilmente confondere le idee al lettore non allenato. Analizziamolo con calma.
Ciò che è Sostanziale, Ciò che è Accidentale
Nella prima parte del testo il teologo ragiona sulle specie eucaristiche e sostiene che forse dovremmo chiamare il pane ed il vino accidenti, anziché specie.
Parentesi Aristotelica
Nella metafisica di Aristotele, che San Tommaso d’Acquino utilizzerà per descrivere il mutamento delle specie eucaristiche nel Corpo e nel Sangue di Cristo, si distingue tra sostanza e accidenti.
La sostanza delle cose è la loro realtà necessaria, ontologica «dell’oggetto in sé», profonda. Non ha niente a che vedere con la sostanza in senso chimico, ma con la verità dell’essere di un oggetto. È più vero affermare che il pane sia pane, o che sia una miscela di glucidi, acqua e fibre? Aristotele direbbe la prima: la seconda è una accidente.
Gli accidenti, appunto, sono le caratteristiche contingenti, non necessarie alla identificazione profonda della realtà di un oggetto. Forma, dimensione, colore, assenza o completezza delle parti, e persino la composizione chimica, sono caratteristiche accidentali.
Il ragionamento del teologo non sta in piedi in termini aristotelici, perché pane e vino sono sostanze, non accidenti. L’accidente è semmai la forma, il colore, la composizione chimica, il gusto di questi. Il termine specie indica proprio gli accidenti del pane e del vino. Quel del è importante: sarebbe improprio e fonte di confusione chiamare accidenti direttamente il pane ed il vino.
Si noti che nel pensiero aristotelico non appare il termine specie, perché in esso non poteva darsi la totale separazione di una sostanza dai suoi accidenti: ciò che avviene invece nella trasformazione eucaristica.
Nella transustanziazione, gli accidenti permangono, ma la sostanza del pane e del vino cessa integralmente di esistere, sostituita dalla sostanza del Corpo e del Sangue di Cristo. È per questa ragione che chiamiamo il pane ed il vino specie: perché esse non sono che una apparenza che non esiste più dall’istante della consacrazione. Rimangono solo le loro proprietà accidentali.
La maggior parte dei lettori si starà giustamente chiedendo cosa ci sia di così importante in questo ragionamento. La risposta è che il Grillo, in questo girotondo intellettuale, sta cercando di reintrodurre il pane ed il vino come esistenze permanenti in qualche modo dopo la consacrazione.
Il perché ci può essere suggerito dal paragrafo successivo, che è il vero corpo dell’articolo.
Il Rito o le Specie?
da Specie e sostanza: e le azioni rituali? Riconoscere il Signore nella frazione del pane
L’azione rituale come linguaggio della memoria
Per questo un ampliamento della esperienza può passare anche attraverso la correzione di una espressione troppo semplice, troppo astratta, di cui facciamo uso in modo troppo disinvolto, come accade al termine “specie”. Allo stesso modo, anche la “sostanza” viene arricchita per il fatto di essere in relazione non soltanto con una “apparenza”, ma con un “accidente”, un “accadere” che nella sua contingenza costituisce un elemento insuperabile per comprendere e vivere il senso teologico del sacramento.
La parola “specie” induce solo a guardare e facilita la separazione della eucaristia in due parti scollegate: il sacramento, come sostanza, e il suo uso relativamente autonomo. D’altra parte, come abbiamo già scoperto, proprio considerando la nuova formula introdotta dalla riforma liturgica, è evidente che la espressione “questo è” non sia riferita ad un “oggetto”, ma ad una “azione”: tutto ciò che Gesù ha fatto nell’ultima cena (prendere il pane, rendere grazie, spezzare, dare e dire) costituisce il referente di quella identificazione con il suo corpo e il suo sangue. Per questo la memoria di lui non è soltanto nelle “parole sul pane e sul calice”, ma anzitutto nelle “azioni col pane e con il calice”, che trovano la loro forma più compiuta in tutta la sequenza rituale della messa: ossia, dopo la liturgia della parola, essa inizia dalla “presentazione dei doni” (“prese”), prosegue nella “preghiera eucaristica” (“rese grazie”), nella frazione del pane (“lo spezzò”), nel rito di comunione (“lo diede ai suoi discepoli”) e nelle parole che il ministro della comunione dice consegnando la particola (“Corpo di Cristo”).
Tutta questa sequenza è il “questo” che viene identificato come corpo e sangue del Signore.
Traducendo dall’accademico, Grillo sostiene che il Cristo, dicendo «questo è il mio Corpo» e «questo è il mio Sangue» non stesse indicando al pane ed al vino, ma all’interezza del rito dell’ultima cena.
Sebbene sia grammaticalmente accettabile, il contesto narrativo non permette una simile interpretazione. Cristo pronuncia «questo» (Τοῦτο) nel momento della consegna del pane. Poco dopo, consegnando il vino, nuovamente pronuncia «questo». Nella santificazione del vino non è presente la stessa descrizione della dinamica eucaristica, e dunque «questo» non può riferirsi ad altro che alla coppa – o al suo contenuto, per sineddoche.
Perché frazionare la consacrazione in due dichiarazioni, se fosse la consacrazione stessa nella sua interezza ad essere il Corpo del Signore?
Di fatti, l’asserzione del teologo è in piena collisione con tutta la Tradizione interpretativa Cattolica. Abbiamo già citato il Catechismo, ma ora aggiungiamo anche una citazione inequivocabile a Sant’Ambrogio, Padre della Chiesa che scrive già nel IV secolo: ben prima del Tomismo.
Liber De Sacramentis, IV
14 Tu forse dici: «È il mio pane abituale!». Ma questo pane è pane prima delle parole sacramentali; quando sopraggiunge la consacrazione, da pane diventa carne di Cristo. Dimostriamo dunque questo. Come può ciò che è pane essere il corpo di Cristo? La consacrazione dunque, con quali parole avviene e con il discorso di chi? Del Signore Gesù.
[…]
19 … Hai dunque imparato che, da pane [che era], diviene il corpo di Cristo. E che dire del vino, dell’acqua? Viene messo nel calice, ma diventa sangue attraverso la consacrazione celeste.
È chiaro che Sant’Ambrogio identifica molto precisamente il pane ed il vino come oggetto della consacrazione e trasformazione eucaristica. Si potrebbero citare una pletora di altri padri! Nessuno membro della Chiesa però, se non in tempi estremamente recenti, ha proposto l’identificazione del Corpo del Signore con l’interezza del rito eucaristico.
Con tutto il rispetto per il teologo, dunque, alla sua dichiarazione «è evidente che la espressione “questo è” non sia riferita ad un “oggetto”, ma ad una “azione”» dobbiamo necessariamente rispondere: non è evidente affatto. Si tratta della sua personale interpretazione. Al netto di aver inteso male le sue riflessioni, si tratta inoltre di una interpretazione del tutto eterodossa.
Ma perché sarebbe così importante? Perché questo ragionamento porta in seno, sia pure sottilmente, il rifiuto della dottrina eucaristica cattolica. Questo perché se il Corpo ed il Sangue di Cristo non sono il pane ed il vino eucaristici, ma piuttosto l’intero rito, allora Cristo non è fisicamente presente.
Il motivo è semplice: il rito non è qualcosa di fisico, ma di meramente ideale. Se è il rito la vera «specie eucaristica», il Corpo di Cristo non si manifesta affatto nel mondo fisico.
Corretto sarebbe stato affermare che alle specie eucaristiche, che sono il Corpo ed il Sangue di Cristo, corrisponda un luogo spirituale ove è inteso ne avvenga la consumazione, e che questo luogo sia il rito eucaristico. Ma il Grillo non sta affermando questo: sta affermando che il rito eucaristico sia il Corpo ed il Sangue del Signore. Non posso pensare però che un teologo del calibro di Andrea Grillo non sia ben consapevole della differenza fra le due asserzioni.
Stanti così le cose, questi ragionamenti costituiscono un rifiuto della dottrina eucaristica cattolica. Essi implicano direttamente che non vi sia una vera e fisica presenza di Cristo nel banchetto eucaristico tramite la trasformazione del pane e del vino nel suo Corpo e Sangue.
Con preoccupazione, pregando di sbagliarmi, mi chiedo se non possa essere questa la reale ragione del suo sfuriare nei confronti del Beato Carlo Acutis, che alla testimonianza a favore della Santa Eucarestia ha offerto tutta la sua vita.
Rimango fiducioso verso la buona fede e la ortodossia di Andrea Grillo, ma a questo punto un intervento chiarificatore sembra necessario.
Conclusione
Gli articoli che Andrea Grillo ha dedicato al Beato Carlo Acutis, se letti semplicemente per quanto in essi è scritto, non possono non apparire del tutto irrispettosi nei confronti del giovane.
A molti cristiani sono sembrati articoli ricolmi di astio, sarcasmo immeritato, ed asserzioni argomentate male o per nulla, oltre che stucchevoli mancanze di rispetto per un ragazzo che si è fatto esempio di Santità.
Se Grillo negasse che questo fosse stato il suo intento scusandosi per il linguaggio incautamente utilizzato, sarebbe giusto accettare la sua buona fede. Tuttavia, negare l’evidenza di quanto indelebilmente scritto, scaricando la colpa del «fraintendimento» sui cristiani che ne hanno tratto scandalo, non è una postura spirituale degna di un teologo del suo calibro.
Attaccare Carlo Acutis è attaccare la coraggiosa e controculturale lotta per la santità di una generazione sempre più aggredita dal secolarismo e dalla mediocrità moderna.
Se anche la sensibilità di Acutis fosse davvero «ingenua» quanto sostiene Grillo, noi la abbracceremo comunque: perché Santa Chiesa ha stabilito che essa abbia condotto il giovane al paradiso, ed è lì, e lì solo, che noi desideriamo andare.
Dove condurrà, invece, il percorso intellettuale del teologo? Per ora, sembra averlo portato a revisionare o trattare con superficialità l’insegnamento millenario della Chiesa.
Inoltre, i ragionamenti sull’eucaristia che ha condiviso devono essere necessariamente chiariti. Stanti così le cose, egli sta proponendo qualcosa di profondamente «altro» rispetto alla dottrina Cattolica.
È un terreno spirituale pericoloso, da cui dovremmo tenerci cautamente alla larga.
Speriamo comunque nella buona fede del teologo, e ci auguriamo di vedere opportune spiegazioni, accompagnate da indispensabili ed imprescindibili scuse per i fedeli scandalizzati e per il Beato, che a prescindere dall’intento di Grillo, nei suoi scritti è stato trattato con evidente irriverenza.
Non di meno, Andrea Grillo è un docente con il gravoso onere di formare le prossime generazioni di teologi e di presbiteri. Per lui, e per tutti i docenti che con lui condividono questa responsabilità, dobbiamo pregare.
Preghiamo dunque per tutti questi, e così anche per noi, affinché il Signore conceda a ciascuno la lucidità e la mitezza di tornare sempre all’ovile della Chiesa.
Preghiamo di ascoltare sempre la Parola, la Tradizione ed il Magistero vivo, senza imporvi la superbia di voler spiccare intellettualmente su di essi. Preghiamo di amare sempre l’eucarestia che è Cristo e alimento che ci sostiene in questo cammino, con la stessa santa ingenuità che Carlo ha condiviso con i Santi che lo hanno preceduto.
Beato Carlo Acutis, ottienici questo per la tua intercessione. Amen.

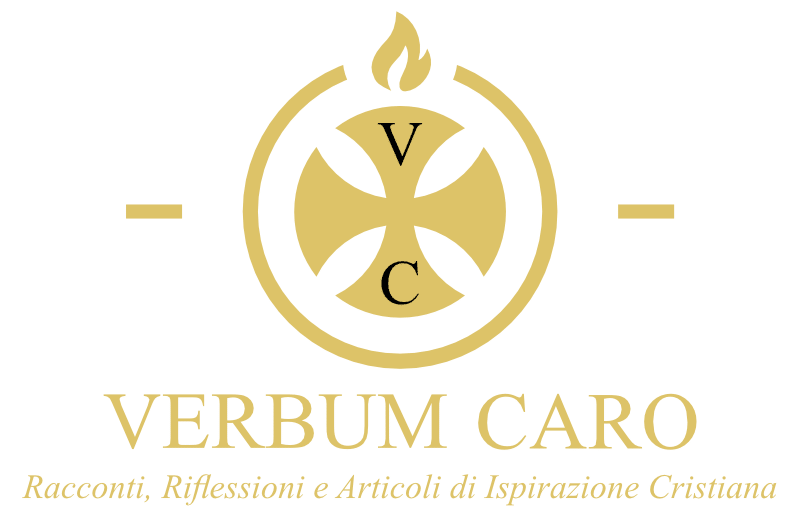

Lascia un commento