Anziché sanare le cause della profonda crisi relazionale del nostro tempo, processiamo colpevoli già morti. Eppure, una soluzione esiste.
Indice
Nel 1649, nel contesto di una sanguinosa guerra civile, il condottiero Oliver Cromwell depose il re di Inghilterra Carlo I, condannandolo a morte. Diede così inizio ad un governo repubblicano, il «Commonwealth of England». Nel 1658, Cromwell però morì, e poco più di due anni più tardi Carlo II restaurò la corona inglese.
Quando ciò accadde, per consolidare il suo potere e imporre una definitiva condanna alla memoria del regicida, il Re ordinò che Cromwell venisse riesumato e sottoposto ad un regolare processo pubblico. Cromwell – o almeno, ciò che di lui restava – fu condannato ad una seconda morte, impiccato e nuovamente sepolto – eccetto per la testa, che fu rimossa dal corpo ed esposta al pubblico ludibrio per oltre vent’anni.
Ancora più bizzarro che infierire su un cadavere per un crimine commesso in vita, però, sarebbe processare un morto per un crimine consumatosi dopo la morte e sepoltura dello stesso, trovando un qualche fantasioso sistema per cui un defunto possa rendersi responsabile di un delitto.
Eppure, a qualcosa di simile a questo singolare esercizio, pur trasposto sul piano delle idee, sembrano appassionati diversi «intellettuali» moderni.
Chiarisco. Ogni qualvolta la cronaca sia macchiata da un omicidio con una vittima femminile, specie qualora si tratti di un «delitto d’amore» (le virgolette sono doverose), i giornali e le televisioni si riempiono di opinionisti pronti ad additare «il patriarcato» come colpevole di tale male. Si arriva addirittura al delirio di scagionare l’omicida pur di crocifiggere l’idea, come accadde nel Caso Turetta, omicida che nel 2023 ha assassinato la giovane Giulia Cecchettin, definito da qualcuno «figlio sano del patriarcato».
Ogni volta che assisto a questo spettacolo, che piega la tragedia dell’omicidio ad una demenziale logica di ideologia, mi trovo ad interrogarmi a lungo sulla disposizione degli opinionisti che si spendono verso questa tesi; a chiedermi se siano folli, totalmente privi di capacità di osservazione ed analisi, oppure in mala fede. Puntualmente concludo che non possano che essere macchiati da tutte e tre le colpe.
Questo perché il patriarcato, di fronte a qualsiasi analisi non ideologica, è completamente morto da almeno trent’anni.
Cos’è realmente il patriarcato?
Al netto di ridefinizioni ideologiche del termine, il patriarcato è quel sistema di organizzazione familiare – e per estensione sociale, essendo la famiglia il fondamento di ogni forma di società – secondo cui la autorità è accentrata sul patriarca, cioè il padre di famiglia o il maschio più anziano.
Il patriarcato è necessariamente fondato su una forte identità maschile, e sulla capacità del soggetto maschile di imporre la sua giurisdizione sulla famiglia. Sino al ‘900, una famiglia era un nucleo numeroso: si componeva dei nonni, che avevano spesso numerosi figli, che procuravano spesso numerosi nipoti. Stabilire la direzione della famiglia, dirimere le controversie, organizzare quella «micro società» per le difficoltà di un mondo ancora non stravolto dalla distribuzione di massa e dal «benessere», era compito del patriarca, specie nel mondo rurale.
L’educazione dei figli era rigida, e, per i maschi, particolarmente orientata a tutelare questo sistema. Era necessario che i ragazzi fossero formati ad una mascolinità temperata, forte, resistente, austera; ma anche che fossero abituati ad un rispetto per l’autorità del padre, di cui avrebbero prima o poi ricoperto il ruolo. Similmente, per le ragazze, l’educazione era rivolta specialmente a prepararle al ruolo di cura della famiglia e del futuribile marito, nonché alla educazione dei figli.
Lo spazio per l’introspezione, per l’esplorazione emotiva, per l’individualità era compresso: la logica era quella della continuità, in un mondo dove la sopravvivenza come singolo individuo era difficile o impossibile, specie per i ceti meno abbienti. Rispetto ad una sensibilità moderna, il modello educativo vigente fino alla seconda metà del ventesimo secolo risulterebbe autoritario, repressivo, addirittura violento.
La società prende la forma della famiglia: così quella patriarcale fu indubbiamente una società dove i ruoli di potere ed autorità, e gran parte delle posizioni lavorative, rimanevano prerogativa dei maschi. La donna lavoratrice esisteva già, ma le tipologie di carriera ad essa possibili erano certamente diverse da quelle aperte agli uomini. Inoltre, era quasi inesistente la figura dell’uomo o della donna «single» – salvo per i consacrati. Del resto se patriarca condivide l’etimologia con pater, è chiaro che si trattasse di una società non tanto fondata sull’uomo quanto sul padre, ed il padre, per definizione, richiede una madre.
Si potrebbe ragionevolmente dire che la società patriarcale fosse società fondata sul matrimonio, nella sua accezione etimologica di mater–monium, dove monium significa compito, e nello specifico il compito della madre di dare alla luce, crescere ed educare i figli. Esso doveva essere sostenuto dal patrimonio – ancora una volta pater-monium, il compito del padre di provvedere alle necessità materiali e di sicurezza della moglie e dei figli.
Compreso questo, possiamo tornare all’osservazione fatta in apertura. Chi sostiene che i casi di violenza tra i sessi che osserviamo fra i giovani di oggi siano frutto della cultura patriarcale, deve altrettanto sostenere che i perpetratori – solitamente uomini nati tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei duemila – siano stati cresciuti ed educati in un contesto patriarcale. Leggendo quanto ricapitolato in questo paragrafo, si dovrebbe ben capire perché ho accusato di follia, inettitudine o malizia chi si propone di sostenere questa tesi.
Si può ancora parlare realmente di patriarcato?
Dalla cosiddetta «rivoluzione sessuale» avvenuta tra gli anni sessanta e settanta, questo tipo di struttura famigliare si direbbe tutto fuorché predominante: e negli anni novanta, essa si può dire totalmente scomparsa. Per affermare questo è sufficiente essere in grado di osservare la propria realtà sociale quotidiana senza veli ideologici. Ma se ciò non bastasse, è possibile guardare le metriche relative alla vita coniugale che forniscono gli istituti statistici pubblici e privati.
Secondo i dati Eurostat, dagli anni settanta in poi si è assistito ad un declino drammatico di tassi di matrimonio, che nell’arco del quarantennio sono più che dimezzati. Contestualmente si è osservato un raddoppio abbondante dei tassi di divorzio – almeno fino agli anni recenti, quando il numero sempre più basso di matrimoni ha portato anche ad un ovvio abbassamento dei divorzi.
Il cambiamento è stato accompagnato dal dimezzamento del tasso di natalità, con il passaggio per l’Italia, dagli anni sessanta ad oggi, da un indice di 2.40 a 1.21 nascite per donna. Contestualmente, si è assistito ad un aumento dell’età media delle madri al primo figlio: nel 2023, questa ha toccato in Italia i 31 anni e dieci mesi.
Questi figli, inoltre, nascono sempre più frequentemente fuori dal contesto matrimoniale. Infatti, se negli anni sessanta in Italia appena il 2.4% dei bambini nasceva da coppie non sposate, questo valore ha superato nel 2023 il 40%.
Confrontati da questi dati, gli ideologhi femministi cercano spesso di ridefinire il concetto di «patriarcato» come il «controllo dell’uomo sulla sessualità della donna». Per quanto possa essere faticoso metabolizzare il fatto che qualcuno possa partorire un simile delirio, è necessario prendendo atto che questa idea è di fatto dominante nell’ambiente intellettuale femminista. Ma questa tesi è evidentemente in diretto contrasto con la realtà dei fatti.
Dalla «liberazione sessuale» del sessantotto ad oggi si è osservato un aumento degli incontri sessuali prematrimoniali – come già evidenziato dall’esplosione delle nascite extra matrimoniali. Gli affetti e le relazioni nascono con assoluta libertà e leggerezza, privi di qualsiasi vincolo sociale – tanto meno di natura patriarcale. L’età minima del primo rapporto sessuale è diminuita drasticamente, fenomeno a cui si associa l’esplosione dell’uso dei contraccettivi.
Ciò in particolar modo con la comparsa dei contraccettivi femminili, come la pillola, che hanno contribuito a «sganciare» la sessualità femminile dalle sue naturali conseguenze. A questo proposito, l’elefante nella stanza è certamente il dibattito sull’aborto.
In virtualmente qualsiasi paese europeo, una donna può far uccidere il proprio figlio nascituro, entro il terzo mese di gravidanza, liberamente e senza il permesso del padre del bambino, anche in situazioni ove non vi sia alcun pericolo per la salute psicologica o fisica della madre.
Si tratta di realtà che rendono evidentemente insostenibile la tesi femminista, dimostrando come nella realtà moderna, il controllo sull’atto sessuale – e sulla sua naturale conseguenza, cioè la vita – non sia affatto esclusivamente maschile.
Di fronte alla realtà inequivocabile della società moderna, come è possibile affermare che essa sia ancora permeata da una cultura patriarcale? Una simile posizione non può essere frutto di una analisi disinteressata della realtà, ma solo di presupposizione ideologica.
Per gli intellettuali femministi moderni la società è patriarcale a prescindere dall’analisi dei fatti; e questo perché l’intera giustificazione della loro corrente ideologica dipende da questo.
Dalla «liberazione sessuale» alla crisi dei sessi
Smontare la tesi secondo cui i «femminicidi» sarebbero «manifestazioni di una cultura patriarcale» ci lascia purtroppo nella posizione poco confortevole di non avere un capro espiatorio ideologico a cui additare questa crisi.
Si potrebbe ragionevolmente affermare che non ne abbiamo bisogno. A ben vedere, infatti, non esiste alcuna emergenza: il numero degli omicidi, inclusi gli omicidi con vittime femminili, è consistentemente diminuito negli ultimi vent’anni ed è oggi ai minimi storici. Per altro, per ciò che concerne l’Italia, il numero è fra i più bassi in Europa: significativamente più basso di paesi considerati «più progressisti» come Germania, Olanda, Finlandia, Regno Unito.
Ciò non significa però che non vi sia qualcosa di profondamente disfunzionale nel rapporto fra i sessi, su cui vale la pena riflettere. Infatti, mentre processiamo il patriarcato per crimini commessi ad almeno vent’anni dalla sua morte ed inventiamo crisi di «violenza di genere» inesistenti, ignoriamo una emergenza ben più reale e socialmente preoccupante. Una crisi che, forse, potrebbe avere con gli episodi di violenza osservati negli ultimi anni dei collegamenti più significativi di quanti non ne abbia «il patriarcato».
Gli indicatori che affermano questa disfunzione sono gli stessi che confermano la morte del patriarcato: declino del matrimonio come scelta di vita permanente, crollo della natalità, aumento vertiginoso dell’età media al primo figlio. Si tratta di indicatori che dovrebbero preoccupare tutti, quantomeno per le evidenti implicazioni sociali ed economiche – in particolare nei paesi con una forte struttura assistenzialistica.
Tuttavia, ci sono delle ulteriori metriche che possono aiutarci a capire che «qualcosa non va»: metriche che per alcuni sociologi testimonierebbero una specifica «crisi del maschile».
Nell’ultimo decennio infatti, in particolare nei paesi anglosassoni, il sesso maschile ha dimostrato essere affetto da una sofferenza senza precedenti, il cui primo indicatore è rintracciabile nei risultati scolastici e accademici. I ragazzi hanno un rendimento scolastico medio ed un tasso di abbandono delle aule universitarie in continua crescita, e nettamente superiore alle loro coetanee. Similmente, i giovani uomini guadagnano significativamente meno delle loro coetanee in età post universitaria.
Tra i millennials ed i gen-xers, per la prima volta nella storia sono spesso le donne i «breadwinner», quanto meno dal ceto basso a quello medio-alto. Se ciò non bastasse, tra i maschi statunitensi si registra nel frattempo un’autentica rinuncia ad affrontare la vita, testimoniata da alcuni indicatori preoccupanti: incidenza in crescita del fenomeno neet (not into employment, education or training, persone disoccupate e non impegnate nello studio o nella preparazione professionale o sportiva), aumento dell’isolamento sociale, aumento dell’abuso di alcolici e droghe – e decessi per overdose – aumento dell’incidenza di suicidi.
Per i giovani uomini statunitensi, tutti questi indicatori superano abbondantemente quelli relativi alle loro controparti femminili. Il fenomeno in Europa è leggermente più contenuto, ma comunque decisamente rilevabile.
La crisi del maschile
Non è facile dare una spiegazione a questo un fenomeno. In ragione del forte grado di ideologizzazione che percorre i cosiddetti «studi di genere», si tratta infatti di metriche difficili da valutare senza sovraimporvi filtri ideologici. Tuttavia, la spiegazione che io ritengo più convincente e più rispondente alla mia esperienza diretta, è che gli uomini occidentali siano in preda ad una profonda crisi di senso.
Lo psicologo americano Jordan Peterson è un testimone fondamentale di questa tesi. Peterson è saltato agli onori della cronaca attorno al 2018, dopo ad essersi scontrato con l’ideologia progressista che nelle accademie canadesi ha imposto ai docenti, a suon di onerose sanzioni, di assecondare le identità di genere degli studenti transessuali.
Da allora, l’attività dello psicologo si è concentrata sull’analisi dei conflitti di genere ed in particolare della «crisi della mascolinità», inquadrando quest’ultima in una più ampia dimensione di crisi di senso e della percezione del proprio ruolo sociale. Peterson si è dedicato – pur essendo personalmente non credente nel senso comune del termine – alla divulgazione della sua analisi psicologica e archetipica delle scritture bibliche, riscuotendo un successo senza precedenti fra i giovani uomini canadesi ed americani.
Dalle sue esperienze in quest’ambito, che lo hanno portato a riempire interi stadi in eventi di divulgazione, Peterson afferma di aver raccolto innumerevoli testimonianze di giovani confusi sul senso della loro identità maschile, sul loro ruolo nella società, e sul senso ultimo dell’esistenza.
La consapevolezza verso l’esistenza di una «crisi del maschile», però, non riguarda solo intellettuali legati al mondo tradizionalista o conservatore, ma è stata rilevata anche da diversi pensatori progressisti. Alcune delle soluzioni che quest’ultima area intellettuale propone, tuttavia, manifestano a mio avviso una grave miopia ideologica.
Invece che riconoscere il fallimento dell’attuale sistema socioculturale, in particolare per ciò che concerne i valori famigliari ed il rapporto fra i sessi, gli intellettuali post femministi propongono di «ripensare il maschile», sottendendo dunque che uno dei due sessi possa essere ingegnerizzato in un laboratorio di scienze politiche.
Sul fondo di questo atteggiamento stanno due assunzioni egualmente false ed ideologiche. La prima e più fondamentale, è che il sesso non sia una caratteristica ontologica del corpo, della persona e dello spirito umano, ma un semplice fenomeno sociologico. Su questa idea non mi soffermerò ora e probabilmente non mi soffermerò mai, giacché la ritengo poco più che un indicatore di scarsa igiene mentale.
Il secondo assunto è che la crisi sia solo maschile. Il genere femminile non sarebbe, secondo questi pensatori, colpito da nessuna crisi ma piuttosto starebbe attraversando un periodo di prosperità. Dunque, è solo la mascolinità a dover essere «ripensata» e adeguata alla società moderna e post patriarcale.
Questa conclusione è semplicemente non ricevibile. I sessi sono infatti una diade perfettamente complementare: la crisi del maschile non può esistere se non con una parallela e contraria crisi del femminile, e, in effetti, abbiamo indicatori più che sufficienti a dimostrarlo.
La parallela crisi del femminile
Se è infatti vero che la performance accademica ed economica delle donne sia migliorata negli ultimi decenni, tanto da essere in sorpasso rispetto agli uomini, resta da dimostrare queste metriche siano sufficienti ad indicare una sana espressione della femminilità nell’epoca moderna.
Rilevare che le donne stiano coprendo meglio o più frequentemente degli uomini i ruoli tradizionalmente maschili, non è in alcun modo un indicatore esaustivo della supposta prosperità del genere femminile.
Infatti, sebbene le donne abbiano certamente migliori possibilità lavorative ed accademiche oggi rispetto a cinquant’anni fa, la soddisfazione che generalmente esse provano per la propria vita non è in aumento. Tale realtà è stata ripetutamente confermata negli anni da vari studi sociologici e psicologici.
Al questi si sommano indicatori di natura clinica paralleli a quelli già osservati per i giovani uomini. Fra le giovani donne, ed in particolare fra le ragazze adolescenti, il tasso di depressione è aumentato sistematicamente dal nuovo millennio, così come l’utilizzo degli psicofarmaci.
Questa tipologia di farmaci, ed in particolare gli ansiolitici come lo Xanax, rappresentano una letterale epidemia fra le ragazze adolescenti, che ne fanno un uso quasi doppio rispetto agli uomini – spesso senza alcuna ricetta medica.
Sembra dunque evidente che vi sia anche fra il genere femminile una crisi simile e parallela a quella maschile, seppur testimoniata da indicatori diversi. La situazione è in effetti rilevata da diversi pensatori – e pensatrici.
Intellettuali come la sociologa Eva Illouz o la giornalista Mary Harrington, che pure non appartengono certamente ad una corrente tradizionalista, hanno attribuito la sofferenza della donna moderna ad una profonda insoddisfazione relazionale. Secondo queste pensatrici il cambiamento del ruolo della donna nella società consumistica, unitamente alle conseguenze della «liberazione sessuale» del sessantotto hanno denaturato radicalmente la dimensione relazionale del rapporto uomo-donna, una dimensione che per l’esperienza femminile è assolutamente fondamentale.
La così detta «uguaglianza» non ha infatti creato nuovi spazi sociali adatti alla natura femminile, ma piuttosto ha inserito la donna in spazi sociali tradizionalmente sviluppati attorno alla fisiologia, l’attitudine e persino la sessualità maschile.
Nel mondo del lavoro, la donna moderna si trova costretta su un sistema economico che impone giornate lavorative lunghe ed impegnative. Così, quando non è la gravidanza a diventare un ostacolo alla carriera femminile, è la carriera a rendere indisponibili i tempi per uno sviluppo relazionale sano con i figli. La donna lavoratrice che ambisce ad una carriera – per vocazione propria o per pressione sociale – è di conseguenza privata della dimensione profonda della maternità, che per la maggior parte del genere femminile è un desiderio archetipico e fondamentale.
La stessa «rivoluzione sessuale», operando una demistificazione ed una trivializzazione dell’incontro sessuale, ha favorito la sparizione di quei tempi e spazi relazionali nel rapporto uomo-donna che sono vitalmente fondamentali per la psiche femminile. Il corteggiamento è compresso o addirittura annullato, e dove presente è appiattito su esperienze sempre più legate al consumismo che alla costruzione della relazione e alla progettualità di coppia.
La giornalista e autrice Louise Perry, definita da alcuni «femminista reazionaria», ha criticato duramente la positività del mondo femminista attorno alla «rivoluzione sessuale», ed in particolare per quanto riguarda la diffusione esplosiva della produzione e del consumo di pornografia. Quest’ultima, operando una distorsione delle aspettative relazionali specialmente nei giovani uomini, fra i quali costituisce una autentica epidemia, costringe le donne a misurarsi con una sempre maggiore riduzione del rapporto uomo-donna alla dimensione sessuale, ed ad una dimensione sessuale non naturale ma scenica e performativa, e dunque estremizzata e disumana.
In ultima istanza, tutte queste riflessioni tornano a quegli indicatori citati all’inizio: il crollo dei matrimoni e della natalità generale, l’innalzarsi dell’età media del primo figlio, l’instabilità dei rapporti.
Tanto la crisi del maschile quanto quella del femminile possono infatti essere riassunte in una parola: crisi della famiglia. La realtà che dovremmo osservare è che uomini e donne non sono più capaci di incontrarsi in maniera sana per costruire relazioni significative, durature, progettuali. Relazioni da cui naturalmente si sviluppa l’intera società e da cui nasce la vita.
Relazioni senza cui la stessa psiche dell’individuo è compromessa, ed egli si trova senza senso, senza scopo, senza direzione, senza consapevolezza di cosa è e di quale sia il suo ruolo.
Nello scorso capitolo, abbiamo dimostrato come il fenomeno dei femminicidi, se realmente esistente come fenomeno sociale di massa, non possa essere attribuito al «patriarcato», una realtà sociale del tutto defunta. Parimenti non vogliamo commettere il simile errore di creare un discutibile nesso causale tra questo fenomeno e la crisi di cui abbiamo parlato in questo capitolo.
D’altra parte non possiamo non vedere un collegamento credibile tra lo sfogo di violenza e la realtà in cui è costretta a muoversi questa generazione.
Si tratta di una realtà dove uomini non più formati alla propria identità maschile incontrano donne non formate alla propria identità femminile, in un contesto in cui le differenze sono trivializzate e negate dall’ideologia e dalla cultura. Un contesto peraltro privato della dimensione etica e relazionale dell’incontro e dove il mistero sessuale è sparito ed appiattito ad una visione volgare e pornografica. Dove la progettualità ed il sacrificio latitano e trionfa il vicendevole consumo erotico, totalmente effimero, arbitrario, capriccioso.
Di fronte ad una simile realtà, chiunque abbia chiaro cosa è un uomo e cosa è una donna, non può stupirsi quando la natura, che ha disposto nell’uomo una forza ed una attitudine alla violenza totalmente diversa rispetto alla donna, tragicamente presenta il conto.
Un altro Uomo ed un’altra Donna
Per proporre una diversa visione del rapporto tra uomini e donne, dobbiamo tornare alle origini, soffermandoci su cosa siano in effetti uomo e donna; in cosa differiscano, in cosa si equivalgano, e quale sia il loro rapporto naturale. Faremo questo con l’aiuto del «manuale delle istruzioni» dell’Uomo, ovvero la Sacra Scrittura.
La Bibbia parla infatti dell’uomo e della donna sin dal primo capitolo della genesi.
Genesi 1:26-28, 31
26 Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.
27 E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.28 Dio li benedisse e Dio disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”.[…] 31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
C’è così tanto già in questo primo capitolo. Per cominciare, il versetto ventisette pone quella che è la pietra fondante della antropologia cristiana: l’Uomo, inteso come «essere umano» e quindi come uomo e come donna – «maschio e femmina li creò» – è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Ha dunque una dignità infinita. Ogni uomo ha un valore incommensurabile, senza limiti, ed è impossibile da porre in una gerarchia di valore rispetto agli altri uomini – e donne – perché è immagine dell’infinito che plasma l’universo.
Per questa ragione appare evidente come ogni lettura che immagini una differenza di dignità ontologica tra uomo e donna è sia una imposizione ideologica che ignora ciò che il testo, con assoluta chiarezza, afferma.
I versetti ventisei e ventotto che incorniciano il testo ci parlano dello scopo per cui l’essere umano, nella sua unità, è creato: dominare e coronare la Creazione, la natura. Questo è un esercizio che richiede la collaborazione dei due sessi, perché intimamente legato alla procreazione: siate fecondi e moltiplicatevi, comanda Dio.
La vita umana deve crescere e coprire la terra, per governarla come fedele amministratore. Del resto, il crescere delle famiglie e delle società, o, in gergo tecnico, «l’espansione demografica» è il motore pulsante di ogni società capace di affrontare il mondo.
Il capitolo due della Genesi ci offre un altro racconto per la creazione dell’uomo, complementare al primo.
Genesi
18 E il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda”. […] 21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. 22 Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.23 Allora l’uomo disse:
“Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta”.24 Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.
25 Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna.
Questo secondo racconto, a differenza del primo, introduce una relazione asimmetrica fra uomo e donna. Alcuni leggono in questo passaggio una differenza di dignità fra i due generi, ma questa lettura è in chiaro contrasto con il racconto precedente. Abbiamo infatti letto che uomo e donna condividono la stessa relazione con Dio, perché ne sono entrambi immagine. In virtù di questo, come detto, possiedono la stessa dignità ontologica e morale. Perciò questa immagine non può essere letta come un tentativo di stabilire una gerarchia.
Tuttavia è altrettanto sbagliato ignorare questo passaggio considerandolo semplice poesia priva di conseguenze. Infatti questo racconto ci parla di quella che è la relazione archetipica tra uomo e donna; una relazione che non è simmetrica. Una relazione che pur essendo fra creature con uguale dignità, non è equivalenza tipologica.
Cerchiamo di proporre una lettura. In questo secondo racconto la donna è rappresentata come parte sottratta all’uomo, e l’uomo è di conseguenza essere incompleto senza di essa. L’uomo deve dunque incontrare la donna per conseguire la completezza. Questo sottende una relazione tra un desiderante un desiderato, dove il fondamento del desiderio è la ricerca dell’unità.
Con le parole «L’uomo lascerà suo padre e sua madre», l’uomo ci è proposto come soggetto attivo, che si stacca dalla sua casa per cercare la donna. Dunque egli «si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne». Non più due, non più incompleti, ma un’unità.
Cavalieri e Principesse, Barbari e Prostitute
Questa tensione intimamente tessuta nella natura umana si è espressa nell’immaginario comune con una coppie di figure archetipiche ricorrenti in ogni cultura, in ogni luogo, in ogni tempo: il cavaliere e la principessa, i quali appaiono in qualche misura nei miti fondativi di ogni civiltà umana.
La principessa è la donna che si rende desiderabile in virtù delle sue qualità estetiche, intendendo in questo caso non una estetica meramente fisica ma piuttosto ontologica, totale. La vocazione della principessa non è tanto essere bella, ma essere il bello. Nell’epica e nei miti, essa non è principalmente, o almeno non solo, desiderata per la sua bellezza fisica, ma soprattutto per la sua bellezza morale, la grazia, la nobiltà, la candidezza dello spirito.
La bellezza principesca di conseguenza non è passiva, non è un «qualcosa che si ha», ma una bellezza attiva, cioè «qualcosa che si è». Per questo, essa agisce su chi la contempla, e pretende da questi un qualche cosa: è dunque questa ragione che a questo archetipo femminile non può che essere associato a quello maschile del cavaliere.
Il cavaliere, più che ad essere, è chiamato a fare. È l’uomo che si incammina per rendersi degno della bellezza per mezzo delle sue imprese; colui che, mosso dal desiderio di unità con la principessa, si incammina per superare le prove e le peripezie che conducono all’amata.
La cultura femminista ha contestato la validità di questi «ruoli psicologici» vedendo in essi la riduzione della donna ad un oggetto, un trofeo da conquistare. Una volta «ottenuta» la principessa esaurirebbe la sua funzione, mentre il cavaliere cercherebbe una diversa avventura amorosa. La donna cesserebbe allora di essere oggetto del desiderio e sparirebbe, ad esempio, nel ruolo materno, nella sua funzione sociale.
Si tratta di una lettura che fraintende il senso di questa immagine, e non considera la natura fondamentale di quel «desiderio di unità» a cui abbiamo accennato. In primo luogo, principessa e cavaliere sono figure sempre accoppiate: non si può dare l’uno senza l’altra. Sono tipi psicologici che descrivono, come già ribadito, non la natura ontologica dell’uomo o della donna, ma piuttosto la loro relazione.
In secondo luogo, è importante riflettere sulla natura di questo desiderio, per capire che esso non può essere ridotto ad una consumazione sessuale. Per capire questo basta pensare come, nei racconti del passato, le imprese che il cavaliere è chiamato a compiere hanno sempre una dimensione spirituale prima che materiale; perché la lotta del cavaliere è anzitutto trascendere sé stesso, le sue pulsioni, le proprie viltà.
Ciò non sarebbe necessario se il culmine del viaggio del cavaliere fosse semplicemente «prendere per se», come oggetto o trofeo, la propria amata. Il desiderio che distingue il cavaliere non è principalmente volontà di possesso, ma piuttosto di sacrificio, di dono integrale di sé; e non è un caso che la massima ambizione del cavaliere delle canzoni medioevali è, appunto, la morte per la propria amata.
Il greco, la lingua dei Vangeli, distingue fra tre forme di amore. La prima è la filia, l’amore tipico della amicizia. È un amore che si manifesta come gioia per la semplice vicinanza con qualcuno, per la condivisione di un tempo, uno spazio, una esperienza.
Vi è poi l’amore erotico, l’eros. Questo è quell’amore che desidera l’unione fisica e carnale con l’altro. È una forma di amore che sottende un movimento «introverso», volto a portare qualcosa dall’esterno a sé. Una forma di amore che vuole «prendere» l’amato per il proprio piacere: fisico, intellettuale, economico, spirituale.
C’è però una terza parola greca per amore, che è agape. L’amore agapico è il desiderio profondo per il bene altrui. Un sentimento «estroverso» che spinge l’uomo non a conquistare, ma a donare integralmente sé stesso per il bene dell’amato. Questo è l’amore di cui parla il Cristo quando comanda ai discepoli «amatevi gli uni con gli altri come io ho amato voi». Un amore che offre la sua intera vita.
Ciò che muove il cavaliere verso la principessa è la completezza di queste tre tipologie d’amore, dove tutto è però espresso ed inquadrato principalmente attraverso il sentimento agapico. Ed è questo il motivo per cui questa non è una forma di relazione che si esaurisce con la «conquista» della principessa da parte del cavaliere. L’unione fisica dei due non è un culmine che conclude il desiderio, ma piuttosto la progressiva integrazione della promessa della Genesi secondo cui «i due saranno una sola carne».
L’incontro sessuale non è infatti la conclusione del desiderio ma piuttosto, il «segno sacramentale» di una unione che si compie progressivamente nel progetto matrimoniale. Così l’uomo e la donna che vivono nel matrimonio sono cavaliere e principessa escatologici sino all’ultimo loro giorno terreno.
L’Amore Evangelico
Meravigliosamente, San Paolo lega l’ideale di amore cristiano tra un uomo ed una donna proprio all’amore mistico che lega il Cristo alla sua Chiesa.
Lettera agli Efesini 5:21-33
21 Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: 22 le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; 23 il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. 24 E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto.25 E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 26 per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, 27 e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. 28 Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso.
29 Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, 30 poiché siamo membra del suo corpo.31 Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 32 Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
Erroneamente si è letto in questo brano una sottomissione ontologica della donna all’uomo. Possiamo capire che questa lettura è sbagliata da due elementi.
In primi, l’apertura del brano, con «siate sottomessi gli uni agli altri», parla chiaramente una sottomissione vicendevole. In secondo luogo, le prescrizioni che Paolo da alle mogli ed ai mariti non implicano una azione sull’altro, ma esclusivamente su sé stessi.
Paolo non prescrive al marito di governare o comandare la propria moglie, diversamente da come avrebbe probabilmente suggerito un pagano del suo tempo. Il rispetto dell’autorità maschile è prescritto invece alla moglie; ma senza che vi sia un parallelo invito al marito ad esercitare tale autorità. Invece, a questi è richiesto qualcosa di diverso: di amare, e di amare come Cristo ha amato la Chiesa, cioè sino alla morte, sino al completo svuotamento di sé.
A ciascun coniuge è prescritto un atteggiamento che non dipende dal comportamento dell’altro coniuge. Ciò perché l’amore che Paolo è in mente è agapico, estroverso: entrambe le prescrizioni sottendono un amore che, seppur in maniera diversa, chieda a ciascuno di farsi dono per l’altro, rinunciando a sé stesso per costruire quella unità che è promessa nel matrimonio. Paolo descrive questo come una misteriosa affinità a quell’amore che lega Cristo e la sua Chiesa: un amore per cui Cristo, svuotando sé stesso, si sacrifica completamente in favore della Chiesa, e quest’ultima segue docilmente la via che egli ha indicato.
Questo amore ha, come conseguenza finale, l’integrazione in un corpo unico. Per seguire il parallelo Paolino tra l’amore divino e l’amore coniugale, l’unione sessuale – e la vita che da essa procede – diventa quasi un segno sacramentale dell’unione tra gli sposi, così come l’Eucaristia è sacramento dell’unione tra Cristo e la Chiesa.
Diametralmente opposta a questa visione mistica dell’amore sta la concezione moderna. Nella concezione odierna, non vi è alcuna unità metafisica nell’incontro tra l’uomo e la donna. Essi rimangono individui, con i propri personali interessi, sogni ed aspirazioni disgiunti ed individuali, che si incontrano soltanto per una convenienza reciproca – emotiva, economica, sessuale, lavorativa. Una convenienza che può cessare a seconda delle aspirazioni e dei bisogni di uno dei coniugi.
L’amore moderno è un amore fondamentalmente erotico, e non tanto in senso sessuale, quanto nel senso greco del termine. È un amore che cerca l’altro per sé, per assorbire dall’altro quanto conviene a proprio benessere, per consumarlo.
Questo tipo di amore è ben rappresentato da un altra coppia di archetipi, che possiedono una affinità narrativa con il triste tema da cui siamo partiti: barbari e prostitute.
A differenza della principessa, che è bellezza ontologica, la prostituta è mera apparenza sfruttata per la seduzione. Essa utilizza le sue qualità per attrarre a sé l’uomo ed ottenere da esso un vantaggio: protezione, sostentamento economico, supporto emotivo. L’amore della prostituta non pretende dall’uomo una crescita spirituale e ontologica, perché è amore di puro consumo: quando questi esaurisce la sua attrattiva o è superato da un altro potenziale partner, viene semplicemente abbandonato.
A fianco della prostituta sta il barbaro. Anche egli cerca la donna per ragioni personali: prestigio, desiderio sessuale, apparenza o stabilità emotiva. L’amore barbarico è appiattito sulla dimensione erotica, perché è puro possesso. Qui sì, la paura femminista è destinata inevitabilmente a concretizzarsi: il barbaro abbandona la donna nel momento in cui se ne presenti un’altra da possedere che conceda maggior piacere, maggior potere, maggior prestigio.
A differenza del cavaliere, il barbaro non cerca la trascendenza dalle proprie pulsioni, dalle proprie emozioni, dai propri desideri. Non cerca di «farsi degno» della prostituta, perché non c’è nulla di cui farsi degno: nessuna bellezza morale, nessuna grazia che chiede d’essere custodita, nessun invito estetico al trascendere sé stessi. L’appariscenza della prostituta è riconosciuta dal barbaro per ciò che è, cioè quella di una persona che ha ridotto sé stessa ad oggetto. Un oggetto che per quanto possa essere attraente, altro non invoca che la conquista.
Così, laddove l’amore cavalleresco ha per scopo l’elevazione degli amanti, l’esito dell’amore barbarico è invece il consumo vicendevole. Nel peggiore dei casi, questo amore di possesso sfocia nella violenza. E ciò è tristemente proprio della natura stessa del barbaro.
Conclusione
A scanso di scandalosi equivoci, tengo a chiarire che non sto ovviamente insinuando alcunché riguardo alle vittime di femminicidio. Non sto suggerendo che chi si trova a fianco di un barbaro sia una prostituta. Come ho già detto, si tratta di termini che puntano a strutture relazionali, non a realtà ontologiche relative alla persona in sé. Principessa e cavaliere, barbaro e prostituta: si tratta di tensioni, atteggiamenti, modi di incontrarsi, che in una qualche misura coesistono in ogni uomo ed in ogni donna.
Nessuno vive un amore completamente dominato dal sentimento erotico, come nessuno vive un amore perfettamente ordinato alla volontà agapica. Molti uomini e donne moderni, ad esempio, vivono rapporti di convenienza, ma sanno poi esprimere un completo e nobilissimo sacrificio di sé verso i loro figli. Altri credono o tentano di vivere un amore che sia veramente rivolto all’altro, e poi falliscono di fronte alle difficoltà o alle tentazioni che la vita propone. La ferita del peccato originale, per cui la «volontà della donna sarà contro il marito e questi userà dominio su di lei» (Genesi 3) è presente in tutti i cuori, senza esclusioni.
Ciò che però è innegabile è che la cultura moderna – a partire dall’intrattenimento, dal cinema, dalla letteratura – non sia più in grado di proporre una visione edificante dell’amore. L’amore propagandato dagli schermi televisivi, dai cartelloni pubblicitari, dai social network, è sempre più incentrato sulla convenienza personale, sessuale ed emotiva: su una estetica sempre più volgare e pornografica.
Nel frattempo, il discorso si è appiattito sul tema del consenso. Per il pensiero moderno non è importante che l’incontro tra uomo e donna diventato sempre più sterile, sempre più povero, sempre più limitato alla dimensione sessuale. Ciò che importante è solo che i sessi procedano verso questo abisso umano di comune accordo.
L’educazione affettiva, su cui così fortemente si torna ad insistere ad ogni tragedia, non si preoccupa di educare maschi e femmine alle loro differenze. Non insegna alle ragazze a conoscere il valore della propria purezza, la dignità di un «no», la grandezza del dono della vita che custodiscono; e non insegna agli uomini a conoscere la propria forza, il proprio dovere, il senso del giusto e del controllo su di sé.
Di fronte ai fallimenti della modernità, anziché prendere atto del fallimento del nostro sistema e cambiare strada, preferiamo riesumare un morto e processarlo, in un cupo rituale mediatico che rasserena le coscienze sino al successivo fatto di cronaca.
Invece, la via per una società più sana è un cambio totale di paradigma. Serve tornare a glorificare l’amore esaltandone la mistica, la tensione spirituale, il sacrificio, il dono di sé. Ma per fare questo, e farlo in maniera efficace, è necessario tornare ad avere consapevolezza di cosa siamo, di quali siano le nostre differenze, i nostri ruoli, le nostre tensioni.
È necessario tornare ad affermare che l’uomo è uomo, la donna è donna, ed insieme compongono la famiglia e danno origine alla vita. Nei nostri licei, anziché consentire a sedicenti «sessuologi» di parlare di pillole e preservativi a ragazzi che ne sanno più di loro, si torni a raccontare il mistero dell’altro, la bellezza di un incontro fra i sessi che cerchi il bello ed il giusto trascendente.
Si torni ad educare i maschi all’eroismo, al sacrificio, ad i modelli antichi; e le ragazze alla bellezza, non solo fisica, non solo effimera, ma morale, spirituale, famigliare.
Forse, allora, non avremmo più bisogno di processare i morti.
Riferimenti
A. Documenti del Magistero cattolico
- Catechismo della Chiesa Cattolica
https://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm - San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html - Francesco, Amoris Laetitia
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
B. Statistiche demografiche e familiari
- Eurostat, “Marriage and Divorce Statistics” (agg. 04-04-2025).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriage_and_divorce_statistics - Eurostat, “Fertility Statistics” (dataset tps00199).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics - ISTAT, Vittime di omicidio – Anno 2023 (nov. 2024).
https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/Report_Vittime-di-omicidio_Anno-2023.pdf
C. Scuola, lavoro, indicatori sociali
- OECD, Education at a Glance 2024 – Indicator A3.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487 - Education Policy Institute (UK), Annual Report 2024 – Gender.
https://epi.org.uk/annual-report-2024-gender-2/ - Eurofound, “NEETs Topic Page”
https://www.eurofound.europa.eu/topic/neet - Wall Street Journal, “America’s Young Men Are Falling Even Further Behind” (13-10-2024).
https://www.wsj.com/articles/americas-young-men-are-falling-even-further-behind-11697011200
D. Salute mentale, dipendenze, suicidio
- Trust for America’s Health, Pain in the Nation 2023.
https://www.tfah.org/report-details/pain-in-the-nation-2023/ - AFSP, Suicide Statistics 2023.
https://afsp.org/suicide-statistics/ - C. Howard & S. Smith, “Alprazolam Misuse among Treatment-Seeking Youth” Journal of Adolescent Health 74 (2023).
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.01.012
E. Personalità accademiche
- Louise Perry, The Case Against the Sexual Revolution
https://www.amazon.com/Case-Against-Sexual-Revolution/dp/1509549986 - Jordan Peterson, Conferenze (01-07-2025)
https://www.youtube.com/@JordanBPeterson

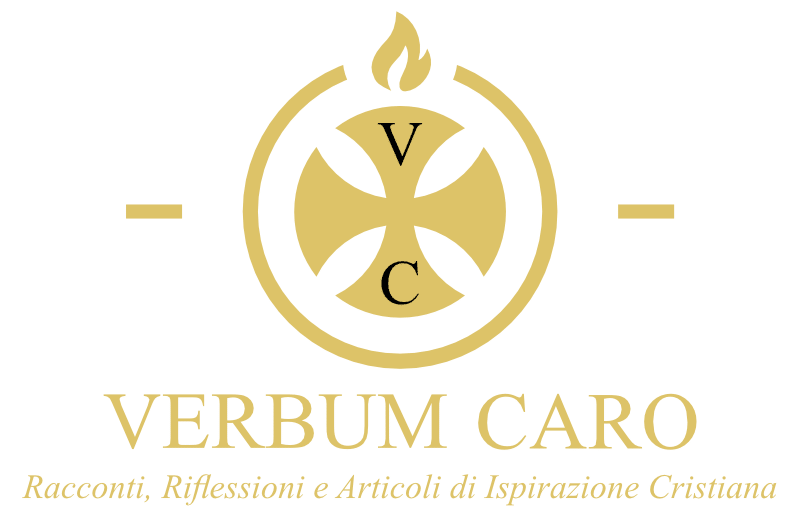

Lascia un commento