La personalità di Gesù è, qualora analizzata con un occhio attento, unica e quasi fuori dal tempo, anacronistica. Apprezzare profondamente questo fatto è il modo migliore per rendersi conto di quale sia la Sua vera natura.
Questo articolo è il primo di una serie che si propone di mostrare, attraverso delle riflessioni su alcuni episodi evangelici di particolare importanza, l’inspiegabile originalità di Gesù.
In questa prima parte, introdurremo la riflessione ed analizzeremo due episodi raccontati nel Vangelo di Luca.
Introduzione
Vi siete mai interrogati sulla storicità del vangelo, e sul rapporto che questa storicità può avere con le asserzioni teologiche del cristianesimo? William Lane Craig si è posto con grande serietà queste domande nel suo libro The Son Rises: Historical Evidence for the Resurrection of Jesus.
Craig è un filosofo, docente, autore prolifico e cristiano evangelico, celebre sopratutto per aver riportato nelle aule accademiche il cosiddetto argomento cosmologico, una argomentazione classica per l’esistenza di Dio basata sulla riflessione attorno all’origine dell’universo. Un argomento che affiora in più modi nella storia del pensiero sino alla filosofia greca, ma che il filosofo ha riproposto arricchito di osservazioni ispirate alle più recenti scoperte scientifiche.
La fama di Craig è dovuta in buona parte alla sua frequente partecipazione a dibattiti formali sull’esistenza di Dio. In questo contesto il filosofo si è scontrato con alcune fra le menti più acclamate della controparte ideologica – guadagnandosi una discreta fama e spesso anche il rispetto dei suoi avversari – utilizzando con abilità una discreta varietà di argomentazioni a supporto della sua tesi. Nell’armamentario del filosofo ci sono due argomenti ricorrenti, da lui chiaramente privilegiati: l’argomento cosmologico, che lo ha reso famoso, e un argomento che potremmo chiamare argomento dalla Resurrezione di Gesù.
La storicità della figura di Gesù di Nazareth è un fatto accettato dalla quasi totalità degli studiosi, a prescindere dalla appartenenza religiosa. Il mondo accademico accetta inoltre come storica la persona di San Paolo di Tarso, a cui sono attribuite con altrettanta certezza la maggior parte delle lettere paoline, nonché di San Luca, a cui è attribuita l’opera lucana, contenente il Vangelo secondo Luca e gli Atti degli Apostoli.
Queste opere, la cui veridicità è corroborata da una incredibile abbondanza di reperti manoscritti coevi agli autori, costituiscono autentici documenti storici. Secondo l’argomento di Craig, anche se considerassimo aprioristicamente inattendibile il contenuto miracolistico di questi testi, dovremmo comunque fare i conti con un nucleo di fatti storici inequivocabili, testimoniati per altro anche da fonti di terze parti, come lo storico romano ebraico Giuseppe Flavio, o il latino Tacito.
I fatti sono i seguenti:
- Gesù di Nazareth è stato ucciso per crocefissione;
- Tre giorni dopo, la sua tomba è stata trovata vuota;
- Nei giorni successivi, un gran numero di persone vide apparizioni del Gesù risorto;
- Molti di questi uomini mantennero la propria testimonianza sino al martirio, dando origine ad un movimento religioso che avrebbe avuto una crescita esplosiva ed un impatto socioculturale senza precedenti.
Craig sostiene che per questi fatti, che sono accettati come storici dalla maggior parte degli studiosi, vi siano solo tre possibili spiegazioni: che i discepoli abbiano mentito, che vi sia stata una sorta di allucinazione collettiva, oppure che la Resurrezione di Gesù sia un fatto storico.
Secondo il filosofo, la tesi della truffa è da scartare: gli apostoli, facendosi leader di questo movimento, avrebbero guadagnato solo persecuzioni e fatiche, sino al martirio, rendendo la loro ipotetica cattiva fede poco credibile. Craig offre inoltre alcune argomentazioni socio-psicologiche contro la tesi della allucinazione collettiva – la più accreditata in ambito accademico, fra gli studiosi non credenti – concludendo dunque che l’unica spiegazione possibile è la veridicità della Resurrezione.
Tuttavia, aggiunge Craig, sappiamo bene che secondo natura gli uomini non possono resuscitare dalla morte. La veridicità di un simile evento sarebbe quindi prova delle pretese di divinità avanzate da Gesù e, di conseguenza, dimostrerebbe il cristianesimo. The Son Rises: Historical Evidence for the Resurrection of Jesus, contiene per intero le riflessioni del filosofo su questo tema, e un discreto corpus di prove storiche e circostanziali a supporto delle premesse storiche citate.
Ho sempre trovato affascinanti le argomentazioni a supporto del cristianesimo fondate sulla sua storicità. Il cristianesimo è in effetti fra le pochissime religioni il cui mito fondativo non è in realtà un mito ma bensì un fatto storico precisamente collocato nel tempo, e dunque passibile di analisi e scrutinio. Tuttavia, per quanto ritenga forte l’argomento di Craig, penso che la Resurrezione sia solo una parte di ciò che rende l’analisi storica e contestuale della nascita del cristianesimo così interessante.
Il Paradosso di Gesù
Fra le riflessioni che hanno più aiutato la mia conversione alla fede cristiana, vi è l’idea che essa sia, nelle sue asserzioni teologiche, tanto radicalmente innovativa e originale da rendere la sua comparsa nella storia, ed il suo incredibile impatto storico e sociale, estremamente improbabile. Tanto improbabile, in effetti, da essere in qualche modo giustificabile solo a patto da considerarne veri i contenuti teologici.
Quando parlo di asserzioni teologiche radicalmente innovative, mi riferisco alle verità che il cristianesimo afferma circa la natura di Dio, la natura degli uomini, e la natura della salvezza.
Il contenuto teologico del cristianesimo è a dire poco bizzarro, paradossale, specialmente in relazione al contesto culturale da cui affiora – l’ebraismo del primo secolo – e questa incredibile originalità è dovuta interamente agli insegnamenti e alla potentissima personalità del suo protagonista. Gesù è un paradosso, un imponderabile, qualcosa di così unico ed inaspettato da poter essere spiegato solo da Dio.
Cerchiamo allora di capire meglio in che modo Gesù è così radicalmente innovativo.
Quando pensiamo alle religioni antiche, generalmente, pensiamo a religioni di natura politeista, come l’ellenismo, che aveva una forte influenza in tutto l’impero romano. Il tratto che legava tutti gli dei di queste variegate fedi era solitamente la potenza e la sovranità sulle cose naturali. Gli dei erano generalmente connessi a cose o eventi naturali, come gli astri e le stagioni, il raccolto e la pesca, il mare, le montagne, i boschi. Concetti personificati, infusi di potenza e dominio su ciò che rappresentavano, e venerati in maniera contrattualistica, in ragione esclusivamente di questa potenza.
In effetti, se non per via della loro autorità, gli dei erano spesso figure non particolarmente nobili. Quando si interessavano agli uomini generalmente non era per benevolenza o pietà, ma piuttosto per diletto: pensiamo alle numerose scappatelle di Giove, o alle sanguinarie mattanze animate da Marte. Nei rari casi in cui provavano pietà, ciò si manifestava con semplici elargizioni di beni od opere sovrannaturali e, comunque, sempre nell’interesse del dio stesso: pensiamo ai miti di Hyacinthos, o di Demetra e Persefone, o al mito di Daphne.
Gli dei emergono sempre e comunque come entità che guardano all’uomo dall’alto al basso, per lo più indifferenti alla sofferenza della condizione umana.
Nella cultura ebraica, d’altra parte, Dio non è umanizzato nella misura in cui lo sono gli dei pagani. Dio non è immanente, non esiste nel mondo, ma trascendente, e per alcuni versi ciò lo rende ancora più irraggiungibile. Certamente nell’antico testamento appare costante il tentativo di Dio di farsi prossimo al Suo popolo, di provvedere per esso, di essere presente con amore paterno. Tuttavia, salvo in alcuni libri come Osea ed Isaia, non c’è dubbio che il punto focale dell’antico testamento sia la sovranità, la giustizia, e la potenza di Dio. A tratti, si pensi ad esempio a Giobbe, il Dio dei Giudei appare quasi come un severo e lontano sovrano cosmico, inavvicinabile e incomprensibile, di cui persino il nome è impronunciabile.
In effetti, nessuno nell’antico testamento vede Dio. Persino Adamo si limita a sentirne i passi e la voce: così fu anche per Abramo ed i Patriarchi, per Mosè, i Re ed i profeti. Le teofanie dell’Antico Testamento sono visioni di angeli o di entità astratte: nubi, fuochi, luci. L’unica apparizione che si avvicina ad una fisicità del divino è forse la affascinante, e misteriosa, lotta di Giacobbe.
Il Dio ebraico è qadosh, santo: cioè puro e totalmente preservato dal peccato. Questo termine ha però anche il significato di separato, posto fuori: Dio è radicalmente separato dal peccato e non può mescolarsi con esso e, dunque, non può mescolarsi con gli uomini, che sono impuri sin dal peccato originale. Il tempio di Gerusalemme, a riprova di questo, possedeva una area sacra dentro il tabernacolo, anche esso considerato sacro: il Qodesh ha-Qodashim o Santo dei Santi, ove era palpabile la presenza di Dio. Solo il Sommo Sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi, e solo una volta l’anno, per pronunciare il nome di YHWH e compiere i riti di espiazione.
Proviamo, senza pregiudizi, a calarci in questo mondo antico, e sforziamoci di apprezzare la portata della assurdità che la buona novella di Gesù poteva avere nel primo secolo.
In un contesto del genere, in un mondo con concezioni teologiche e morali così radicalmente diverse dalle nostre, un gruppo di uomini iniziò a raccontare una storia che non aveva nulla in comune con qualsiasi altra storia mai raccontata prima. Per di più, questi uomini sostennero sino al martirio che ciò che raccontavano non fosse un mito, una fantasia tramandata e romanzata nei secoli, ma bensì un resoconto di eventi realmente accaduti e di cui erano testimoni oculari.
Gli apostoli iniziarono a raccontare che sì, Dio è trascendente, unico e assoluto, come insegnava la tradizione giudaica, ma che questo Dio è sceso dal suo trono, e si è incarnato in un uomo, in una famiglia umile in una regione di periferia del regno di Erode, un nazareno. Che, come se non bastasse già questo, Dio non si fosse incarnato per diletto, capriccio o noia, come usava fare un qualsiasi Zeus o Poseidone: ma si fosse incarnato per servire gli uomini ed insegnare loro il modo giusto di vivere con Dio e con il prossimo. Che avesse condotto un ministero di insegnamento centrato sull’amore e sulla donazione radicale di sé, scontrandosi con le autorità religiose e portando prospettive totalmente rivoluzionarie.
Questo paradosso raggiunge la sua portata massima nel vangelo di Giovanni, dove l’apostolo – o forse Qualcuno che lo ha ispirato – riesce in un capolavoro del paradossale oltre ogni immaginazione. Il vangelo si apre con il celebre Inno al Logos, un prologo che fa coincidere il Dio ebraico con il concetto, divinizzato dai filosofi greci ed in particolare dagli Stoici, del Logos: una divina razionalità, una logica seminale, che sta alla fondazione della struttura di tutte le cose e di tutti i concetti. Il Dio trascendentale ebraico diventa un concetto, insomma, fra i più ineffabili ed elusivi che si possano concepire. Pochi versetti a seguire, però, Giovanni ci colpisce con una dichiarazione assurda: il verbo, il Logos, si è fatto carne.
Così Giovanni racconta la storia di un Logos, che è in verità una persona, che si è incarnato in un uomo, Gesù di Nazaret. Costui, come detto, vive una vita di insegnamento e servizio, arrivando persino, negli ultimi atti della sua vita, a cingersi di un grembiule e a lavare i piedi ai suoi seguaci.
Il gesto della lavanda dei piedi, nel contesto del Vangelo di Giovanni, è più che incredibile. Si tratta di un gesto di umiltà e servizio fortissimo. Sarebbe stato totalmente impensabile che un superiore lo compisse verso un suo sottoposto, pensiamo ad padrone di casa nei confronti del suo servo o un rabbino verso i suoi discepoli. Giovanni invece ci racconta addirittura che un Dio assoluto e sovrano, trascendentale ed ineffabile quanto il Logos dei Greci, si è umiliato nella condizione umana sino a compiere questo gesto per i suoi discepoli, semplici peccatori – il tutto senza mai compromettere la sua posizione di autorità ed anzi, sfruttandola per insegnare che, come lui, anche loro dovranno servire l’uno con l’altro: Gv 13, 16: "in verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato."
Infine, la assurdità definitiva si concretizza in maniera che non si può definire altro che miracolosa nel racconto della croce. Il Dio di Isacco, di Abramo e di Giacobbe, creatore dell’universo, sovrano su ogni cosa, supremo e santo – il Dio di Giobbe, incommensurabile, potente e terribile, oltre ogni giudizio – accetta l’umiliazione, la tortura, e la morte più abbietta che il mondo antico aveva da offrire, riservata ad i ribelli e ai prigionieri politici, tanto terribile da essere considerata quasi una parola proibita: la crocefissione.
Il motivo di tutto questo? L’amore, l’agape, la radicale offerta di sé stesso a vantaggio di tutti gli uomini, riassunta magistralmente da Paolo nella Lettera ai Filippesi 2, 6-8:
6 egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
7 ma svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8 umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce.
Come è possibile che una teologia del genere sia nata ed esplosa con una simile forza, cambiando completamente la storia del mondo nel giro di qualche decennio? Come è possibile che decine di uomini abbiano difeso questa storia assurda, totalmente anacronistica, proclamando di essere testimoni di questi fatti in prima persona, rifiutandosi di rinnegarli fino alla morte per martirio?
Ecco cosa intendevo, sostenendo che Gesù sia un paradosso che solo Dio può spiegare.
Ho scelto di porre Gesù come soggetto del paradosso, anziché il cristianesimo nel suo complesso, perché ritengo che in effetti queste stranezze trovino giustificazione nella personalità stessa del protagonista del racconto evangelico. In effetti, se Gesù il Nazareno da una prospettiva cristiana appare portare a compimento molte delle profezie messianiche dell’antico testamento, da una prospettiva esclusivamente veterotestamentaria, specie calata nell’ebraismo del primo secolo, egli appare invece superarle abbondantemente e, spesso, stravolgerle, sovvertendo le aspettative fra lo stupore – e spesso l’indignazione – dei religiosi del primo secolo.
Per capire come il carattere, la personalità e le azioni di Gesù siano tanto originali da poter dare effettivamente giustificazione a questo paradosso teologico, non possiamo che immergerci nei racconti dei vangeli. In questo articolo ci soffermeremo su come questi aspetti emergano nel Vangelo secondo Luca, in particolare su due racconti tratti da esso.
Introduzione a Luca
Molto succintamente, richiamiamo qualche elemento di contesto per aiutarci ad analizzare i due episodi che andremo a leggere. Anzitutto, ci troviamo nel Vangelo secondo Luca, probabilmente terzo per ordine di redazione, ma primo per rigore di compilazione da un punto di vista storico-biografico.
Luca è un assistente, nonché accompagnatore, di Paolo. Egli segue il “tredicesimo apostolo” attraverso i suoi viaggi e – se l’identificazione con il caro medico Luca della Lettera ai Colossesi è corretta – gli sta accanto sino alla prigionia. Luca è forse un gentile, un non ebreo, o comunque ha una grande attenzione verso il ruolo universale del vangelo. Il Vangelo secondo Luca è l’unico con un prologo che rispetti il formalismo classico e proprio in questa introduzione l’evangelista ci avvisa di non essere il primo a cimentarsi nella compilazione in forma scritta dei racconti, orali, degli apostoli.
Egli dedica inoltre il suo Vangelo a un certo Teofilo, che descrive come qualcuno che è già convertito al cristianesimo. Non possiamo sapere se Teofilo fosse una persona reale o fittizia – il nome Theos-philos, amico di Dio, invita in effetti questa seconda ipotesi – ma in ogni caso rappresentava probabilmente un cristiano gentile, come molti degli uomini incontrati e convertiti da Luca nei suoi viaggi con Paolo in Anatolia ed in Grecia.
Luca 1, 1-4
1 Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 2 come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 3 così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 4 in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Teniamo a mente queste brevi riflessioni e andiamo a leggere il primo episodio su cui ci soffermeremo: la predica a Nazareth ed il rifiuto di Gesù da parte dei nazareni.
La Predica a Nazareth ed il rifiuto del Messia da parte dei Nazareni
Nei versetti precedenti, Gesù è stato battezzato da Giovanni per poi ritirarsi nel deserto, ove ha in solitudine sopportato il peso della tentazione nel digiuno e nella privazione, emergendo trionfante. Questo racconto apre, nel Vangelo di Luca, il ministero di Gesù in Galilea.
Luca 4, 14-30
14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
15 Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
16 Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.
17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:18 Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
19 a proclamare l’anno di grazia del Signore.20 Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
21 Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.
22 Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: “Non è costui il figlio di Giuseppe?”.
23 Ma egli rispose loro: “Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!””.
24 Poi aggiunse: “In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
25 Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese;
26 ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone.
27 C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro”.
28 All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno.
29 Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù.
30 Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Prima di tutto, cerchiamo di capire la scena. I protagonisti sono Gesù e la folla: non vi sono altre figure rilevanti, solo un inserviente è brevemente citato. La parte centrale della scena è la lettura del rotolo di Isaia, che è come incorniciata dai versetti diciassette e venti, i quali raccontano le stesse azioni capovolte: il rotolo viene consegnato, svolto, letto, riavvolto e infine restituito.
Questa cornice aiuta i lettori a concentrarsi sul messaggio che, tramite Isaia, Luca vuole rendere chiaro: Gesù è il Messia che i giudei aspettavano, venuto a liberare gli oppressi e proclamare la grazia del Signore.
Infatti, Gesù annuncia che la profezia di Isaia è compiuta nei suoi giorni, reclamando per sé il titolo messianico. La folla gioisce, e gli rende testimonianza: un verbo che in contesto biblico è sempre positivo. Per capire la seconda parte dell’episodio, dobbiamo cercare di capire quanto importante poteva essere questo momento per la folla: chi era il messia, per i giudei del primo secolo?
Meshiach, in ebraico, significa unto, e si riferisce alla pratica di benedizione tramite unzione con l’olio santo. Questa pratica era riservata a due sole figure nella tradizione ebraica: il Sommo Sacerdote, discendente di Aronne e custode del Santo dei Santi nel tempio di Gerusalemme, oppure il Re di Israele, discendente di Davide, protettore del regno. Le aspettative verso il messia erano dunque fondamentalmente di due nature: regali e sacerdotali.
Nelle varie componenti e correnti di pensiero del popolo ebraico il messia era dunque un uomo che avrebbe liberato il popolo di Israele una volta per tutte, riformando il regno di Davide e stabilendolo a capo di tutti gli altri regni; oppure un santo, un grande profeta, che avrebbe riconciliato definitivamente il popolo ebraico al suo Dio, rinnovando la fede delle genti e ripristinando la santità delle tradizioni. Questi aspetti erano generalmente intrecciati, seppure talvolta uno prevaleva sull’altro. Ciò che però era chiaro è che il Messia sarebbe stato un uomo santo, mandato da Dio come ultimo dei profeti, a vantaggio del suo popolo.
Questo uomo era atteso da centinaia di anni: secoli di combattimento, divisione ed esilio, durante i quali gli israeliti hanno pregato e atteso, talvolta sotto il giogo del dominio straniero. Proprio mentre si svolge questo episodio, Israele è frammentato in più regni, tutti comunque sotto il giogo dei Romani, e persino sul piano religioso vi sono forti divisioni.
Così possiamo solo immaginare la reazione del popolo quando Gesù, dei cui segni miracolosi già si vociferava, si rivela come il messia di Isaia, colmo dello Spirito del signore e venuto a compiere le promesse di Dio. Non solo, ma Gesù è uno di loro, un Nazareno!
Nella seconda parte del brano però, Gesù aggiunge una precisazione, causando un totale cambio di atteggiamento nella folla. Nel versetto ventitré, egli anticipa le richieste dei presenti: “Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!””
Insomma, Gesù immagina che i suoi compaesani chiederanno per sé stessi qualche segno miracoloso, qualche azione salvifica, che dimostri la sua essenza messianica – e, magari, un trattamento preferenziale. Invece, tra i versetti ventiquattro e ventisette, Gesù decide di citare le opere dei profeti Elia ed Eliseo a favore dei non ebrei: la vedova di Sarepta, una pagana che tramite il profeta Elia fu miracolata e salvata dalla fame per molti giorni, ed il lebbroso Naaman, addirittura un generale nemico di Israele, purificato dalla lebbra da Eliseo.
Gesù sta dicendo alla folla qualcosa di sconvolgente: Io sono sì il messia, l’uomo anticipato da Isaia, ma non sono qui solo per voi. Le aspettative che voi nutrite, sono in larga misura sbagliate.
Gesù non chiede alla folla, “siete ugualmente disposti a seguirmi?”: Sa già la risposta. E così i nazareni, che poc’anzi hanno testimoniato la sua pretesa messianica, si infuriano e lo rifiutano, addirittura cercando di metterlo a morte.
Soffermiamoci, per concludere, su un breve dettaglio del testo. Al versetto ventitré, troviamo:
23 Ma egli rispose loro: “Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!””.
C’è qualcosa di bizzarro in questo verso: nel vangelo di Luca, Gesù entrerà a Cafàrnao solo al termine di questo episodio, e precisamente immediatamente dopo, nel versetto trenta. Chiaramente, non si tratta di una svista: abbiamo detto in apertura che Luca scrive almeno per terzo, e conosce bene le sue fonti. Luca decide consapevolmente di anticipare questo episodio all’inizio del ministero di Gesù, come menzionato in apertura. Ma quale è la ragione di questa scelta?
Se daremo uno sguardo ai sinottici, e precisamente a Mc 6, 1-6 e Mt 13, 53-58, scopriremo che gli altri evangelisti offrono una versione piuttosto più succinta dell’evento. Per Luca invece questo episodio è tanto importante da dedicargli molte righe – ricordiamoci che nel mondo antico, la carta è estremamente costosa – e anticiparlo all’apertura del ministero. Utilizzando questo episodio come apertura e dandogli così abbondante rilevanza, Luca vuole dirci qualcosa di importante, che faccia da chiave di lettura di ciò che andremo a leggere poi.
Possiamo ipotizzare che Luca intendesse dare due messaggi fondamentali.
Primo: leggete il resoconto di questo ministero sapendo che Gesù è il messia non solo dei giudei, ma il Messia universale, venuto per tutti i popoli.
Secondo: aprite i vostri cuori, e accettate il messaggio di salvezza di Gesù così come è dato. Non permettete alle vostre aspettative personali di chiudervi al suo messaggio, così come fecero gli abitanti di Nazareth.
Luca, e Gesù, ribadiranno questi messaggi con anche maggiore forza nel prossimo episodio che andremo a leggere: la chiamata di Levi, poi detto Matteo, ed il pranzo con i peccatori.
La chiamata di Levi ed il Pranzo coi Peccatori
Nei versetti precedenti, Gesù è entrato a Cafàrnao, dove ha operato molti segni miracolosi, radunato i primi quattro dei suoi Apostoli, e accumulato una certa fama. Ha attirato anche l’attenzione dei farisei, con cui si è già scontrato.
Luca 5, 27-39
27 Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”.
28 Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì.
29 Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con loro a tavola.
30 I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: “Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?”.
31 Gesù rispose loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati;
32 io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano”.
33 Allora gli dissero: “I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!”.
34 Gesù rispose loro: “Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro?
35 Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno”.
36 Diceva loro anche una parabola: “Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo.
37 E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti.
38 Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi.
39 Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: “Il vecchio è gradevole!””.
Come al solito, partiamo dal testo. Gesù chiama a seguirlo un pubblicano – una sorta di esattore di imposte – di nome Levi, che diventerà poi l’apostolo ed evangelista Matteo. Matteo ha forse già sentito delle opere di Gesù, e possibilmente ne ha viste, e accetta la chiamata con gioia. Decide così di bandire un banchetto, invitando varie sue conoscenze, fra cui anche altri pubblicani, in onore di Gesù.
Il festeggiamento viene visto da dei farisei e degli scribi, che avvicinano i discepoli di Gesù per interrogarli polemicamente sul perché stiano condividendo la tavola con dei peccatori. Gesù interviene rispondendo a tono, ed i farisei cambiano domanda. Gesù risponde allora una seconda volta, questa volta aggiungendo una parabola che chiarisce la natura del suo ministero.
Cerchiamo innanzitutto di capire chi sono Levi e gli altri protagonisti del banchetto, e perché la loro presenza susciti l’intromissione dei farisei. Un pubblicano era un esattore delle tasse, e svolgeva il suo compito collaborando con l’occupazione romana. Se già questo non fosse motivo, per i giudei, di detestare la categoria, si consideri che spesso i pubblicani non erano alle dipendenze dei romani: piuttosto, acquistavano il debito dal governo per poi rivalersi, con gli interessi, sui tassati. Erano dunque quasi degli usurai: certamente dei peccatori rispetto alla legge ebraica, che proibiva il prestito ad interesse fra giudei.
I farisei non si mescolavano con i peccatori, specie a tavola. Motivavano questo atteggiamento sostenendo che essendo i peccatori, per l’appunto, peccatori, non era possibile essere sicuri che avessero rispettato la legge nel preparare i pasti.
In particolare, essi avrebbero potuto ignorare le norme cerimoniali per la preparazione del cibo, o aver acquistato il cibo da mercanti che avevano a loro volta mancato di versare al tempio l’offerta dovuta per le vendite. Il cibo sarebbe stato dunque impuro, e mangiarne sarebbe stato peccato. I farisei stanno dunque, indirettamente, rivolgendo a Gesù e ai suoi l’accusa di essere peccatori.
Un dettaglio curioso: i farisei non approcciano direttamente Gesù, ma mormorano, un verbo utilizzato abbondantemente nell’esodo per descrivere i momenti durante i quali il popolo di Israele, dubitando del Signore, mormorava fra sé criticando le direzioni di Mosè o lamentando il proprio stato. I farisei che criticano Gesù, emulano gli atteggiamenti riottosi dei loro avi, che mormoravano contro Dio.
Gesù interviene, ma non raccoglie l’insinuazione. Invece spiega il suo ministero come il lavoro di un medico, che si interessa dei malati e non dei sani. Così Gesù è venuto a chiamare i peccatori, come Levi ed i suoi colleghi, che sanno riconoscersi tali e chiedere la sua guida: non è venuto per i giusti, o meglio per quelli che si considerano tali non essendolo, e sono incapaci di divenire umilmente suoi discepoli.
I farisei a questo punto gettano la maschera, e accusano direttamente Gesù ed i suoi di essere peccatori: non rispetterebbero il digiuno. I farisei, in effetti, rispettavano assiduamente il digiuno, addirittura praticandolo due volte la settimana. Citando anche Giovanni, però, danno a Gesù l’opportunità di rispondere con una nuova – molto sottile – pretesa messianica. Gesù si identifica con uno sposo, ed i suoi come degli invitati a nozze. Gesù è motivo di gioia e festeggiamento: è colui che doveva arrivare e di cui Giovanni parlava, e poiché è assurdo che si digiuni durante le nozze e a fianco dello sposo, i suoi non digiunano. Essi torneranno a digiunare quando lo sposo sarà loro tolto – un sottile annuncio della Passione.
Per capire questo ragionamento dobbiamo avere chiaro lo scopo ed il significato del digiuno. Il digiuno serve come preparazione spirituale. Ha lo scopo di preparare il proprio stato di coscienza ad occuparsi di bisogni più alti ed intimi di quelli del corpo, negando per un periodo la soddisfazione di questi ultimi. Ha un chiaro significato penitenziale che viene vissuto associandolo alla preghiera.
Nel celebre Discorso del Monte, Gesù criticherà invece l’ostentazione del digiuno, suggerendo quasi di nascondere agli altri quando si sta digiunando. Questo perché l’ostentazione svuota il digiuno del suo significato e scopo, rendendolo una pratica di apparenza, finalizzata a guadagnarsi il plauso delle altre persone.
I farisei in effetti sono spesso accusati di ipocrisia religiosa, e il fatto che utilizzino il tema del digiuno come strumento per attaccare gli apostoli in questa maniera fa pensare che, in una certa misura, essi fossero colpevoli proprio di questo atteggiamento.
A questo punto, Gesù utilizza alcuni esempi per mettere in risalto la differenza tra il nuovo messaggio che il suo ministero sta annunciando, ed il vecchio modo di vivere la fede a cui si aggrappano i farisei.
La prima immagine: non si rattoppa un vestito vecchio tagliando un pezzo dal nuovo, altrimenti si rovina non solo il secondo, ma anche il primo, poiché il rattoppo di tessuto nuovo risalterà sul vestito vecchio, che possiamo immaginare sbiadito.
La seconda immagine richiede un po’ di spiegazione, considerando che pochi di noi sono ancora abituati ad utilizzare otri in pelle o a fare il vino. In antichità, si usava realizzare degli otri con pelle di animale conciata. Invecchiando, questa pelle perde elasticità e diventa più fragile. Il vino nuovo non ha completato la fermentazione, e dunque tende a liberare aria e a gonfiare il contenitore ove viene conservato, se questo è stagno. Dunque il vino nuovo va messo in otri nuovi ed ancora elastici, che possono sopportare la pressione della fermentazione senza rompersi. Se lo si pone in otri vecchi, fragili e non più elastici, si perdono sia gli otri, sia il vino.
Il messaggio di Gesù, insomma, non può essere limitato nelle forme delle vecchie tradizioni, né incarnato dai vecchi uomini religiosi, come i farisei. Gesù non è un riformatore, venuto a incorporare il suo messaggio nelle vecchie interpretazioni. Chiede invece un rinnovamento totale e completo. Diversamente, il suo messaggio non può essere ricevuto.
Queste immagini sono presenti anche negli altri sinottici, in Mc 2,18–22 e Mt 9,14–17, ma Luca aggiunge un’altra osservazione col versetto trentanove:
39 Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: “Il vecchio è gradevole!””.
Luca, come abbiamo detto, viaggia con Paolo e vive in prima persona l’evangelizzazione sia dei gentili che degli ebrei. Possiamo presumere che con questo versetto Luca voglia spiegare la fatica di questi ultimi ad accettare pienamente il messaggio di Gesù, perché questo impone una rottura con alcune concezioni che il popolo ebraico aveva circa l’esclusività del proprio rapporto con Dio.
Questa riflessione ci conduce a ricongiungerci con le conclusioni della analisi che abbiamo fatto della predica ai nazareni. Anche in questo episodio, Gesù e Luca stanno ripetendo gli stessi concetti chiave. Nel parallelo con un medico che cerca i malati, e nella scelta di mangiare a fianco dei peccatori, il Cristo sta ribadendo di essere messia universale; venuto per la salvezza di tutti.
Infine, tramite gli esempi del vestito e degli otri, ecco che ancora una volta è ribadito come il messaggio di Gesù deve essere accettato da ciascuno come trasformativo e rivoluzionario: le aspettative, la storia, il passato – il vestito e gli otri vecchi – non possono essere la chiave di lettura del Vangelo, ma devono essere completamente rimpiazzati da questo.
Conclusione
Analizzando due passi estratti dal Vangelo di Luca abbiamo ricavato due elementi chiave fra quelli che rendono così unico e rivoluzionario il messaggio di Gesù e, in ultima istanza, il cristianesimo: la sua portata universale, cioè la pretesa di abbracciare tutti gli uomini equamente con la propria potenza salvifica, e la sua forte pretesa di verità, che si manifesta come una chiamata a rinnovare noi stessi e conformarci al Cristo, senza cercare di conformare invece il Cristo alle nostre concezioni e abitudini.
Seguendo il ragionamento fatto in premessa, non possiamo non considerare la potenza e la originalità di questi aspetti messi in relazione alla cultura giudaica del primo secolo, fortemente esclusivista, nonché in attesa della restaurazione del regno e del ripristino delle antiche tradizioni, piuttosto che di una rivoluzione interiore e spirituale aperta a tutti, ebrei e gentili!
Vogliamo ribadire che questi elementi non sono asserzioni teologiche prodotte dal ragionamento filosofico, ma piuttosto parte della natura e della personalità di Gesù di Nazareth, ed emergono dal suo modo di comportarsi e dalle sue parole così come ci sono trasmesse dal racconto biblico.
Gesù è un unicum nella storia, ed i due caratteri che abbiamo citato non sono che una parte di ciò che lo rende così straordinario. Come abbiamo citato in premessa, in Gesù convivono la divinità, che egli più volte reclama per sé con autorevolezza e autorità, con una straordinaria umiltà e svalutazione di sé. In altri episodi il Cristo sovverte le forme religiose del tempo, ponendo il valore intrinseco dell’uomo, derivante dall’amore di Dio, come fondamento delle tradizioni e delle regole religiose, e non viceversa.
Gesù si scontra, in favore del popolo e addirittura dei peccatori, con le resistenze delle autorità religiose, che vedono nel suo ministero un pericolo anziché una opportunità di rinascita.
Con il suo modo di proclamare e vivere la sua divinità fra gli uomini, Gesù distrugge definitivamente le basi teologiche che giustificavano l’idea del sacerdote come custode da cui si deve necessariamente passare per accedere a Dio, e che poteva utilizzare questa posizione per opprimere e comandare. Se prima era il sacerdote ad avere accesso esclusivo al divino, come Mosè che si ritirava nella sua tenda per conferire con Dio, e il Sommo Sacerdote che solo accedeva al Santo dei Santi, ora Dio stesso scende fra gli uomini e vive fra loro. In Cristo, il sacerdote custode lascia il posto al sacerdote pastore, che vive fra la gente e per la gente.
Avremmo modo di riflettere su questi e altri aspetti della personalità di Gesù in futuri articoli.
Preghiamo, però, di avere cura di ragionare sempre con cuore aperto sull’esperienza di Gesù: oppure di fronte alla sua forza paradossale ci troveremo come Nicodemo in Gv 3, 9, a chiederci, increduli ed incapaci di raggiungere una conclusione, “Come può accadere questo?”
Articoli Correlati
Ford Madox Brown – Jesus Washing Peter’s Feet
La lavanda dei piedi è un gesto meraviglioso di umiltà, servizio e devozione, non da un servo al superiore, ma…

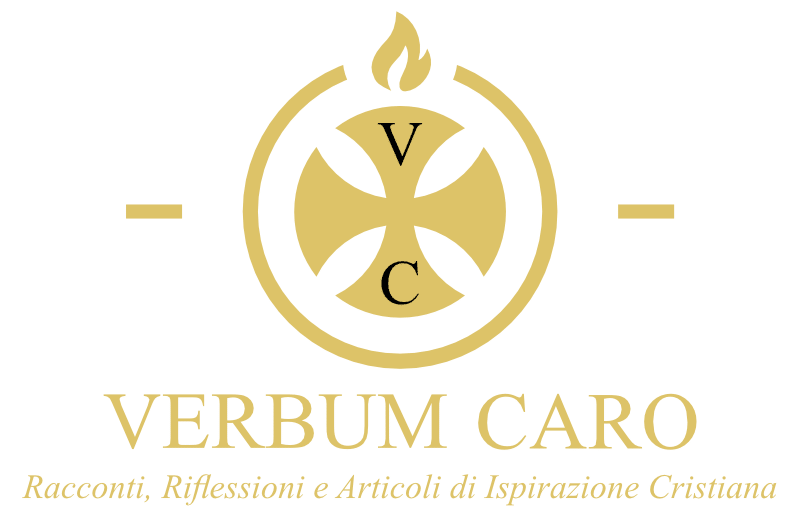

Lascia un commento