Olio su tela, 1854. Hamburger Kunsthalle, Amburgo. Immagine in alta risoluzione disponibile su Wikimedia Commons.
Esodo 3:1-6
1 Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 2 L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3 Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4 Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5 Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». 6 E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.
Tutti conosciamo, più o meno approfonditamente, l’episodio dell’Esodo in cui Mosè incontra il Roveto Ardente, che gli si manifesta come Dio (“Io sono”) e gli comanda di liberare il popolo di Israele dall’Egitto.
C’è un dettaglio di questo episodio che mi affascina particolarmente. Dio ordina a Mosè di togliersi i sandali, spiegandoli che il luogo in cui si trova è luogo sacro. Non è l’unica occasione in cui questo comando si manifesta: in Giosuè 5:15, un angelo impartisce a Giosuè il medesimo comando.
Ma cosa significa «togliersi i sandali» in questo contesto? Vi sono varie interpretazioni nella storia dell’esegesi, a partire da quella ebraica: dalla semplice e diretta idea che togliersi i calzari sia una forma di rispetto dovuta al Sacro, all’idea che i sandali rappresentino in qualche modo i vizi mondani che soffocano il rapporto con il divino.
Tuttavia c’è una interpretazione che mi appassiona in modo particolare, che ho sentito solo brevemente menzionata dal Vescovo Robert Barron in una conversazione con lo psicologo Jordan Peterson. Secondo l’idea del Vescovo, i sandali rappresentano il potere, il controllo su di sé e sulla propria situazione.
Grazie alla calzatura, l’uomo è protetto dai rovi, dalle pietre taglienti, dal terreno arso o gelato. Il sandalo rappresenta dunque il controllo e la padronanza dell’uomo sul suo cammino: l’uomo calzato può affrontare il mondo, decidendo da sé dove andare.
Dio ordina a Mosè e a Giosuè di abbandonare le calzature. E da quell’istante, rispondendo a quell’invito, nessuno dei due avrà più il controllo sulla propria storia. Essi svolgeranno il loro ruolo nel piano divino, cedendo al Signore il pieno controllo sul loro destino: Mosè affronterà l’uomo più potente del mondo antico, il Faraone d’Egitto, e sarà trionfante; Giosuè diverrà il condottiero più famoso del racconto biblico, posizionando di fatto il popolo di Israele nella terra promessa.
Seguendo il racconto della Lettera di Martinus da Knossos, mi sembra sia proprio questa l’essenza dell’eroismo: riconoscere di essere di fronte ad una storia più grande e meravigliosa di noi, ed accettare di svolgere la parte che il destino chi chiede. L’eroe, in qualche modo, si leva i sandali, e cede al Bene il controllo della propria storia.
Ma cosa c’entra tutto questo con l’opera che ho scelto per il racconto, che rappresenta dei pescatori nella tempesta? Chiaramente il dipinto ha una affinità con la storia dei Sette Eroi di Knossos, che racconto nella lettera, ma non si tratta solo di questo.
Se l’essenza dell’eroe si trova nello svolgere il proprio dovere accettando di cedere al fato il controllo sulla propria vita, mi sembra che il pescatore, nella sua umiltà, sia una figura quasi intrinsecamente eroica. L’uomo che prende il mare, infatti, è simile all’uomo che si è levato i sandali nel sacrario: nel momento in cui la barca si stacca da terra, il pescatore non è più in controllo; ha ceduto alle acque il potere di compiere la propria impresa, oppure di reclamare la propria vita.
Per questa affinità tematica, oltre che atmosferica, ho scelto questa opera. Scrivendo infine questo ultimo paragrafo, e ragionando attorno al potere enorme che il mare – al contempo generoso provvedente o terribile tiranno – esercitava sull’uomo antico e sul suo immaginario, mi è venuto alla mente l’episodio in cui Cristo calma la tempesta.
Se è vero che Gesù è il più grande degli eroi, perché accetta con obbedienza il ruolo che il Padre ha disposto, è anche vero che Egli è Colui a cui persino il mare, simbolo per eccellenza dell’imprevedibilità e della crudeltà del fato, deve obbedienza.
Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che moriamo?». Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?»
MARCO 4:37-41
Articoli Correlati
Knossos, Porta dell’Occidente
Martinius approda a Knossos, ultimo porto dell’occidente prima dell’oceano. In questo luogo, si trova a riflettere sulla natura dell’eroismo….

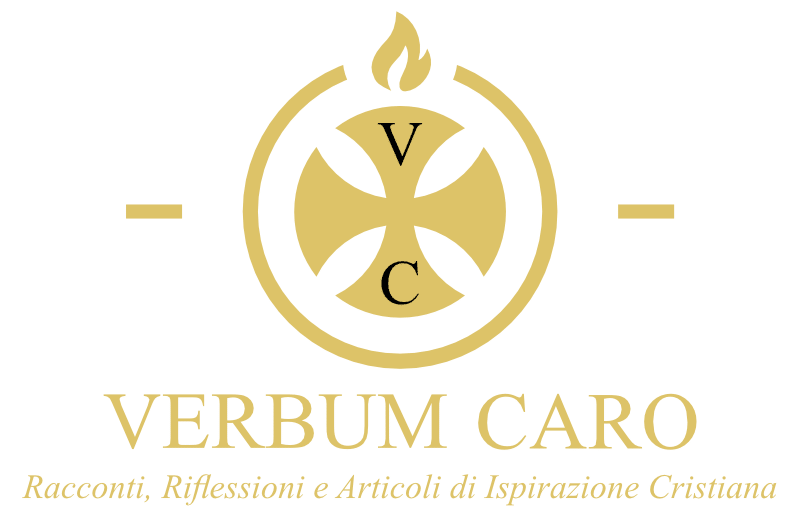

Lascia un commento