Veniamo alla terza parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. In questa parte parleremo della coscienza umana, luogo dove ciascuno vive intimamente l’esperienza morale.
L’Idea della Coscienza
L’esperienza morale umana si manifesta esteriormente nei comportamenti che ciascuno pone in essere. Tuttavia, il luogo dove ciascun uomo elabora la propria riflessione morale e prende le proprie decisioni è un luogo interiore, non esteriore.
Quando parliamo di coscienza, ci riferiamo a volte alla esperienza cosciente umana nella sua totalità – la consapevolezza, insomma, che l’uomo ha di essere ed esistere, il suo pensiero, la sua riflessione, il suo “monologo interiore”.
Tuttavia, in ambito della teologia morale, quando parliamo di coscienza intendiamo invece un luogo più intimo e preciso della interiorità umana. Vi è, nel cuore di ogni uomo, un luogo particolare dove egli si interroga in ogni momento sul quale sia l’azione corretta da intraprendere: una parte della sua psiche che lo invita costantemente a compiere il bene, e lo accusa quando egli compie invece il male. In questo luogo di sé, quello che prima abbiamo citato come “monologo interiore” assume invece una forma di dialogo: la coscienza è il luogo dove l’uomo si confronta con Dio.
Il Gaudium et Spes, definisce così la coscienza:
La Coscienza è il nucleo più segreto ed il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria.
La coscienza umana è il luogo fondamentale ed individuale della relazione col bene, con la verità e con Dio. Nessuna riflessione morale può essere proposta senza tenere conto di essa.
Questa idea, in effetti, non è esclusivamente cristiana, né esclusivamente biblica. Già Socrate, nel V A.C., parlava di daimon, una sorta di spirito o voce interiore che perseguita l’uomo, spronandolo a perseguire la verità ed il bene in ogni momento.
Nella cultura ebraica, e nell’antico testamento, il centro di questa esperienza è il cuore, lêv. Le qualità morali dell’uomo, la compassione, la volontà di giustizia, l’irrequietezza di fronte al male, i suoi sentimenti, nell’immaginario ebraico sono strettamente legati alle sue viscere – un idea che, in qualche modo, comprendiamo ancora oggi (qualcosa di crudele o ingiusto ci fa “rivoltare lo stomaco”).
Nel cuore ebraico vi è una dimensione dinamica dell’alleanza con Dio, una sorta di continua necessità di confermare e rinnovare i termini del patto abramitico di fronte alle continue avventure – positive e non – del popolo di Israele. Vi è però anche una dimensione dialogica: il fedele non è infatti mero esecutore del volere divino, ma collaboratore attivo del disegno di Dio. Egli si relaziona ai comandi del Signore e gli adempie secondo la sua individualità – o li rifiuta, dando origine al peccato.
Nel Nuovo Testamento
Come accennato, la coscienza è poi un elemento fondamentale nella riflessione morale cristiana.
Già nella scrittura, San Paolo introduce il tema della coscienza, sopratutto a partire da esperienze pratiche. Egli utilizza il termine synéidēsis, che in greco significa percezione dei propri pensieri, percezione del bene e del male, parlando di alcuni casi di valutazione morale discussi dai suoi discepoli: ad esempio, se fosse accettabile mangiare la carne sacrificata dai pagani ai loro déi, o partecipare ai banchetti in onore di questi, o ancora se fossero necessarie o giuste certe pratiche ascetiche.
San Paolo reitera la dimensione dialogica della coscienza, già nota agli ebrei. L’uomo vive l’esperienza morale nella sua interiorità, e da questo non è possibile prescindere. È infatti prima di tutto la coscienza che ha il compito di testimoniare al fedele la bontà della sua condotta, o di condannarlo in caso di errore.
2Cor 1,12: Questo infatti è il nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e sincerità che vengono da Dio.
San Paolo introduce due elementi importanti, forse non così marcati nell’esperienza precedente. Il primo, la coscienza, pur essendo il luogo di relazione con Dio, può essere corrotta o ignorante, e condurre l’uomo in errore. Così essa deve essere sempre sottomessa al giudizio ultimo di Dio: essa deve interpretare la Legge e applicarla nella vita quotidiana e concreta, non può mai farsi legge da sé.
Questo processo di continuo perfezionamento del sentimento individuale nella parola divina è necessario per via della natura caduta dell’uomo. Il desiderio di una totale indipendenza e assolutezza da Dio, che nella genesi è spiegato con il racconto metastorico della caduta, conduce l’uomo a crearsi un proprio ed imperfetto “bene”. L’uomo caduto soffoca e aggira con varie razionalizzazioni ciò che gli perviene dalla coscienza per assecondare i desideri terreni: il piacere, il potere, la ricchezza, la reputazione…
Per questo motivo, la coscienza va continuamente purificata e addestrata nella parola divina, e così facendo l’«agire secondo coscienza» diventa «agire nella volontà di Dio». Diversamente, l’agire secondo coscienza si riduce all’agire secondo il proprio personale arbitrio.
Inoltre, la coscienza è una esperienza universale, propria dell’uomo e quindi anche dei pagani. La colpevolezza per il male o l’orgoglio per il bene possono essere dunque, anche nei non cristiani, segni di una esperienza di dialogo con il Divino. Poiché Cristo è morto per la redenzione di tutta l’umanità, egli costantemente cerca di raggiungere ogni uomo: e ciò accade proprio nella individuale interiorità di ciascuno.
Rm 2, 14-15: Quando i pagani, che non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la Legge, essi, pur non avendo Legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono.
Nella Tradizione Cattolica
I padri della Chiesa si sono estensivamente interrogati sulla natura della coscienza, proponendone varie interpretazioni. Per Origene (184-253), essa è il luogo ove risiede lo Spirito Santo che guida l’uomo nelle decisioni; vivere secondo coscienza è dunque vivere secondo spirito; per Sant’Agostino (354-430), la coscienza è la sede di Dio nell’uomo.
Queste considerazioni rispondevano alla domanda che spontaneamente sorge dalla lettura degli ultimi atti dei Vangeli:
Gv 14:26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Cristo ascende al Padre, ma al suo posto concede ai fedeli l’aiuto dello Spirito Santo, affinché sia per loro testimone di ciò che è bene e ciò che è male. Ma dove, praticamente, si svolge questo confronto dialogico con lo spirito? Questo avviene nella coscienza dell’uomo: ed ecco che lo Spirito Santo sembra improvvisamente svolgere un ruolo tanto simile a quello del daimon di cui Socrate aveva parlato.
Nel medioevo, San Tommaso d’Aquino, uno dei più celebri teologi della storia cattolica, interpreta la coscienza come razio pratica, esperienza razionale che valuta le azioni umane rispetto alla Legge divina, deducendo dal generale – il comandamento – il particolare del comportamento corretto in ogni situazione. L’intelletto pratico è formato dalla virtù della prudenza, cioè quella caratteristica umana che spinge a giudicare ogni situazione valutando secondo la ragione il giusto comportamento e rifuggendo i giudizi affrettati. Così la mente guida il giudizio ad applicare i comandi di Dio senza sbagliare.
San Bonaventura, amico di Tommaso e Ministro Generale dell’Ordine Francescano, interpreta invece la coscienza come sede della volontà divina: la coscienza è il luogo dove Dio – ancora tramite lo Spirito Santo – fa palese agli uomini la propria volontà, e dove l’uomo ha la possibilità di fare propria tale volontà, oppure di rifuggirla. Le due visioni colgono due aspetti complementari e non in contraddizione di questa dimensione umana, e tuttavia non scindibili: non sono due “parti” della coscienza, ma due possibili e parziali descrizioni di essa.
Il periodo rinascimentale vede una evoluzione abbastanza tormentata del concetto. A seguito del Concilio di Trento, la Chiesa vede un irrigidimento della sua riflessione morale attorno al concetto della penitenza. Ciò era funzionale a fare fronte alla dottrina protestante, che negava la necessità della confessione sacramentale, e tuttavia aveva portato ad una certa limitazione della riflessione etica. In questo clima, la Chiesa si trova coinvolta tra due correnti intellettuali contrastanti.
La prima, legata al pensiero gesuita, era focalizzata al primato della vita secondo coscienza, e cercava in qualche modo di riformare l’impostazione eccessivamente normativa del periodo. Secondo i gesuiti, l’uomo doveva cercare il bene in maniera pienamente libera, valutando secondo la propria esclusiva interiorità ciascun caso morale. Questa corrente di pensiero portò ad un certo lassismo morale, ad una deviazione personale ed individuale da ciò che la norma biblica prescrive. Questo effetto contribuì in parziale misura alla prima soppressione della Compagnia di Gesù.
La seconda corrente di pensiero, legata sopratutto ad intellettuali domenicani, enfatizzava il primato assoluto della legge sulla coscienza. Anche questo pensiero, rispetto alle evoluzioni successive, portava in sé un errore. Negando la necessità di una comprensione e di una partecipazione genuina alla volontà di bene, si spoglia l’uomo dalla propria esperienza del bene stesso, negandogli di collaborare in maniera autentica alla volontà divina.
Influente fu il pensiero di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che cercava di unire le due prospettive: la coscienza morale promulga la legge divina nella persona, permettendole di farsi liberamente collaboratrice del progetto divino. In altre parole è fondamentale che la coscienza accolga, rifletta e comprenda la prescrizione divina, e poi la applichi, facendola propria, nella vita quotidiana. Questa educazione della coscienza trova la sua espressione principale nella comunità, nella catechesi, nella pastorale.
Dopo il Concilio Vaticano II
Il Concilio Vaticano II è un momento fondamentale per la riflessione morale della chiesa.
Nella prima metà del XX secolo, il pensiero personalista del teologo laico Emmanuel Mounier aveva acquisito una significativa influenza. Mounier, non trascurando la oggettività e la assolutezza della legge morale, aveva messo nuovamente l’accento sulla libera adesione della coscienza alle norme morali, recuperando il pensiero di de’ Liguori.
Tra il diciannovesimo e ventesimo secolo questo pensiero era infatti nuovamente scemato in favore di un approccio casuistico, che valutava a livello ecclesiale i giusti comportamenti caso per caso, limitando l’esperienza individuale.
La discussione conciliare fu certamente influenzata dal pensiero di Mounier, che tentò di coniugare con un ritorno alle origini del pensiero morale cattolico. Si cercò di recuperare i fondamenti della Scrittura e sopratutto gli insegnamenti dei padri della Chiesa. Centrale è il tema della coscienza, a cui la costituzione Gaudium et Spes dedica l’intero capitolo 15, posto – non casualmente, ma in ossequio al pensiero tomistico e quello di Bonaventura – fra il capitolo dedicato alla ragione ed il capitolo dedicato alla libertà.
Viene recuperata la tradizione patristica, ed in particolare di Sant’Agostino, che vede la coscienza come sacrario dell’uomo, il luogo preposto ad ospitare Dio e dove si manifesta il dialogo interiore tra Egli e l’uomo. In riferimento alle visioni tomistiche – la coscienza come luogo della ragione morale – e di Bonaventura – coscienza come luogo della volontà – viene ribadita una visione unificata della coscienza, che non può essere scissa, se non per ragioni descrittive, in parti distinte. Entrambi gli elementi sono dunque confermati, ed inquadrati in quella relazione dialogica, fatta di discernimento, ragione, ma anche accettazione e resa, che l’uomo ha con lo Spirito Santo.
Il Concilio, ritornando a San Paolo, ribadisce che la coscienza è disponibile a tutti gli uomini in quanto figli di Dio, e che l’umanità intera, nel proprio cuore, cerca il sommo bene che è Dio. Tuttavia, l’uomo può agire contro la sua coscienza, o rifiutarne il consiglio. Il peccato, se ripetuto e perseverato, ha l’effetto di assopire ed in definitiva accecare la coscienza.
L’effetto di queste considerazioni è un importante impulso alla riflessione sulla Teologia Morale, che ritorna nuovamente ad interessarsi dei fondamentali della esperienza morale partendo dalla lettura delle Scritture.
Tipi di Coscienza
La riflessione sulla coscienza porta dunque ad identificare delle caratteristiche o dei tipi di coscienza, in funzione di come essa si relaziona ai componenti fondamentali dell’esperienza morale.
Don Mattia Francescon propone una descrizione catechetica della coscienza, in funzione di queste componenti:
In rapporto al Tempo
Il giudizio di coscienza si definisce:
– antecedente, se precede l’azione giudicata. In questo caso, la coscienza può prevenire o causare l’azione.
– concomitante, se accompagna l’azione giudicata. La coscienza vive l’esperienza immediata del bene o del male, accompagnando l’agire con un senso di gioia o di accusa.
– conseguente, se si riferisce ad una azione già compiuta. In questo caso la coscienza può confermare l’azione o indurre il pentimento; per il cattolico, invocando il desiderio della confessione.
In rapporto alla Norma Morale
La coscienza si può definire vera se il suo giudizio coincide con quello divino, cioè con la norma morale. Altrimenti è definita erronea. In questo secondo caso, si può ulteriormente valutare se l’errore è causato da una ignoranza invincibile.
Se l’individuo non ha la possibilità, per esempio per condizioni di educazione, contesto, o indisponibilità di modelli positivi, di riconoscere l’errore, ad esso non può essere attribuita una colpa. Questa condizione è delicata, in quanto va valutata rispetto alla situazione complessiva dell’individuo, tenendo conto del suo interesse o disinteresse a correggere sé stesso e degli sforzi compiuti in tal senso.
Si tratta, comunque, di una sfumatura: raramente l’ignoranza è perfettamente invincibile, così come raramente la coscienza è perfettamente consapevole.
In rapporto al Giudizio in sé
La coscienza si può definire certa se emette un giudizio con sicurezza. Diversamente è definita dubbiosa. Il dubbio riguarda la condizione di incertezza sulla liceità o illiceità di un comportamento, e può essere sia positivo, ad esempio quando incita la persona a mettere in discussione la liceità di un suo comportamento in contrasto con la norma, che negativo, quando sospende inutilmente l’azione o causa angoscia immeritata.
In rapporto all’Abitudine
In base alla consistenza nel tempo e allo stile di giudizio di una coscienza, la definiamo:
- delicata, quando in ogni momento e anche negli atti più semplici cerca di giudicare rettamente il da farsi per rispettare la norma divina, con equilibrio e misura;
- scrupolosa, quando tende a trovare in ogni situazione motivo di male, anche laddove non ve ne sia;
- lassa, quando tende invece a trovare in ogni situazione una giustificazione per le proprie deviazioni dalla norma.
In rapporto alla Responsabilità
Definiamo infine la coscienza, in base alla responsabilità con cui si esprime il giudizio:
- retta, se si adegua al giudizio della ragione con prudenza;
- distorta, se ignora il giudizio razionale e agisce in maniera imprudente ed non ragionata.
Il Dialogo della Coscienza
Se il pensiero umano è generalmente immaginabile come un monologo, la coscienza va vista invece come un dialogo. La coscienza è sempre relazione, anche quando apparentemente parla con sé stessa.
Identifichiamo quattro forme di relazione nella coscienza.
Con sé stessa
Definiamo questo dialogo l’autocoscienza, l’io, la riflessione su di sé e sul perché delle proprie scelte. In ogni momento e azione la persona cerca una fedeltà a sé stessa, ed in questa ricerca di fedeltà è costruita la persona stessa. Ogni scelta non è mai ripetizione, ma piuttosto conferma o rinnovamento. Nel dialogo della coscienza con sé stessa trova luogo la sua parte più intima, che include affetti ed emozioni, così come virtù e vizi.
Ogni persona ha un set di reazioni immediate, non riflessive, per rispondere prontamente alle situazioni immediate, alle emergenze e alle tentazioni. Esse sono costruite negli anni e nella vita delle persone dall’accumularsi delle scelte razionali, e possono essere altrettanto descritte da vizi e virtù.
Con Dio
La coscienza cerca continuamente Dio, anche quando non lo riconosce. L’uomo continuamente dialoga con quel Summum bonum, che i fedeli riconoscono come persona, ma che chi non crede può comunque percepire come un assoluto o vari assoluti. È il luogo dei valori ultimi e fondamentali; del “senso ultimo” che ciascuno riconosce per la sua vita. Esso trascende sempre l’uomo, eppure si trova dentro di lui. È principalmente tramite il rapporto con questo sommo bene l’uomo definisce sé stesso.
Con il Contesto
Il contesto di vita di una persona, l’ambiente, la società, la famiglia, gli amici, eccetera, penetra continuamente nell’intimo della sua coscienza. La coscienza è in costante dialogo con questi stimoli, vagliandoli e decidendo quali valori o disvalori integrare o rigettare. Nessun uomo è impermeabile alla propria cultura, ma diventare coscienti di questo continuo attacco – positivo e negativo allo stesso tempo – aiuta l’uomo a trascenderne le influenze.
Con la Norma
Infine, l’uomo dialoga con la norma. La consapevolezza di cosa è bene e di cosa è male non conduce automaticamente a commettere il primo e rigettare il secondo, come ipotizzava l’etica socratica. L’uomo, essendo libero, è in costante relazione con la norma, ed in ogni momento razionalizza le sue decisioni, ignorandola o applicandola.
Vizi e Virtù
Attraverso la vita e le scelte ripetute della persona, la coscienza assume alcune caratteristiche buone o cattive, che la aiutano ad orientarsi verso il bene od il male.
La tradizione cristiana distingue le virtù umane, che l’uomo può procurarsi in qualche modo da solo, dalle virtù che sono esclusivamente derivanti dal rapporto con Dio, dette virtù teologali.
Si possono elencare moltissime virtù umane, ma tradizionalmente si considerano quattro virtù fondamentali da cui derivano tutte le altre, dette cardinali:
- La prudenza, ovvero la capacità di discernere con cautela il bene ed il male in ogni momento.
- La giustizia, ovvero la disposizione a rendere a ciascuno ciò che merita; a Dio, l’adorazione, agli uomini, l’amore fraterno; al bene commesso, la lode, al male, la condanna.
- La fortezza, cioè la forza d’animo necessaria ad agire con prudenza e secondo giustizia in ogni situazione, anche nelle situazioni che spaventano o mettono in pericolo la nostra integrità o vita.
- La temperanza, cioè la capacità di governare le passioni, di mantenersi lucidi ed efficaci nelle decisioni.
A queste virtù, da cui discendono tutte le virtù umane, si aggiungono le virtù prettamente divine, cioè che l’uomo riceve in varia misura solo nel rapporto con Dio:
- La fede, cioè la capacità di affidarsi alla guida e al giudizio divino incondizionatamente;
- La speranza, cioè la fiducia seria e concreta che, in ultima istanza, il bene è destinato a trionfare sul male ed ogni sofferenza sarà compensata;
- La carità, intesa non come semplice solidarietà, ma come dono completo, incondizionato e disinteressato di sé per il prossimo.
Queste virtù sono definite teologali, e la loro discendenza dal rapporto con Dio, che è evidente per la fede, è altrettanto chiara per la speranza e la carità se si pensa al significato che questi atteggiamenti assumono in mancanza di un Bene Sommo destinato in ultima istanza a trionfare, giudicare il male, e compensare il bene.
In un mondo “senza Dio”, infatti, che senso ha la speranza, così come la abbiamo definita? L’osservazione del mondo così come è non può condurci ad una genuina fiducia nel trionfo del bene, e se lo facesse, non sarebbe certo nulla di razionale, ma piuttosto un ostinato e irragionevole ottimismo.
Simile ragionamento può essere dato per la carità. In ultima istanza, se questa è la sola esistenza che ci è data, possiamo considerare ragionevole la solidarietà e l’aiuto reciproco nella misura in cui agevolano e rendono più piacevole la nostra convivenza. La carità, tuttavia, è qualcosa che supera queste forme, richiedendo un dono super-erogatorio, totale, disinteressato e gratuito della propria persona: il sacrificio del Cristo ne è l’esempio principale.
Un simile disprezzo di sé a favore del prossimo è assurdo ed irrazionale in un mondo senza Dio. Così, eliminando Dio dal quadro, fede, speranza e carità, cessano di essere virtù e diventano semplicemente i tratti distintivi di un bonario sciocco.
In questa misura esse sono virtù teologali, poiché possono esistere pienamente solo nel rapporto con il Divino.
Articoli Correlati
Appunti di Teologia Morale – Il Giudizio
Veniamo alla quarta parte dei miei appunti di Teologia Morale. Parleremo del giudizio morale di fronte ad una azione o…
Appunti di Teologia Morale – La Bibbia e la Norma
La seconda parte dei miei appunti di Teologia Morale. In questa parte parleremo di etica nel raccondo biblico e di…
Appunti di Teologia Morale – Introduzione
Ecco la prima parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. Introdurremo la riflessione morale in genere….
Un Corso di Teologia Morale
Ho partecipato ad un corso di introduzione alla Teologia Morale Fondamentale. Vi racconto come è andata, e condivido con voi…

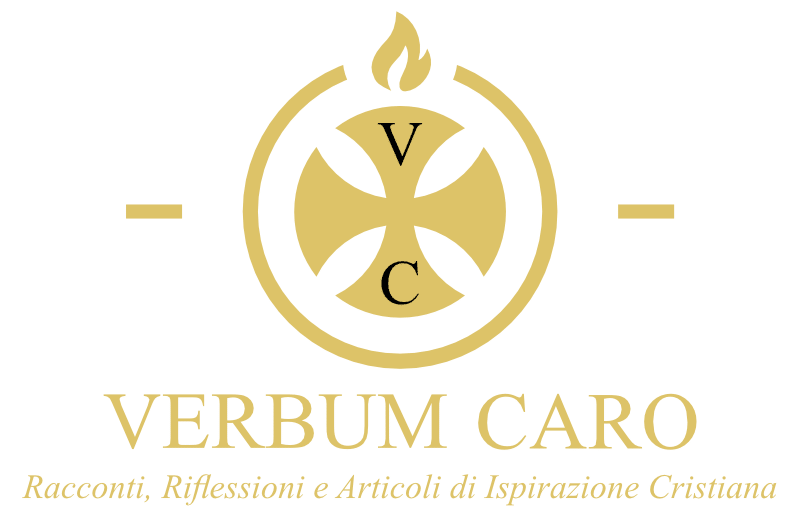


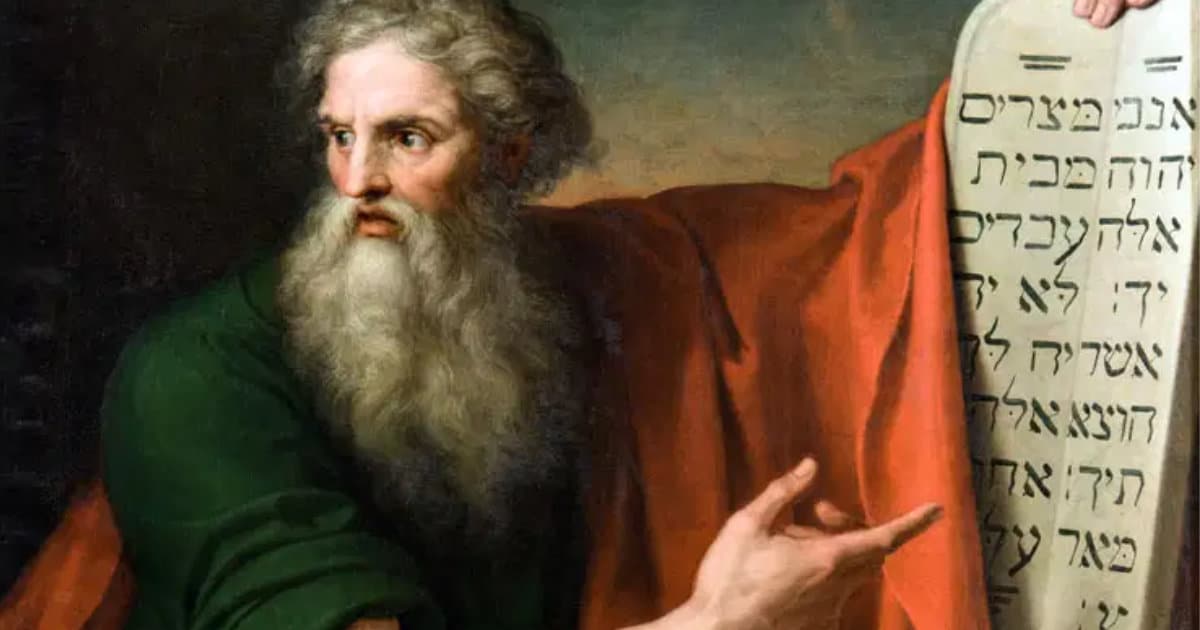


Lascia un commento