Veniamo alla seconda parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. In questa parte parleremo del fenomeno morale nel raccondo biblico e della norma morale cristiana.
Teologia Biblica dell’Esperienza Morale
La Sacra Scrittura è una fonte fondamentale per la riflessione morale cristiana. Dalla Scrittura emergono, al contempo, i principi fondamentali del giudizio e dell’esperienza morale e la norma morale che l’uomo è tenuto a rispettare. Come detto nell’introduzione, la teologia morale fondamentale non si occupa delle specifiche prescrizioni della norma, e dunque ciò non sarà coperto da questi appunti, tuttavia vedremo brevemente quali sono le fonti bibliche principali per queste prescrizioni.
Antico Testamento
Nell’antico testamento, l’esperienza morale è legata strettamente all’alleanza che Dio concede all’uomo. Poiché Dio gratuitamente ha eletto il popolo di Israele ponendolo sotto la propria protezione, sin dalla promessa fatta al patriarca Abramo, questo popolo è tenuto a rispettare la Sua legge come termine dell’alleanza. La richiesta morale che Dio estende al popolo di Israele si esprime in tre modi, che formano una unità, non una contraddizione: la legge, la profezia e la sapienza.
La legge è data al popolo ebraico prima di tutto attraverso il Decalogo, le tavole delle leggi consegnate a Mosè sul Sinai. Il decalogo contiene i principi generali della norma morale, le norme fondamentali da cui derivano tutte le altre. Tuttavia attraverso il racconto biblico la parola di Dio si manifesta anche attraverso fonti secondarie: il Levitico, il Deuteronomio, gli insegnamenti rabbinici in genere.
Tuttavia, il popolo, ed i regnanti in particolare, non infrequentemente deviano dalla legge. Talvolta la ignorano, si dedicano al male anziché al bene, e sprofondano nel lassismo morale o nella disobbedienza – si pensi all’adulterio di Davide e Betsabea. Altre volte invece travisano la legge, adottando uno scrupoloso ed eccessivo legalismo che dimentica il principio fondamentale dell’Amore Divino.
Dio allora invia a Israele dei Profeti, uomini carichi dello Spirito che esortano il popolo e lo riconducono a ciò che è fondamentale. Spesso i profeti si fanno carico delle sofferenze degli ultimi del popolo; sono voce di denuncia sociale e di richiamo ad un rapporto con Dio e la sua legge che sia di cuore e non invece di apparenza.
Infine, vi è l’esperienza personale dell’individuo che aspira ad essere saggio, a capire cioè intimamente come adempiere al volere di Dio e vivere una vita giusta e piena. Tale è l’esperienza Sapienziale: libri come i Proverbi, Giobbe, ma anche i Salmi, ed i più tardivi Sapienza, Qoelet, Siracide. Questi trattano delle profonde domande esistenziali dell’uomo nel suo rapporto con Dio, con la sofferenza, con la coscienza, con il prossimo. Questi libri propongono modelli ed ispirazioni per la vita del sapiente; e la Sapienza, in effetti, è la prima e la più importante delle virtù umane, da cui deriva il discernimento del bene e del male.
Excursus: Il Decalogo
Rielaborazione sintetica de PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, Documenti vaticani, LEV, Città del Vaticano 2008, n. 25-32. Si rimanda al testo originale per approfondire.
Per capire l’importanza del Decalogo, è fondamentale vedere questo assieme di precetti nel contesto in cui esso compare nel racconto biblico.
Gli ebrei sono usciti della schiavitù d’Egitto, ed ora sono liberi. Ma la nuova liberà è anche una responsabilità: il popolo è privo di vincoli e di riferimenti e – non a caso – vaga nel deserto.
Subentra così la necessità urgente di darsi un ordine sociale. Ora che gli ebrei non sottostanno più alle leggi e al comando del faraone, devono darsi delle leggi per poter convivere. È Dio, Colui che in primo luogo ha liberato Israele, a fornire queste leggi.
Ecco allora che il Decalogo può essere visto come una sorta di carta costituzionale del popolo di Israele, sia dal punto di vista morale che civile: esso in effetti è la prima organizzazione di una gente che ha finalmente ottenuto la libertà. Questa legge va vista allora come un dono di Dio al suo popolo, e non già una imposizione: come Dio nutre i corpi della gente di Israele col dono della manna, così nutre il futuro regno con un ordine giuridico e morale.
I comandamenti non vanno visti come una norma morale basilare, rozza e arcaica, ma piuttosto come una carta fondante della morale biblica. Se a prima lettura i comandamenti possono apparire come una semplice lista di prescrizioni e divieti, è importante capire che ciascun comandamento sottende un valore fondamentale, da cui deriva ogni altra norma specifica: nella tradizione rabbinica, i 613 precetti.
Vediamo come è possibile riesprimere il decalogo in termini valoriali.
| Comandamento | Valore Sotteso |
|---|---|
| 1. Io sono il Signore, tuo Dio… Non avere altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine… Non ti prostrerai davanti a quelle cose… | Fedeltà a Dio rifiuto dei falsi idoli. |
| 2. Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio… | Rispetto delle cose sacre. |
| 3. Osserva il giorno di sabato per santificarlo… | Rispetto del tempo, e della sua dimensione sacra. |
| 4. Onora tuo padre e tua madre… | Rispetto verso la famiglia. |
| 5. Non uccidere. | Diritto alla vita. |
| 6. Non commettere adulterio. | Sacralità ed esclusività del matrimonio. |
| 7. Non rubare.* | Libertà e la dignità dell’individuo (e, secondariamente, dei suoi possedimenti.*) |
| 8. Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. | Rispetto per la verità e la reputazione degli altri. |
| 9. Non desiderare la moglie del tuo prossimo. | Rispetto verso la famiglia (altrui) e le comunità in generale. |
| 10. Non desiderare la casa del tuo prossimo… né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. | Rispettare la proprietà privata. |
| *in ebraico, il termine utilizzato condivide il campo semantico con “non rapire”. |
Così espresso il decalogo rappresenta un assieme di valori fondamentali, posti per altro in una scala gerarchica in ordine di importanza. Esprimere i precetti del decalogo in forma di valori, inoltre, non diminuisce in alcun modo la forza delle proibizioni espresse, anzi aumenta il campo di applicazione della norma, superandola e completandola.
In questi termini, appare per altro più immediato leggere il decalogo come un dono della rivelazione divina. La lettura meramente legalistica ne esce depotenziata, e traspare con forza l’intento del legislatore: l’armonia e l’Amore fra l’uomo e Dio, e fra l’uomo ed i suoi simili.
In questo senso è quasi anticipata la rivelazione di Gesù, che, come vedremo, completa e non sostituisce la legge mosaica. Completare la norma significa proprio il riportare la Legge nel quadro dell’Amore divino non può esaurirsi nel precetto in sé, ma affiora dal valore fondamentale che il precetto ha lo scopo di tutelare.
Nuovo Testamento
Nel nuovo testamento la legge mosaica trova compimento nella vita perfetta di Gesù. L’insegnamento morale del nuovo testamento per lo più non ha una forma legalistica, ma si manifesta piuttosto con gesti concreti, insegnamenti pratici, ed, in ultima istanza, tramite l’obbedienza supererogatoria di Gesù al Suo compito.
Si possono in ogni caso individuare alcuni momenti e concetti fondamentali dell’insegnamento morale di Gesù, all’interno dei Vangeli.
Il discorso della montagna (Mt 5-7) è ritenuto giustamente una sorta di magna charta della morale cristiana. La premessa al discorso sono le beatitudini, una sorta di identikit del tipo umano attraverso cui si manifesta la presenza e l’amore di Dio nel mondo. Distruggendo alcune concezioni tipiche del primo secolo che vedevano nel derelitto il punito da Dio, attribuendo la sofferenza umana al peccato, Gesù identifica invece come amati da Dio, o beati, gli ultimi, i perseguitati, gli affamati di giustizia insoddisfatti della giustizia umana, i miti, i sofferenti.
Il discorso che segue, poi, passa letteralmente a rassegna la legge mosaica e, senza mai negarla o abrogarla, la arricchisce di un significato e una potenza anche maggiore, confrontando l’interpretazione legalistica antica (avete sentito che…), con l’antitesi, la Legge riletta nel contesto dell’Amore di Dio (ma io vi dico…).
Altro concetto fondamentale è il duplice comandamento dell’amore, presentato come primo comandamento, o meglio come sintesi di tutti i comandamenti: Amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore… (i comandamenti verticali, i primi tre del Decalogo) e Amerai il prossimo tuo come te stesso (i comandamenti orizzontali, gli ultimi sette). In questo quadro va letta anche la celebre regola d’oro: fa agli altri ciò che desideri sia fatto a te.
Infine, il comando apostolico di seguire Cristo. Seguire Cristo è risposta morale alla rivelazione Divina, che ci chiama a condividere la sua vita, a scegliere di rinunciare se necessario persino ai nostri cari e ai nostri beni, facendoci carico della croce. San Paolo esprimerà universalmente questo concetto parlando di imitazione del Cristo attraverso la nostra vita.
L’atto morale fondamentale di Gesù è di natura eroica. Gesù obbedisce a Dio oltre a quanto è richiesto al singolo uomo: Egli si fa carico, pur essendo senza macchia, di tutti i peccati degli uomini, e muore la terribile morte di croce. Con questo atto supererogatorio, che supera oltre l’immaginazione ogni imperativo morale, Gesù redime l’umanità del peccato originale. Riporto integralmente le parole di Don Mattia Francescon:
Con la passione, morte e risurrezione, Gesù diventa il centro della rivelazione di Dio al mondo, il centro della Scrittura: tutto converge in lui. La croce è assoluta trascendenza di Dio di fronte al male, al peccato; paradosso dell’esistenza umana, nella sua drammaticità, in cui l’uomo può trovare conforto.
Nel Risorto la potente provvidenza di Dio nel mondo si rivela efficace, punto di svolta nella storia, dinamica di trasformazione e trasfigurazione. È il compimento della duplice convinzione di Gesù: conferma la mediazione del Figlio e permette la partecipazione dell’intera umanità agli effetti della mediazione salvifica del Figlio.
Il sacrificio della croce rivela la dignità filiale di tutti gli uomini; Rinnova in Gesù, con Gesù, per Gesù la comunione tra Dio e gli uomini; compie la promessa divina della nuova alleanza con il dono dello Spirito. Attratti da Gesù per mezzo della Spirito del Risorto diventiamo capaci di vivere come lui, da figli, fedeli alla nuova alleanza.
La Norma Morale
Veniamo finalmente alla norma morale. In questi appunti, occupandoci di teologia morale fondamentale, non ci interessa indagare lo specifico, cioè i contenuti della norma morale, ma piuttosto la norma in sé. Vogliamo capire cosa sia in effetti la norma morale, da dove derivi, come sia definibile. Abbiamo brevemente accennato a tutto ciò nella sezione Teologia Biblica della Morale, ma ora cercheremo di approfondire.
Con norma morale si può intendere sia il singolo precetto che un insieme o sistema di norme.
Rispetto al primo caso, potremmo definire la norma morale così:
Una formulazione che concede, proibisce, o esorta un atteggiamento o un comportamento, la quale tutela e promuove un valore.
La norma, dunque, può essere proibitiva, “non uccidere”, ma anche esortativa, “onora tuo padre e tua madre”, e, come vedremo, essa mira a tutelare o promuovere un valore. In questo senso il rispetto della norma morale è il mezzo attraverso cui ciascuno risponde alla vocazione di santità – cioè da piena adesione al progetto divino – nella sua specifica condizione di vita.
La norma morale è comunque un componente fondamentale di qualsiasi discorso morale. Non ha significato parlare di moralità, senza riferirsi ad una norma. Questo perché la riflessione morale nasce per rispondere ad una domanda pratica – “che cosa devo fare?” – a cui non è possibile rispondere se non in relazione ad una norma generale.
Ma da dove proviene la norma morale? In precedenza, abbiamo parlato della legge mosaica e della nuova legge evangelica. Tuttavia la norma morale ha una origine ancora più ancestrale e precedente.
Sebbene gli uomini siano capaci e spesso propensi a sopprimerlo e assopirlo, essi hanno tutti una forma di intuito per il bene. Ogni uomo ha in effetti come una comprensione innata, seppur non sempre allenata, della legge divina: una sorta di norma arcaica, infusa nella natura stessa dell’uomo in quanto Figlio di Dio creato a Sua immagine. In questa forma innata, essa ha il nome di legge naturale.
Il Gaudium et Spes, scrive così:
L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità.
Tale considerazione fa eco alle parole di San Paolo, nella lettera ai Romani:
Romani 2:14-15
14 Infatti quando i gentili, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno legge, sono legge a se stessi; 15 essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. 16 Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio vangelo.
È quindi fondamentale ricordare, contro il pensiero relativista così diffuso nella modernità, che la norma morale è una esistenza reale, necessariamente derivante dalla natura Divina.
Se i costumi cambiano in base al luogo o al momento storico, la norma morale è sempre la medesima, ed al più si può dire che un popolo o una cultura siano deviati da essa, abbiano in qualche modo sottomesso l’intuito morale al costume. Me se pure questo intuito può essere in parte soffocato dai condizionamenti culturali o dalle condizioni soggettive di ciascuno, non è mai sopito del tutto.
Tutti gli uomini riconoscono dei valori fondamentali, che guidano e dirigono la loro vita. Questi valori, spesso e volentieri, sono riflesso, sia pure parzialmente offuscato o distorto, dei valori divini.
È così quasi sempre possibile condurre l’uomo alla vera norma morale tramite un processo razionale, identificando i fondamenti comuni e derivando le buone norme da essi, e rivelando i disvalori per ciò che sono esplicitandone le estreme conseguenze. Il discorso morale che mira a delineare razionalmente i comportamenti giusti ed i comportamenti sbagliati è l’etica normativa.
Si consideri che uno dei primi ad interrogarsi con profondità sul fenomeno morale in ambito filosofico è probabilmente Socrate: ciò è solo una ulteriore prova che gli interrogativi morali, il bisogno del bene, non sono realtà esclusive del mondo cristiano né del credente in genere, ma nascono dalla natura fondamentale dell’uomo.
I Valori ed i Disvalori
Nello scorso capitolo, abbiamo parlato in più occasioni di valori e di disvalori. Avevamo già introdotto il termine durante l’excursus sul Decalogo, spiegando come ciascun comandamento sottenda un particolare valore. Un valore è in effetti descrivibile come il bene che una norma morale si propone di tutelare.
Ad esempio, il bene associato all comando non rubare, è l’onesta; a non commettere adulterio, la fedeltà, l’integrità della famiglia.
Come per il decalogo, la norma morale potrebbe essere espressa altrettanto bene in termini di valori desiderabili e disvalori da rigettare. In effetti, è questo che si tende a fare quando in una situazione appare impossibile soddisfare al massimo tutti i precetti positivi e negativi della norma.
Si cerca in questi casi allora di ragionare in termini valoriali, rispondendo alla domanda “come posso realizzare il migliore bene possibile?“, che significa fondamentalmente “come posso tutelare il maggior numero di valori, a partire dai più importanti, in questa azione?“
Vi è in effetti una gerarchia tra i valori, e tale gerarchia può essere derivata dalla stessa norma morale. Tanto più severamente o ripetutamente è ribadita una norma, tanto più importante è il valore che essa protegge.
I valori così individuati, sono detti morali, cioè derivanti direttamente dalla norma morale (non commettere adulterio, fedeltà – non uccidere, rispetto della vita umana – non dire falsa testimonianza, onestà eccetera).
Vi sono inoltre dei valori che definiamo valori non-morali: essi sono tutti quei beni desiderabili ma senza un particolare valore morale, come ricchezza, salute, prosperità. Vanno ritenuti sempre gerarchicamente inferiori ai valori morali.
Infine, un disvalore può essere considerato semplicemente come la negazione di un valore. Il disvalore della promiscuità non è che la negazione del valore della fedeltà, e così via. San Tommaso d’Acquino, uno dei principali teologi della storia della Chiesa, rilevava in questo senso che il male non ha propria consistenza teologica: esso non esiste se non nel senso di negazione o imperfezione del bene.
Comportamento e Atteggiamento
Come vedremo più approfonditamente nella sezione su Il Giudizio Morale, all’agire morale dell’uomo concorrono due fattori: il comportamento, cioè l’azione compiuta, e l’atteggiamento, cioè l’intento, la volontà dell’agente. Entrambi questi elementi si relazionano alla norma, seppure in maniera diversa.
Il comportamento è l’atto normato in sé. Il comandamento non uccidere, ad esempio, proibisce uno specifico atto, cioè l’omicidio. In relazione alla norma morale, è possibile dunque stabilire oggettivamente se un comportamento è moralmente corretto o scorretto. Ciò non è però, come vedremo, sufficiente ad esprimere un giudizio morale.
L’atteggiamento è la disposizione interiore di colui che agisce, e si relaziona anche esso con la norma, o meglio con i valori che la norma sottende.
Il comandamento non rubare sottende il valore della proprietà altrui. Un furto, è una violazione evidente di questa norma. Tuttavia se il ladro agisce in tal modo perché indigente e in necessità di nutrire un figlio affamato, dobbiamo riconoscere che l’intento non è quello di arricchirsi a scapito del derubato, ma di tutelare la vita del pargolo, valore sotteso dal comandamento non uccidere, per altro di ordine superiore.
Similmente, aiuta gli indigenti, può essere una norma morale. Tuttavia colui che offre la carità con il solo scopo di trarne un elogio sociale, pur presentando un comportamento moralmente corretto, agisce con un intento contrario al valore sotteso dalla norma, la dignità umana, poiché utilizza l’indigente a proprio vantaggio.
Si può dire che, se il comportamento è oggetto di specifiche norme che vanno ricavate per ciascuna situazione, l’atteggiamento è legato ad una sola esortazione: persegui il bene e rifuggi il male. Questa esortazione può forse essere rappresentata dal duplice comandamento dell’amore che abbiamo citato parlando del nuovo testamento: ama Dio sopra ogni cosa ed il tuo prossimo come te stesso.
Dall’incrocio del comportamento e dell’atteggiamento della persona, nasce una prima valutazione di merito di una azione, che può collocarla in quattro situazioni ideali:
| Comportamento | Atteggiamento | Situazione |
|---|---|---|
| Corretto | Buono | Il bene morale. Una azione moralmente buona compiuta con l’intento di fare il bene. Un esempio biblico è Giovanni: ama il Cristo e lo segue fin sul calvario. |
| Scorretto | Buono | Il male commesso per ignoranza o superficialità. A seconda della perfezione dell’atteggiamento, in caso ad esempio di completa ed invincibile ignoranza o inconsapevolezza, può non essere un male moralmente rilevante, come vedremo nella sezione Il Giudizio Morale. Secondo alcune interpretazioni, Giuda tradì Gesù per spingerlo a manifestarsi pienamente come messia e rovesciare i romani, secondo una idea di messia-re-liberatore diffusa al tempo, e non si aspettava ciò che invece successe. In questo caso, il tradimento di Giuda sarebbe un esempio biblico di questa situazione: un atto scorretto (il tradimento) commesso con una intenzione almeno parzialmente buona (portare a compimento la promessa messianica). |
| Corretto | Cattivo | Il bene commesso con un secondo fine malvagio. È il caso dell’ipocrisia: un esempio biblico sono i farisei, che praticavano il digiuno e l’elemosina per il proprio stato sociale e in funzione di condannare coloro che non la praticavano. |
| Scorretto | Cattivo | Il male scelto e commesso consapevolmente. È l’unico campo dove si manifesta quello che conosciamo come peccato mortale, la colpa grave. Un esempio biblico potrebbe essere rappresentato dalla vicenda di Davide e Betsabea: Davide pianifica consapevolmente sia l’adulterio che l’omicidio del marito di Betsabea, e li porta a compimento. |
Articoli Correlati
Appunti di Teologia Morale – Il Giudizio
Veniamo alla quarta parte dei miei appunti di Teologia Morale. Parleremo del giudizio morale di fronte ad una azione o…
Appunti di Teologia Morale – La Coscienza
La terza parte dei miei appunti di Teologia Morale. In questa parte parleremo della coscienza umana, luogo dove ciascuno vive…
Appunti di Teologia Morale – Introduzione
Ecco la prima parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. Introdurremo la riflessione morale in genere….
Un Corso di Teologia Morale
Ho partecipato ad un corso di introduzione alla Teologia Morale Fondamentale. Vi racconto come è andata, e condivido con voi…

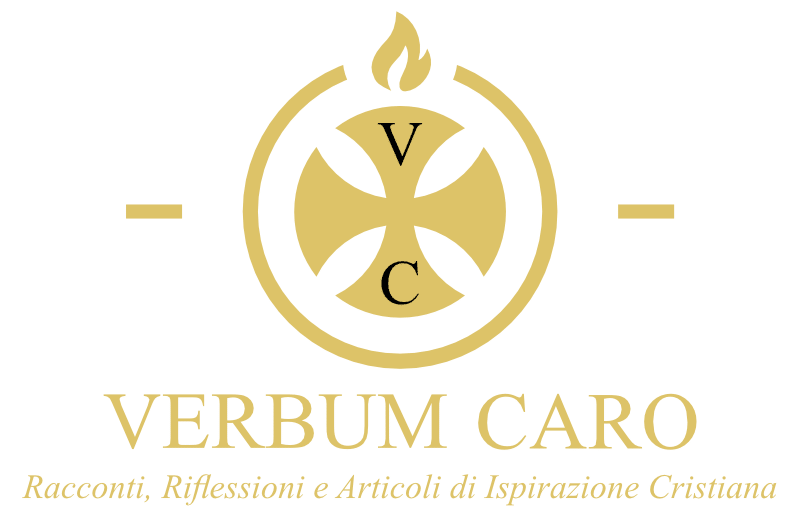
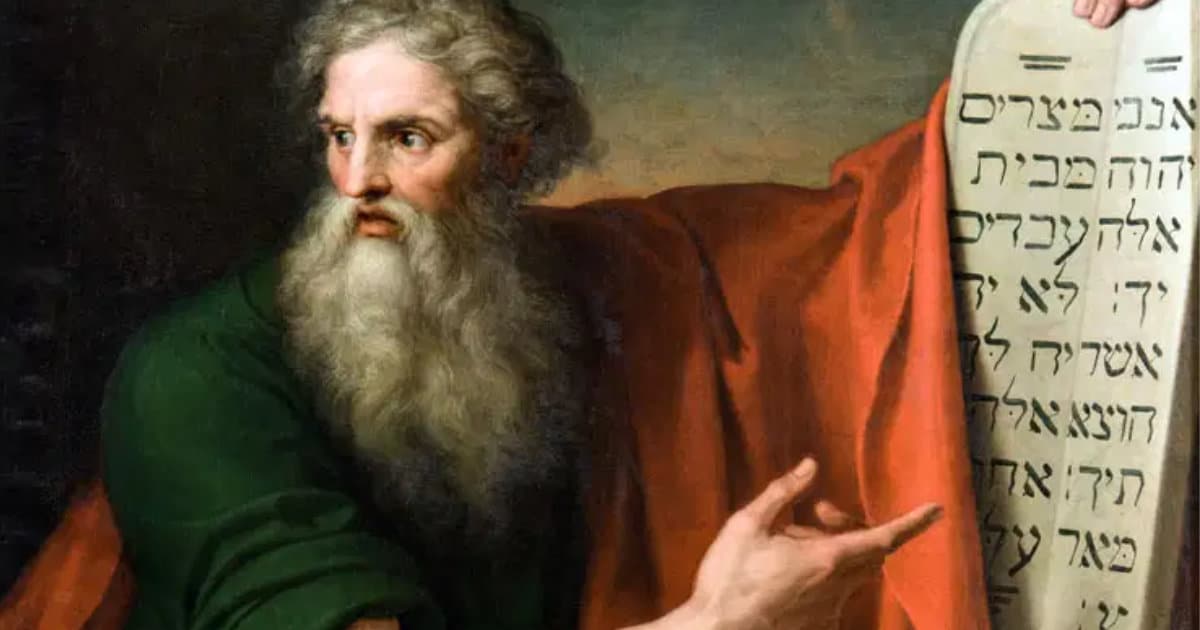




Lascia un commento