Ecco la prima parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. In questa parte introdurremmo la riflessione morale in genere ed i concetti che tratteremo nelle prossime parti degli appunti.
Introduzione Etimologica e Cenni sulla Materia
Per capire di cosa si occupa la Teologia Morale, è bene avere chiaro il significato dei termini che compongono il nome di questa materia.
Teologia significa “discorso su Dio”: il termine deriva dal greco théos, Dio, e logos, discorso, ragionamento. Intuitivamente, la teologia è una branca del discorso filosofico che si occupa di ragionare sulla natura di Dio. In particolare, inserita nella tradizione cristiana, la teologia riflette su Dio a partire dalle fonti della teologia: la Sacra Scrittura, rivelazione che Dio fa di sé, la Tradizione Sacra, cioè l’insieme delle concezioni e degli insegnamenti trasmessi e consolidati nella storia della Chiesa, ed il Magistero, l’insegnamento diretto della comunità dei Vescovi in comunione con il Papa.
Il termine morale è invece più complesso. Deriva dal latino mos, al plurale mores: costumi, usanze, comportamento; ma anche legge, regola, norma.
Il termine ha nella lingua italiana una pletora di diversi significati, e questo può condurre in errore durante una discussione sul tema della morale. Può significare, ad esempio:
- Come sostantivo, la norma morale, cioè l’insieme di regole positive, ovvero ciò che bisogna fare, e negative, ovvero ciò che è proibito fare, che regolano il giusto comportamento umano.
- Ad esempio: “La morale cristiana ci chiede di assistere gli infermi.”
- Come aggettivo, di qualcosa che è legato al campo della riflessione sul giusto comportamento umano o alla coscienza personale.
- Ad esempio: “Fingersi infermi per ottenere l’aiuto del prossimo, è una forma di ricatto morale”, oppure, “l’insegnamento di Gesù è un insegnamento principalmente morale.”
- Come aggettivo, di qualcosa che ha rilevanza morale, ovvero che è giudicabile secondo una riflessione morale. In questo caso, il contrario di morale è amorale o non morale.
- Ad esempio: “I gusti culinari non sono una questione morale.”
- Come aggettivo, di qualcosa che è un bene morale, ovvero di qualcosa che già ha rilevanza morale, ed è anche giudicato buono, dunque in accordo con la norma morale. In questo caso, il contrario di morale è immorale o anti-morale.
- Ad esempio: “Assistere gli infermi è una azione morale.”
Il dilemma è risolto con un uso avverbiale della parola per il terzo e quarto caso: si può parlare di azione moralmente rilevante o moralmente irrilevante, o di azione moralmente buona o moralmente cattiva.
Proposta: Cerca di soffermarti su ogni uso della parola morale in questi appunti, e di ricondurlo ad uno dei significati elencati sopra.
Il termine morale è spesso associato, e alle volte usato intercambiabilmente, con il termine etica, derivante forse dal greco êthos, comportamento o carattere, o forse dal greco èthos, cioè costume o consuetudine. I termini hanno sfumature leggermente diverse in italiano, ma possono per lo più essere utilizzati come sinonimi.
Ciò detto, quando parliamo di Teologia Morale, utilizziamo il termine “morale” come nel secondo uso che abbiamo proposto, intendendo dunque una riflessione teologica legata al campo del giusto comportamento umano.
Se la teologia è la branca della filosofia che si occupa di ragionare attorno al Divino, la Teologia Morale è la branca della filosofia che si interessa del comportamento che gli uomini sono chiamati a mantenere alla luce della loro riflessione sul Divino.
Una riflessione morale non religiosa è definita filosofia morale o semplicemente etica, e si distingue dalla teologia morale principalmente per il fatto di non identificare necessariamente nel Divino la fonte della norma morale, ovvero il “metro” secondo cui giudicare la bontà o meno del comportamento umano. Al di là di questa differenza, le due discipline hanno significative sovrapposizioni, ed è ragionevole descrivere la teologia morale come una filosofia morale sviluppata in ambito religioso.
Appunto: il Realismo Morale
Il realismo morale è l’idea che la norma morale non sia una convenzione sociale, ma un qualcosa di esistente al di fuori dell’uomo o di necessariamente derivante dalla sua natura. Ogni forma di pensiero etico che abbia una pretesa di universalità e oggettività, si basa su una forma di realismo morale. Il pensiero morale cristiano è in questo senso appartenente al realismo morale. Vedremo poi attorno a cosa fonda la sua giustificazione.
La teologia morale trova particolare sviluppo nel pensiero cristiano, dove si configura come una riflessione sul giusto comportamento che l’uomo è chiamato a mantenere alla luce della rivelazione di Cristo.
Poiché la teologia morale si fonda su fonti definite – le scritture, la tradizione sacra e gli insegnamenti del magistero – e poiché analizza queste fonti secondo i metodi della ragione e del rigore filosofico, essa è una disciplina scientifica; intendendo non con questo che si occupi di scienze naturali o di esperimenti, ma che pretenda un approccio metodico e rigoroso, rispettoso della congruenza con le fonti e della consistenza dei ragionamenti proposti.
Per questa ragione le conclusioni della teologia morale, pur consentendo dei margini di interpretazione, non sono arbitrarie. Ad esempio, alla luce della Sacra Scrittura e della tradizione cristiana, è semplicemente errato, nella stessa misura in cui due più due non può dare cinque, sostenere che l’omicidio sia accettabile.
La Teologia Morale non è dunque questione di preferenza o sentimento personale, ma di dialogo razionale, riconoscibile e valutabile da ogni interlocutore, con lo scopo di rispondere agli interrogativi dell’uomo circa la natura del Bene e del suo giusto comportamento nel mondo.
All’interno della disciplina della Teologia Morale riconosciamo tre distinte aree di studio:
- la teologia morale fondamentale, che si occupa di studiare i principi fondamentali della morale, cioè la natura dell’esperienza morale in sé e della risposta dell’uomo al comando morale nelle sue componenti esteriori ed interiori, il rapporto tra la rivelazione divina e la norma morale, i metodi per un giudizio morale equo.
- la teologia morale generale, che si occupa di applicare i ragionamenti fondamentali alle esortazioni bibliche e alla tradizione per delineare le virtù, i vizi, e la norma morale in genere
- la teologia morale speciale, suddivisa in varie sotto branche, che si occupa dei ragionamenti morali legati a campi specifici, come, ad esempio:
- l’organizzazione della società (dottrina sociale della Chiesa);
- la bioetica;
- l’etica della comunicazione.
Questi appunti sono dedicati esclusivamente alla teologia morale fondamentale.
Definizione di Don Mattia Francescon
La Teologia Morale è la riflessione sul comportamento dell’essere umano chiamato da Dio a vivere l’amore nel mondo.Si tratta di una scienza, un sapere riflessivo, alla luce del Vangelo e dell’esperienza umana, sul comportamento dell’essere umano, sull’agire libero, responsabile, consapevole, nella sua dimensione personale (l’esperienza della decisione di coscienza in una rete di relazioni) e nella sua dimensione universale, oggettiva (criteri valutativi generalizzabili, norme) chiamato alla comunione con Dio cioè chiamato a portare frutti di carità nel mondo.
I Quattro Livelli della Riflessione Morale
All’interno della riflessione morale, si possono distinguere quattro piani di discussione, che, spesso, sono intersecati fra loro.
Individuiamo, nel discorso morale:
- un livello fondamentale, detto anche metaetico, cioè la discussione sulla morale in sé, su cosa giustifichi il discorso morale in primo luogo. Ci si chiede cosa, cioè, autorizzi l’uomo a riflettere con pretesa di oggettività – ed eventualmente universalità – su cosa sia bene e cosa sia male. A questo piano del discorso appartiene anche la riflessione antropologica: come vive l’uomo l’esperienza morale? Cos’è la coscienza, cosa e quali sono i vizi e le virtù? Per la riflessione morale cristiana, questa parte del discorso è intimamente connessa alla fede, alla tradizione della Chiesa e al racconto biblico.
- Un livello storico-genetico, cioè la riflessione sull’evoluzione della comprensione dei principi morali nella storia di un popolo e nella vicenda umana in generale. Per i cristiani è fondamentale la riflessione sul mutare del sentire etico nella transizione dall’epoca pre-cristiana all’epoca cristiana, su come alcuni valori, quali ad esempio la sacralità della vita, degli infanti, del matrimonio libero e monogamo, si siano manifestati attraverso questa transizione.
- Un livello formativo, detto anche parenetico o esortativo, cioè la riflessione su come educare al rispetto dei principi morali su come trasmettere questi principi attraverso le generazioni. L’ambito formativo è per i cristiani strettamente legato all’evangelizzazione, alla testimonianza del messaggio di amore universale del Cristo.
- Un livello normativo o teorico-giustificativo, ovvero quel piano del discorso che si occupa di individuare, per mezzo di un discorso razionale e argomentativo, le giuste norme ed i giusti comportamenti.
Il dominio principale della teologia morale fondamentale è, come suggerisce il nome della materia, il livello fondativo: tuttavia essa contiene anche elementi di riflessione storico-genetica, su cui ci soffermeremo parlando dell’evoluzione biblica della norma e della tradizione della Chiesa attorno al tema della coscienza. La teologia morale fondamentale tocca il piano normativo occupandosi, come vedremo, dei principi di soluzione e dei metodi di analisi e giudizio morale, ma non entra nello specifico dell’esposizione e della giustificazione dei singoli precetti della norma morale.
Ciò è infatti dominio principalmente della teologia morale generale e alla teologia morale speciale e della tradizione casuistica, che valutava caso per caso il giusto comportamento.
Come vedremo, la sfida principale del discorso normativo è costruire ponti con riflessioni morali che non condividono la stesso piano fondamentale. Il cristiano si relaziona con una società che non sempre identifica le esortazioni bibliche come validi fonti di principi morali, e tuttavia condivide intuizioni valoriali comuni, quali la sacralità della vita, della proprietà personale, della legalità. In funzione di questi punti comuni è possibile costruire argomentazioni morali che riescano ad legare esperienze dissimili tra loro.
Non si tratta di una sfida semplice; è tuttavia uno sforzo indispensabile ai fini della partecipazione del cristiano ad una società che, pur non totalmente cristiana, può comunque identificare ed incorporare dei valori importanti.
I Fondamenti della Riflessione Morale Cristiana
Abbiamo brevemente toccato questo tema durante l’introduzione, ed ora è opportuno approfondirlo leggermente.
La riflessione morale cristiana nasce dall’idea che Dio, creatore e principio di tutte le cose, sia altresì fonte del bene. Nella visione cristiana il bene è un aspetto della natura di Dio. Non ha senso chiedersi, per un cristiano, se una cosa sia bene perché lo dice Dio, o se lo dica Dio perché è bene: questo perché il bene deriva direttamente dalla natura di Dio.
Il bene non è una entità, una legge, che esista fuori o indipendentemente da Dio: il bene è da Dio. Inteso come norma, il bene è l’insieme di tutti quei comportamenti che consentono all’uomo di collaborare al disegno di Amore di Dio per il mondo. D’altro canto il male è ciò che va contrario a questo disegno. La forza di questa legge morale è data da una chiara visione soteriologica: gli uomini che rigettano la Legge rigettano altrettanto Dio, ed il loro destino ultimo è dunque la separazione da Lui.
Poiché Dio è unico, trascendente, e padre di tutti gli uomini, inclusi i non cristiani, il pensiero cristiano è razionalmente legittimato a sostenere che questo bene sia altrettanto unico ed universale.
Le norme a cui si è chiamati dalla rivelazione di Dio sono norme assolute, valide tanto nell’anno duemila quanto nell’anno zero, e tanto in Europa quanto in Asia. Per tanto, nello sviluppo della storia i popoli non inventano la norma morale, bensì la scoprono, con vari gradi di comprensione della stessa.
Ad esempio, allo stesso modo in cui i romani conoscevano i numerali ed i rudimenti della matematica, ma non conoscevano il calcolo differenziale, così essi riconoscevano la giustizia e la legalità come beni morali, ma non riconoscevano il bene morale della dignità dell’infante.
Questo processo di scoperta è necessario, pur essendo l’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, e dotato di una coscienza che, come vedremo in seguito, lo attira costantemente verso il bene. Questo perché l’uomo è caduto: a causa della disobbedienza originale, la natura umana è corrotta, e l’uomo non ha più la piena comprensione del bene, poiché non ha più la piena comunione con Dio.
Grazie alla incarnazione e alla piena rivelazione di Dio attraverso Cristo e la sua Chiesa, però, la legge divina è accessibile e comprensibile a tutti gli uomini. Attraverso la riflessione attorno alla Scrittura, il rispetto della Tradizione Sacra e l’obbedienza al Magistero della Chiesa, fonti certe ed infallibili, poiché protette dallo Spirito Santo, l’uomo ha la possibilità di comprendere oggettivamente il bene.
Nello specifico, i dettami della norma morale cristiana derivano dal racconto biblico, ed in particolare dal decalogo, le leggi consegnate da Dio a Mosè. La legge mosaica è poi completata dall’esempio e dall’insegnamento diretto di Gesù Cristo, così come riportato nei Vangeli. In particolare, sono fondamentali la cosiddetta regola d’oro, cioè il comandamento di fare agli altri, secondo giustizia, tutto e solo ciò che vorremmo fosse fatto a noi; le beatitudini, che descrivono i tipi umani ove più si posa lo sguardo di grazia di Dio; gli ammonimenti e le esortazioni del discorso della montagna. Questi ultimi non sostituiscono né si aggiungono alla legge mosaica, bensì la completano, la inquadrano nel contesto della carità e dell’amore divino.
Tutto l’insegnamento biblico è poi letto alla luce della tradizione apostolica, risalente alle Lettere Paoline ed alle lettere Cattoliche, seguite poi dalla tradizione dei padri della chiesa. Tutto ciò è poi elaborato e chiarito dal Magistero della Chiesa.
Su queste basi, espresse molto sinteticamente, si fonda la riflessione morale cristiana, nei suoi contenuti e nella sua pretesa di universalità, oggettività ed assolutezza.
La Storia Umana come Cammino di Rivelazione
Nella riflessione cristiana, la storia umana può essere interpretata come la storia di una progressiva rivelazione di Dio agli uomini. Questa storia inizia con l’esperienza intima e diretta di Dio dei Patriarchi. Dio poi sceglie e organizza un popolo, Israele, per preparare la sua rivelazione: la storia ha il suo cardine nella piena rivelazione di Dio in Gesù, e prosegue nella testimonianza di Dio al mondo da parte di un popolo universale, costituito in una Chiesa.
Similmente, nella storia dell’uomo è individuabile anche il rivelarsi di una esperienza morale. In principio vi è l’esperienza di una legge naturale, intimamente presente in tutti gli uomini come segno o impronta del loro Creatore. Questa legge si formalizza nella Legge Antica, donata da Dio ad il popolo di Israele, che dovrà per mezzo di essa preparare la rivelazione definitiva; questa si compie per mezzo di Gesù, che completa la legge antica con la nuova legge evangelica, rileggendola nella carità e nell’amore divino.
Infine il Cristo costituisce il suo popolo in una Chiesa che è incaricata di essere “germe in terra del regno di Dio”. Essa, tramite la partecipazione all’organizzazione sociale e al dialogo civile, continua a rivelare la legge divina al mondo.
A questa storia di rivelazione partecipa la coscienza e l’esperienza di tutta l’umanità, inclusa l’umanità non credente, che è anch’essa partecipe della legge naturale, proprio perché ogni uomo è figlio del medesimo Dio Padre. Tutti partecipano allo stesso piano salvifico, che pure si esprime e si manifesta nella Chiesa di Cristo.
Così vanno lette in una storia di rivelazione progressiva tutte le esperienze di scoperta morale. Storicamente, questa rivelazione parte dalle storie bibliche, ma include anche quei profondi contributi morali e giuridici del mondo antico greco-romano. La rivelazione morale trova il suo fulcro negli insegnamenti del Cristo, che più solennemente di ogni altro ha mostrato al mondo il bene del perdono, della dignità dell’errante, dell’umile e dell’ultimo.
Questa storia comunque continua, con tutte le esperienze dell’umanità in cammino. Dai sacrifici degli ordini religiosi nella cura degli infermi durante le epidemie medievali; allo sviluppo dei primi codici giuridici che rispettavano la sacralità dell’individuo, come l’habeas corpus; fino alle più moderne esperienze legate alle lotte per la libertà e per l’uguaglianza. Ognuno di questi movimenti, anche qualora si sia discostato dalla pienezza della verità evangelica, contiene il seme di una umanità che si relazione con il Bene e lo cerca incessantemente.
Tutto deve essere comunque letto in riferimento alle fonti della teologia: non è infatti necessario che lo sviluppo morale dell’umanità segua un percorso lineare – così come il regno di Israele si è più volte allontanato da Dio, e da Dio è più volte stato redento, così l’umanità potrà errare e dimenticare gli insegnamenti di Dio – e certamente così è stato.
Si pensi infatti alle tragedie belliche o ai genocidi del ventesimo secolo, così come al decadimento della morale coniugale e sessuale nella seconda metà dello stesso secolo, o al diffondersi sempre maggiore, in tempi odierni, di visioni antropologiche antitetiche a quella evangelica, ed alle conseguenze che ciò ha in ambito bioetico.
In ultima istanza, è necessario discernere l’autenticità del progresso morale vedendolo alla luce dell’insegnamento di Cristo e della Chiesa.
Il Livello Formativo dell’Etica Cristiana e come si manifesta nella Vita della Chiesa
La Chiesa, come madre del fedele, ma anche come testimone di Dio nel mondo a vantaggio di tutti, inclusi i non credenti, è costantemente chiamata a testimoniare e promuovere nella società il messaggio evangelico ed i valori cristiani.
Quest’opera è strettamente legata all’evangelizzazione e al catechismo dei credenti ed in particolare dei giovani, che ogni comunità cristiana ed ogni parroco, costituendosi pastore, è tenuto a curare. Nella modernità quest’opera si è configurata in un vasto gruppo di iniziative, promosse dalle singole Chiese particolari come dalla Chiesa Cattolica come insieme. Alla catechesi si affiancano centri di ascolto, incontri di approfondimento, campi scuola e Grest per i più giovani, l’esperienza scout, l’accompagnamento delle coppie verso il matrimonio con percorsi di formazione.
La tradizione sacra della Chiesa forma la coscienza del fedele primariamente attraverso i Sacramenti, e principalmente tramite l’esercizio dell’esame di coscienza che è proprio del sacramento della Riconciliazione. I Santi, inoltre, costituiscono veri modelli eroici ed esemplari, in grado di attirare a sé i fedeli, ispirandoli e suscitando un sano spirito di emulazione; primo fra tutti, il Cristo.
Il compito universale della Chiesa fa si che essa, attraverso l’intera comunità ecclesiale, dunque sia i presbiteri che i laici, sia tenuta a farsi carico di propagare e insegnare i valori cristiani anche nella comunità civile non cristiana. Così sono richiesti al fedele rispetto e attenzione verso tutte le istituzioni di formazione e di cultura anche non ecclesiali: dalle scuole, al dialogo professionale, ai luoghi culturali.
È in queste aree che il fedele è sfidato a formare ai valori cristiani anche le coscienze di coloro che non hanno ancora ricevuto o accettato il vangelo, utilizzando gli strumenti della ragione e individuando le fondamenta comuni.
Argomentare e Giustificare l’Etica Cristiana con gli Strumenti della Ragione
Nel discorso etico-normativo, il cristiano cerca continuamente di leggere le esigenze della modernità alla luce della rivelazione divina, ed individuare, utilizzando gli strumenti della ragione, i comportamenti idonei in ogni situazione. Questo si manifesta in un vivace discorso che copre oggi vari campi: dalla bioetica, all’uso dei mezzi di comunicazione, dei mezzi informatici, alla dottrina sociale.
Nella riflessione etica interna al mondo cristiano, sia pure con le altre confessioni cristiane, il fedele è perfettamente legittimato ad attingere alle fonti della morale cristiana (Scrittura, Tradizione, Magistero) nella sua argomentazione. Questo perché in questa sede, l’interlocutore riconosce generalmente la fonte come autorevole.
Tuttavia, la Chiesa si trova oggi inserita in una società non sempre disponibile ad accettare i fondamenti della morale cristiana come valide fonti dell’etica. Questo fatto non può essere ragione per abdicare al compito di essere guida morale per l’umanità intera, fatta di credenti e di non credenti.
Fortunatamente, ogni uomo possiede un intuito per il Bene, seppure non sempre allenato. È quasi sempre possibile trovare dei valori comuni ad i valori fondamentali cristiani, anche in coloro i quali non si riconoscono nella fede o pratichino altre fedi. Specie nel mondo occidentale, che mantiene comunque un forte retaggio culturale cristiano, quasi la totalità delle persone riconosce come sacra ed indisponibile la vita umana, è orientata al bene della convivenza civile e della stabilità sociale, accetta i valori della solidarietà e della attenzione ai più deboli.
Il fedele deve imparare, per assolvere al proprio compito di essere “luce del mondo e sale della terra”, a costruire ponti sui valori comuni con le altre persone, utilizzando gli strumenti della ragione.
Un esempio concreto e legato alla vita moderna è il tema dei rapporti sessuali prematrimoniali. Se in un contesto puramente cristiano può essere sufficiente ed efficace invocare le prescrizioni bibliche che vincolano l’atto sessuale al contesto del matrimonio, questo genere di argomentazione non sarà certo convincente verso qualcuno che non si riconosce nella fede cristiana.
È però possibile invitare questo tipo di persona ad riflessione sul significato e sullo scopo profondo della sessualità, sugli effetti psicologici della dissociazione dell’atto sessuale dal rapporto affettivo ed esclusivo, sulle conseguenze negative che si riversano sui figli nati fuori dal matrimonio in caso di separazione della coppia, eccetera. Il tutto citando, magari, fonti scientifiche che l’interlocutore accetta come autorevoli.
Una nota è necessaria per ciò che concerne il discorso etico-normativo legato alla promozione di norme di legge nelle varia unità amministrative ove si trova a convivere il fedele. Alcune concezioni, tra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo, hanno teorizzato o auspicato la realizzazione di “stati etici”, ove il giusto comportamento fosse finemente imposto dalla legge.
Tale non può essere l’obbiettivo politico del cristiano. Come insegna il catechismo, non vi è valore in una coscienza non libera. Se è giusto e legittimo promuovere leggi che vietino il male in tutti i quei casi in cui esso è rivolto verso il prossimo, e specie verso i più deboli, non è egualmente praticabile vietare ogni genere di male morale che l’individuo può auto infliggersi – e, tanto meno, non è possibile obbligare l’individuo a commettere il bene.
Articoli Correlati
Appunti di Teologia Morale – Il Giudizio
Veniamo alla quarta parte dei miei appunti di Teologia Morale. Parleremo del giudizio morale di fronte ad una azione o…
Appunti di Teologia Morale – La Coscienza
La terza parte dei miei appunti di Teologia Morale. In questa parte parleremo della coscienza umana, luogo dove ciascuno vive…
Appunti di Teologia Morale – La Bibbia e la Norma
La seconda parte dei miei appunti di Teologia Morale. In questa parte parleremo di etica nel raccondo biblico e di…
Un Corso di Teologia Morale
Ho partecipato ad un corso di introduzione alla Teologia Morale Fondamentale. Vi racconto come è andata, e condivido con voi…

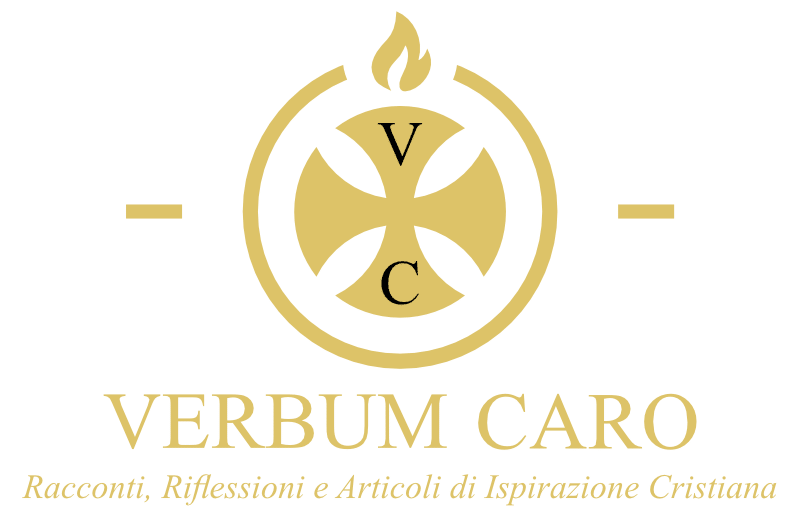



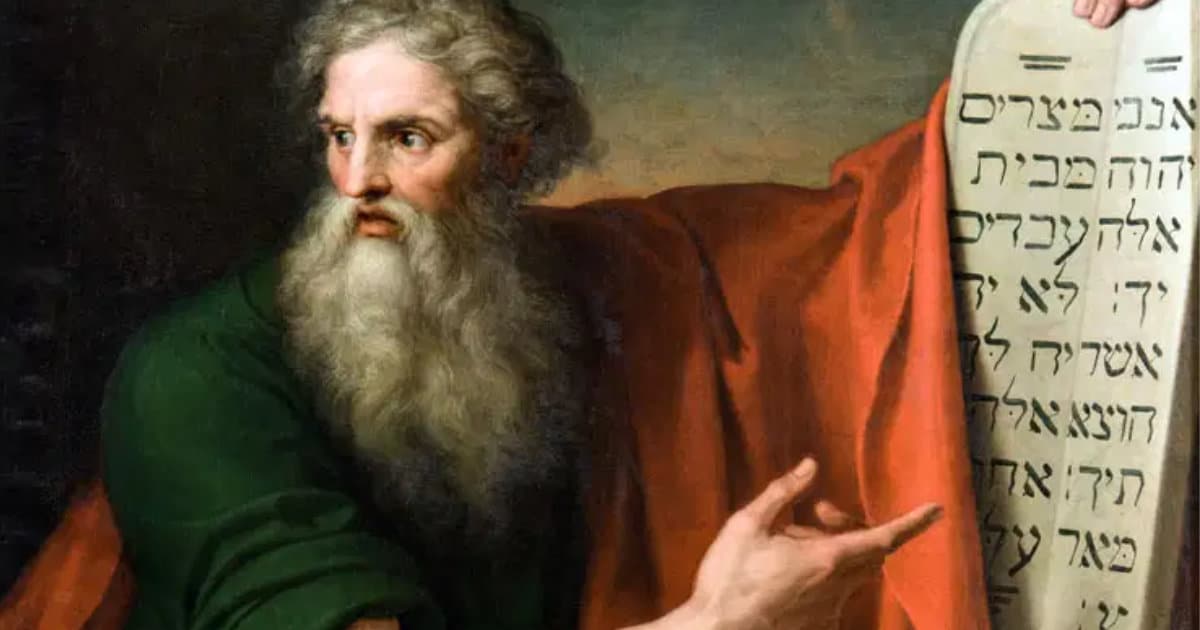

Lascia un commento