Veniamo alla quarta e ultima parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. In questa parte parleremo del giudizio morale di fronte ad una azione o situazione specifica.
Vediamo finalmente un procedimento ideale per esprimere un giudizio morale. Anzitutto, è bene precisare che non tutte le azioni sono giudicabili da una riflessione morale. Il giudizio morale riguarda infatti uno specifico tipo di azioni, aventi specifiche caratteristiche, che ora descriveremo.
Il Campo della Morale
All’inizio di questi appunti, ragionando sui molteplici significati della parola morale, abbiamo introdotto il termine amorale, cioè di una azione che non si ritiene moralmente rilevante. È necessario infatti che una azione soddisfi certi criteri per essere soggetta ad un giudizio morale.
Questi criteri sono:
- Rilevanza morale: la azione deve essere riconducibile ad una prescrizione della norma morale;
- Libertà: la azione deve essere commessa liberamente dall’agente, senza costrizioni fisiche o morali;
- Responsabilità: l’agente deve poter essere responsabile della azione commessa;
- Consapevolezza: l’agente deve essere consapevole che ciò che l’azione che sta commettendo è moralmente rilevante.
L’insieme delle azioni rispondenti a questi criteri forma il campo della morale, cioè il campo delle azioni che possono essere oggetto di un giudizio morale.
Rilevanza Morale
Una azione è di rilevanza morale se è riconducibile ad una prescrizione della norma morale.
Per esempio, come vedremo, la norma morale cristiana si esprime sulla sacralità della vita umana, ma non si esprime sul corretto senso di guida dei veicoli. Per tanto, se un omicidio o una violenza ha una chiara rilevanza morale, ed è dunque condannabile dal giudizio morale, non è significativo un ragionamento sul se sia bene o male guidare a destra o a sinistra: questo genere di comportamento può essere rimesso ad una semplice convenzione sociale.
Attenzione però: l’adesione ad una convenzione sociale, o alla legalità, è invece una prescrizione della norma cristiana. Se nella formazione di una convenzione sociale e nella convenzione sociale in sé non vi è rilevanza morale, decidere di rispettare o meno una convenzione esistente è invece rilevante. Tanto è che, guidando a destra in un paese dove la convenzione è di guidare a sinistra, rischiamo di ferire delle persone.
Libertà
Una azione è definita libera quando è commessa senza costrizioni fisiche o morali. Un esempio di costrizione fisica è una disabilità o un limite personale.
Immaginiamo di incontrare una persona che sta affogando, ed essere gli unici nelle vicinanze in grado di aiutarla: la norma morale ci impone di soccorrerla, ed il nostro eventuale rifiuto è giudicabile come un male morale. Tuttavia, se al posto nostro vi fosse una persona in carrozzina, con le gambe paralizzate, sarebbe assurdo condannarla moralmente per il suo mancato soccorso.
Questo perché la persona paralizzata non era libera di adempiere all’imperativo morale di soccorrere la persona in difficoltà: vi è una costrizione fisica.
Vediamo ora un esempio di costrizione morale. Secondo la norma morale, è un male sfregiare una icona santa. Durante le persecuzioni dei cristiani in Giappone, però, i magistrati giapponesi costringevano coloro che erano sospettati di aderire al cristianesimo a calpestare proprio delle icone del cristo crocefisso. Se si rifiutavano, erano identificati come cristiani e condannati a morte.
Chiaramente, non è possibile giudicare allo stesso modo il comportamento di qualcuno che, per puro sfregio, entri in una chiesa e dissacri una icona, e quello di qualcuno che sotto minaccia di morte calpesti una immagine sacra.
Questo perché la seconda persona non è pienamente libera di non commettere lo sfregio: è soggetta a una costrizione morale.
Ovviamente una azione non è o libera o non libera, in una sorta di bianco-nero. La libertà di una azione è piuttosto una sfumatura che contempera il giudizio morale.
Responsabilità
La responsabilità di un agente rispetto ad un imperativo morale dipende dalla sua capacità di rispondere all’imperativo stesso, in funzione della sua soggettività: età, capacità, storia personale, situazione fisica e psichica al momento della azione.
Il rifiuto a soccorrere una persona che sta affogando, per esempio, è più grave per un bagnino, che possiede una formazione e una responsabilizzazione per intervenire in queste situazioni, rispetto che per un semplice passante.
O ancora, immaginiamo di essere testimoni di una rapina. Non è possibile giudicare un civile disarmato e senza addestramento che, magari per paura, rifiuti di intervenire, allo stesso modo in cui giudicheremmo un ufficiale di polizia che ometta di soccorrere la vittima.
Anche in questo caso, la responsabilità è uno spettro, non una qualità totalmente presente o totalmente assente.
Consapevolezza
La consapevolezza è la conoscenza, da parte dell’agente, delle norme morali che riguardano la azione che sta commettendo.
Ad esempio, laddove è un male morale per un cristiano non partecipare alla Santa Messa, non è certo attribuibile alcuna colpa a riguardo a qualcuno che non ha conosciuto il Vangelo. Similmente, la condanna per qualcuno che pratichi lo schiavismo nell’epoca moderna deve essere totale, ma non può essere tale la condanna verso, per esempio, un uomo vissuto in epoca romana, dove non si era pienamente consapevoli del valore della libertà e della vita umana.
È necessario fare attenzione, però. In primo luogo, la consapevolezza verso la norma morale non cambia la norma morale in sé. In secondo luogo, come abbiamo detto, l’uomo è dotato di una coscienza: essa è considerabile una fonte completa della norma morale cristiana, seppur non immediatamente disponibile.
Per tanto non è possibile considerare totalmente inconsapevole e dunque privo di colpa qualcuno che, educato a non considerare i suoi schiavi come esseri umani, ne abusi liberamente – pensiamo agli antichi romani – poiché egli aveva comunque a disposizione la propria coscienza da interrogare.
Anche la consapevolezza, come libertà e responsabilità, è una sfumatura: non sempre il giudizio è così semplice.
Analisi di una Azione Morale
Proviamo ora a descrivere il procedimento per esprimere un giudizio su una azione morale. Un giudizio morale completo, deve tenere conto di questi elementi:
- Analisi dell’Azione
- Comportamento
- Atteggiamento
- Circostanze
- Analisi del Soggetto
- Coscienza del Soggetto
- Scelte preferenziali (valori e disvalori considerati dal soggetto)
- Scelta vitale (collocamento sociale, vocazione, forma di vita del soggetto)
- Atteggiamenti Fondamentali (cirtù e vizi del Soggetto)
- Scelta fondamentale (intento profondo del soggetto)
- Analisi dell’Ambiente
- Contesto
- Esempio
Analisi dell’Azione
Abbiamo già parlato di Comportamento e Atteggiamento nella sezione dedicata alla norma morale. Questi elementi sono ciò che costituiscono in maniera fondamentale il giudizio morale, ponendoci nei quattro casi ideali che abbiamo descritto in precedenza.
L’analisi della azione è completa una volta che abbiamo considerato anche le circostanze, cioè chi è coinvolto, come è compiuta l’azione e con che mezzi, in che luogo e tempo, per quale ragione, cosa è accaduto che ha portato a quella azione.
La circostanza non cambia la qualità morale dell’azione. Tuttavia contribuisce a definirne la gravità o la bontà. Ad esempio, una decisione scorretta presa in un contesto di urgenza non può avere la gravità di una azione pianificata per tempo.
Analisi del Soggetto
È obbligatorio fare una premessa di umiltà: il soggetto non ci è mai pienamente accessibile. Solo Dio ha accesso pieno all’intimità e alla direzione della persona.
Inoltre le caratteristiche del soggetto non possono in alcun modo cambiare la moralità della azione commessa. Tuttavia, ancora una volta, queste componenti contribuiscono ad determinare la gravità della azione ed a collocarle in un contesto di vita, e possono aiutare a costituire un giudizio di carattere.
Questi elementi sono invece fondamentali quando siamo noi stessi ad essere oggetto del giudizio, in una situazione di auto esame, in cui dobbiamo auto valutare il nostro comportamento inserito in una direzione di vita: è l’esame di coscienza.
La coscienza è infatti il primo elemento, ed il più inaccessibile. Cosa sentiva il soggetto nel momento in cui ha formulato l’intento di agire ed ha agito? Come ha vissuto l’azione, cosa lo ha spinto ad agire? con quali valori si stava relazionando?
Questi ultimi rappresentano la scelta preferenziale del soggetto. I valori a cui egli ha deciso di aderire, ed i disvalori che ha deciso di rigettare.
L’azione può poi essere collocata in una scelta vitale, cioè la condizione di vita scelta dal soggetto. È un padre, un marito? Un militare? Un ordinato? Ancora una volta ribadiamo che questi elementi non cambiano il valore morale della azione, ma la collocano in un contesto più ampio, che consente di inquadrare la persona, ed empatizzare con la sua situazione. Ciò ci permette di dare dei consigli, di proporre un giudizio più utile e caritatevole.
Si considera poi l’atteggiamento fondamentale. Utilizziamo non casualmente lo stesso termine dell’atteggiamento riferito all’azione: l’atteggiamento fondamentale è l’atteggiamento abituale della persona, costruito nel tempo dal ripetersi e sedimentarsi di una certa maniera di agire. Sono i vizi e le virtù, l’abito operativo della persona di fronte alla scelta morale.
Tutte queste cose aiutano a comprendere la scelta fondamentale della persona: il suo allineamento profondo. Il fine ultimo della vita della persona è il bene, oppure il male?
La scelta fondamentale non è presa in una unica istanza, è un insieme di scelte collocate in ogni punto della vita, che formano una unità.
Analisi dell’Ambiente
Poiché il nostro clima culturale tende ad un relativismo esasperato che colloca ogni azione rispetto all’ambiente della persona, tralasciando gli elementi di giudizio oggettivi della norma morale, è bene ribadire: l’ambiente non concorre a cambiare la qualità morale di una azione.
Tuttavia, non si può prescindere dall’ambiente se desideriamo un giudizio morale veramente completo. Dividiamo l’ambiente in contesto ed esempio.
Il contesto è costituito dalle pratiche, le narrazioni e le tradizioni, le forme in cui si organizza la comunità, le istituzioni: tutto ciò che costituisce il luogo sociale e culturale in cui si sviluppa la formazione del soggetto e da cui egli è inevitabilmente condizionato, nel bene o nel male.
È interessante considerare che anche questo contesto può essere confrontato con la norma morale di origine divina per produrne una valutazione: si parla in questo caso di ethos, l’etica comune di riferimento di una comunità.
L’esempio, invece, è il modello a cui il soggetto si riferisce per orientare la sua vita, e può essere negativo o positivo. L’uomo è naturalmente portato ad emulare il comportamento morale di chi ritiene autorevole o stimabile: si pensi al concetto di emulazione espresso da San Paolo rispetto a Cristo, citato nel capitolo dedicato alla coscienza. Così è importante per una analisi completa capire i modelli di riferimento che il soggetto ha avuto a disposizione.
Procedimento per un Discernimento Morale
Ciò che abbiamo descritto alla sezione precedente è una struttura per una analisi morale a posteriori di una azione. Ma come capiamo quale è la azione corretta da farsi di fronte ad una determinata situazione?
Proviamo a descrivere un procedimento per un discernimento morale oggettivo.
Innanzitutto, esplicitiamo l’obbiettivo di questo genere di riflessione: compiere il bene migliore e possibile in una data situazione. L’obbiettivo di questo ragionamento è dunque capire quali sono i valori che è possibile proteggere o promuovere, ed i disvalori che è necessario evitare, in un dato contesto.
Trovandoci di fronte ad una situazione che mette a repentaglio dei valori, non sempre è possibile tutelarli tutti allo stesso momento. È necessario dunque produrre una scala di valori, ponendo in cima quelli così detti morali, che sono strettamente legati alla norma morale (ad esempio, onestà, rispetto della vita, fedeltà…), ed in secondo luogo i valori non-morali o umani, che riguardano condizioni desiderabili ma non cariche di un significato morale (ad esempio, la salute, la ricchezza, il benessere, la realizzazione personale…).
A questo punto, lo schema per procedere può essere così riassunto.
Analisi del Caso
Si riflette sulla situazione che si ha davanti, e si cerca di raccogliere i dati di fatto. Chi e quante sono le persone coinvolte, quale è la situazione, quanto è urgente, quali sono le caratteristiche del luogo, cosa ci è richiesto fare e cosa sta accadendo.
Individuazione degli Elementi Moralmente Rilevanti
Si escludono dalla riflessione tutti gli elementi che non concorrono al giudizio morale. Le caratteristiche personali di chi partecipa alla azione, il luogo geografico, il periodo: tutte queste cose non sono rilevanti. Si cerca di focalizzare l’attenzione su ciò che riguarda concretamente i valori che sono in pericolo o che è possibile promuovere, e le azioni possibili.
Esplicitazione dei Valori in Gioco
Si ragiona sulle conseguenze delle varie azioni possibili nella situazione. Se è possibile tutelare tutti i valori simultaneamente, non vi è alcun conflitto. Altrimenti, le azioni vanno valutate in funzione dei valori che promuovono o compromettono.
Si può ragionare in termine di:
- Valori più alti: i valori morali vanno privilegiati rispetto ai valori non-morali, come citato in precedenza.
- Valori più fondamentali: ad esempio è più importante tutelare la vita che la salute.
- Valori più urgenti: ad esempio è possibile sacrificare il valore della legalità temporaneamente per proteggere il valore della vita in una situazione di immediato pericolo.
Formulazione della norma morale
A questo punto, si emette il giudizio pratico. Si esplicita cioè cosa va fatto nella data situazione, e si agisce di conseguenza.
Principi di Soluzione
Nel processo di giudizio morale, si può trovarsi in situazioni-limite, dove sembra impossibile trovare una soluzione moralmente corretta. Vi sono dei principi di natura teleologica, cioè orientati alla finalità della azione, che possono aiutare a discernere meglio se in un dato caso un comportamento od un male possono essere tollerati in favore di un altro.
Azione con Duplice Effetto
Possiamo trovarci di fronte ad una azione che abbia un duplice effetto, di cui uno negativo. In alcuni casi, una azione del genere è comunque consentita.
Supponiamo ad esempio il caso di spingere una persona per proiettarla fuori dal tragitto di un automobile impazzita e salvarla dall’urto. Spingere una persona, potenzialmente facendola cadere e causandole una ferita, potrebbe apparire in contrasto alla norma morale, tuttavia in questo caso la azione è chiaramente moralmente buona.
Vi sono quattro condizioni da rispettare perché la azione con un duplice effetto sia considerata permissibile:
- Comportamento corretto o moralmente irrilevante. Il comportamento in sé non può essere un male morale evidente.
- Atteggiamento buono. L’intenzione di chi commette l’atto deve essere di tutelare un valore. Ogni effetto negativo deve essere tollerato, non ricercato.
- L’effetto buono non deve derivare da quello cattivo. Non deve esserci un rapporto causale evidente tra l’effetto maligno, indesiderato, e l’effetto buono. Il fine non giustifica i mezzi: non è accettabile una azione che intenzionalmente e consapevolmente causa il male anche se da questo male dovesse derivare un bene.
- Proporzione tra effetti positivi ed effetti negativi. L’effetto negativo deve essere proporzionato a quello positivo. Se l’effetto negativo prevedibile è maggiore del bene che la azione intende di promuovere, allora la azione non è accettabile. Ancora una volta è necessario ragionare in termini di scala di valori tenendo conto di quanto descritto al capitolo precedente, alla sezione Esplicitazione dei Valori in Gioco. Non si può ridurre il ragionamento ad un puro calcolo utilitaristico.
Esempio
Immaginiamo la situazione di una donna incinta che scopra di avere un tumore che necessita un immediato trattamento farmacologico. Ritardare o evitare il trattamento causerebbe con certezza la morte della madre, tuttavia effettuare il trattamento potrebbe causare la morte del feto.
Come consideriamo il comportamento del medico che somministra il trattamento alla donna?
Il comportamento, fornire assistenza medica ad un malato è buono, così come l’atteggiamento, l’intento di tutelare la vita della donna: l’effetto associato, la morte del feto, non è in alcun modo voluto, ma tollerato e sofferto. L’effetto buono non deriva da quello cattivo: se il feto dovesse morire a seguito del trattamento, certo non si può dire che la madre è guarita perché il feto è deceduto. Non vi è correlazione causale tra i due effetti.
Infine, c’è proporzionalità tra i due effetti. In gioco vi è il valore della vita della donna, ed il valore della vita del feto: due valori comparabili.
Privilegio della Totalità
Il principio della totalità consente di sacrificare una parte in favore del tutto. Ad esempio, è tollerabile amputare un arto, violando il valore della integrità del corpo, qualora ciò sia finalizzato a salvare la vita alla persona.
Eccezione
L’eccezione è il caso-limite dove l’applicazione della norma produce disvalori più gravi dei valori che tutela; nel cui caso è consentita la non-applicazione della stessa o della norma contraria.
Due casi concreti:
- Legittima difesa. A causa di una aggressione non appare possibile preservare sia il valore della vita dell’aggressore che dell’aggredito. È lecito in questo caso interrompere la aggressione, anche, in estrema ratio, con l’ausilio di forza potenzialmente letale, purché:
- la situazione sia urgente – non sia dunque possibile preparare ed attuare un intervento mirato a neutralizzare il pericolo con il minor danno possibile, ad esempio coinvolgendo autorità addestrate. Di conseguenza l’aggressione deve essere in corso.
- la aggressione sia ingiusta: non si può considerare chiaramente legittima difesa di qualcuno che interviene a favore di un aggressore per proteggerlo dalla risposta dell’aggredito.
- deve esserci proporzionalità tra il male inferto per difendersi e il bene minacciato. Attenzione, il bene minacciato: non la minaccia in sé. La minaccia è spesso difficile da valutare – non è possibile sapere se un aggressore sia armato o intenzionato a uccidere – mentre è valutabile il bene minacciato. Ovviamente la forza letale è tollerabile solo se il bene minacciato è la vita, e non per esempio la ricchezza: non si può intervenire con forza potenzialmente letale su qualcuno che stia scassinando una cassaforte, ma si può farlo su qualcuno che stia aggredendo fisicamente una persona.
- Male minore. Quando il male è del tutto inevitabile, esso perde la qualifica di male morale, poiché usciamo dal campo della libertà. In questo caso, è legittima la azione che si propone di ridurre il male risultante dalla situazione.
Ogni situazione del genere è chiaramente molto delicata e difficile da valutare con un principio eccessivamente generalizzato.
Principio di Epichèia
L’epichèia (dal greco, sensato, equo, ragionevole) è il principio secondo cui, per risolvere una situazione nuova di cui non si abbia esplicita soluzione nella norma morale, si ricorre a cercare di interpretare l’intento profondo del legislatore, ad esplicitare la situazione in corso secondo valori che il legislatore intendeva tutelare quando ha legiferato, e che per questa specifica situazione non sembrano normati.
Per il cristiano, questo principio si può forse ancora una volta riassumere nel duplice comandamento dell’amore già citato in precedenza.
Conclusione
Con l’occasione di condividere con voi questi appunti, desidero ringraziare ancora Don Mattia Francescon dell’opportunità di questo corso.
Il ragionamento etico, quantomeno nella cultura popolare, ma in verità anche fra buona parte degli intellettuali, è oggigiorno praticamente schizofrenico. La nostra società è rapida e perentoria nell’emettere giudizi, anche drammatici, nei confronti di chiunque non si conformi alla vulgata, al sentire comune, alle esigenze della cultura. Eppure, d’altra parte, quando si tratta di confrontarsi con una pretesa morale contro-culturale, specie nell’ambito delle relazioni sentimentali, il discorso si fa immediatamente balbuziente ed insensato: si obietta che non può esistere una morale buona per tutti, riciclando i vecchi slogan sessantottini del vietato vietare.
È importante più che mai riportare un discorso morale serio e coerente nel sentire e nel parlare comune.
Dal mio punto di vista, è impensabile che qualsiasi pensiero non credente possa farsi carico di questo: semplicemente perché qualsiasi pensiero non credente che sia coerente con se stesso non può che terminare in un nichilistico vuoto morale. La legge è tale se vi è una Autorità che possa esigerne il rispetto; altrimenti, semplicemente non è legge: e questo è tradizionalmente uno dei ruoli di Dio.
Tuttavia la conoscenza ed il rispetto di una struttura morale solida sono anch’essi una forma concreta di testimonianza, specie di fronte ad un mondo che in questo ambito non ha nulla di significativo da offrire.
Optatam totius n. 16
Si ponga speciale cura nel perfezionare la teologia morale, in modo che la sua esposizione scientifica, più nutrita della dottrina della sacra Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo.
Spero che questi appunti, che ho redatto nel mio processo di studio, possano esservi utili proprio a questo fine.
Articoli Correlati
Appunti di Teologia Morale – La Coscienza
La terza parte dei miei appunti di Teologia Morale. In questa parte parleremo della coscienza umana, luogo dove ciascuno vive…
Appunti di Teologia Morale – La Bibbia e la Norma
La seconda parte dei miei appunti di Teologia Morale. In questa parte parleremo di etica nel raccondo biblico e di…
Appunti di Teologia Morale – Introduzione
Ecco la prima parte dei miei appunti di Teologia Morale Fondamentale. Introdurremo la riflessione morale in genere….
Un Corso di Teologia Morale
Ho partecipato ad un corso di introduzione alla Teologia Morale Fondamentale. Vi racconto come è andata, e condivido con voi…

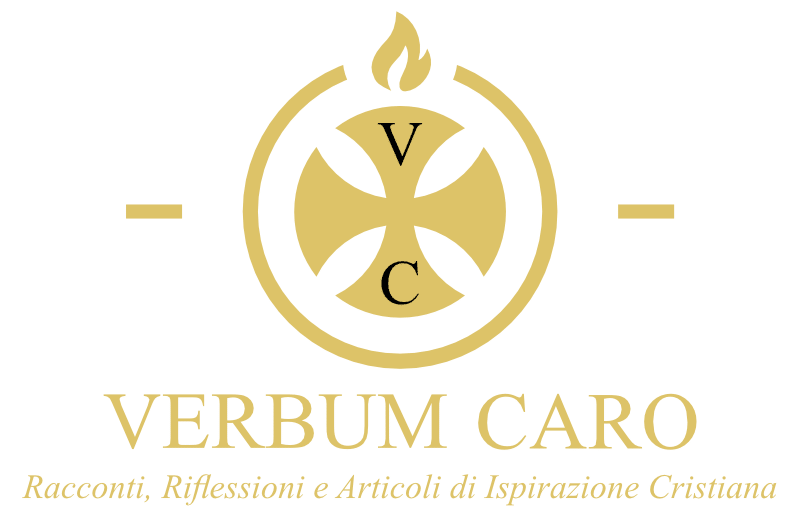


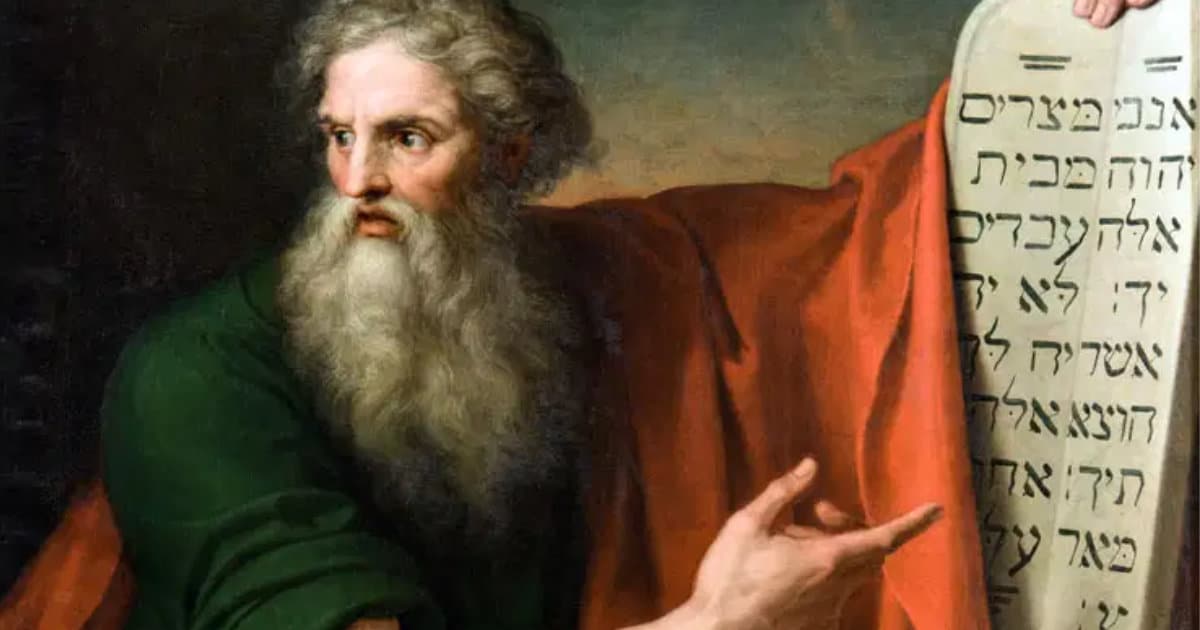


Lascia un commento